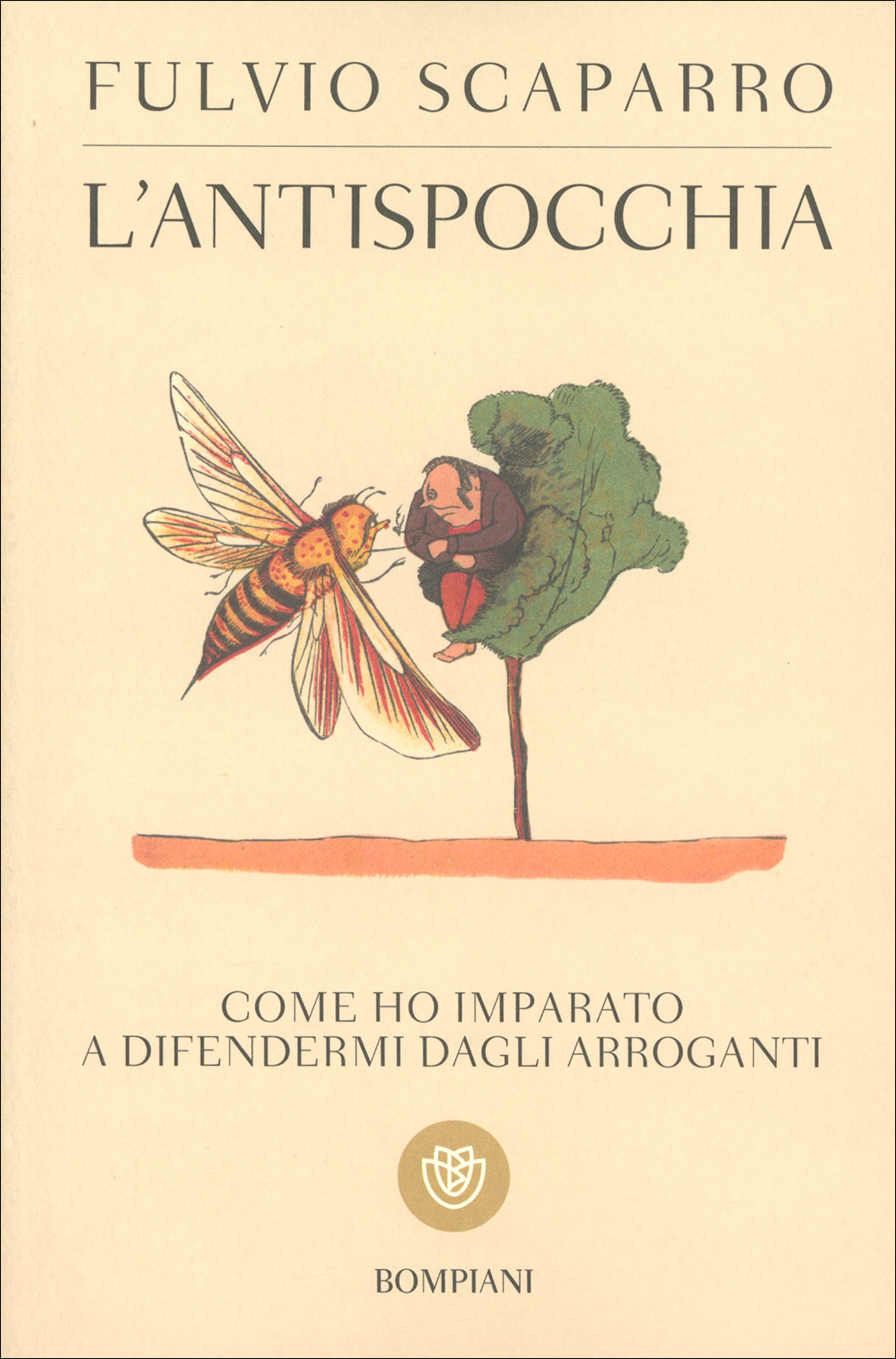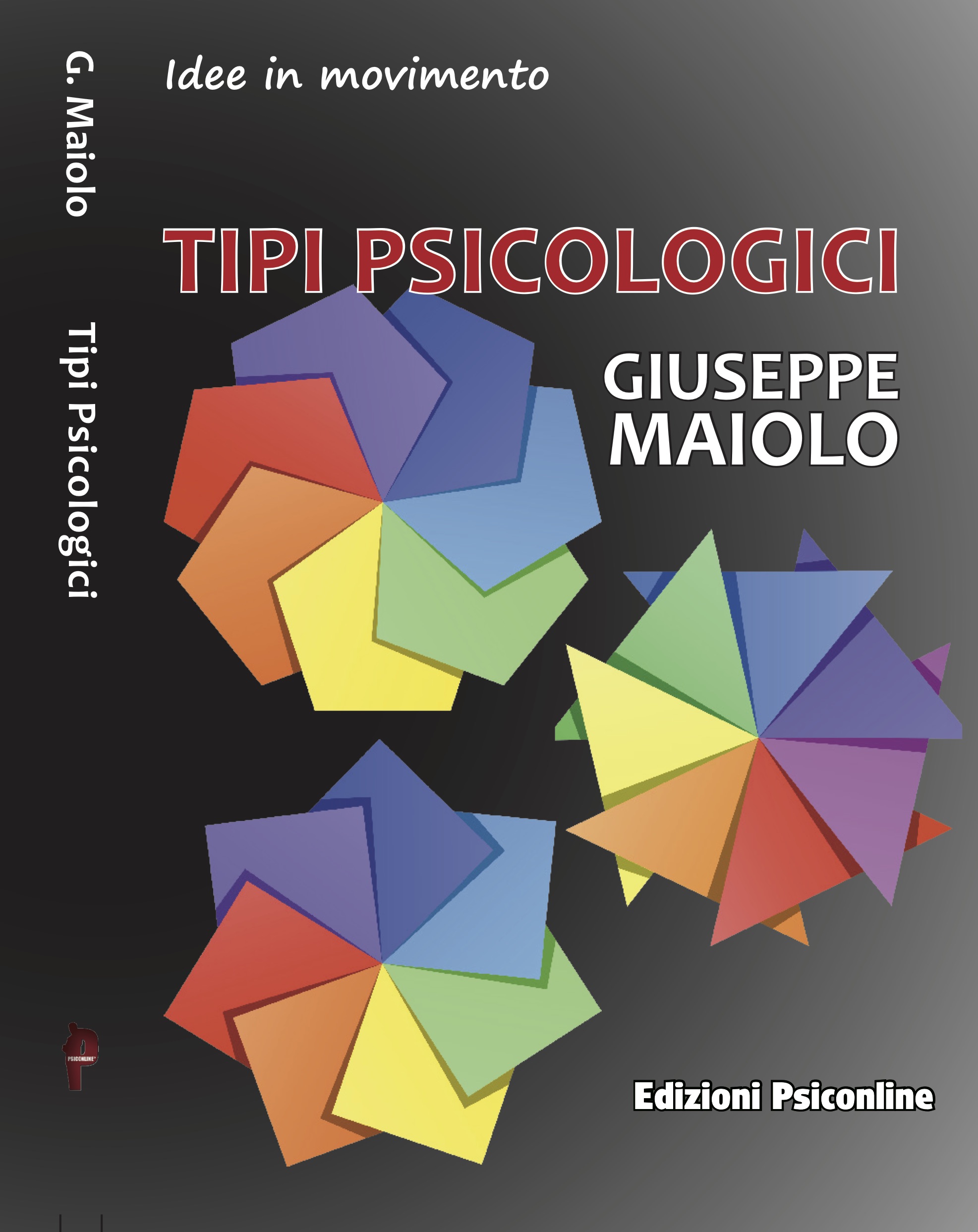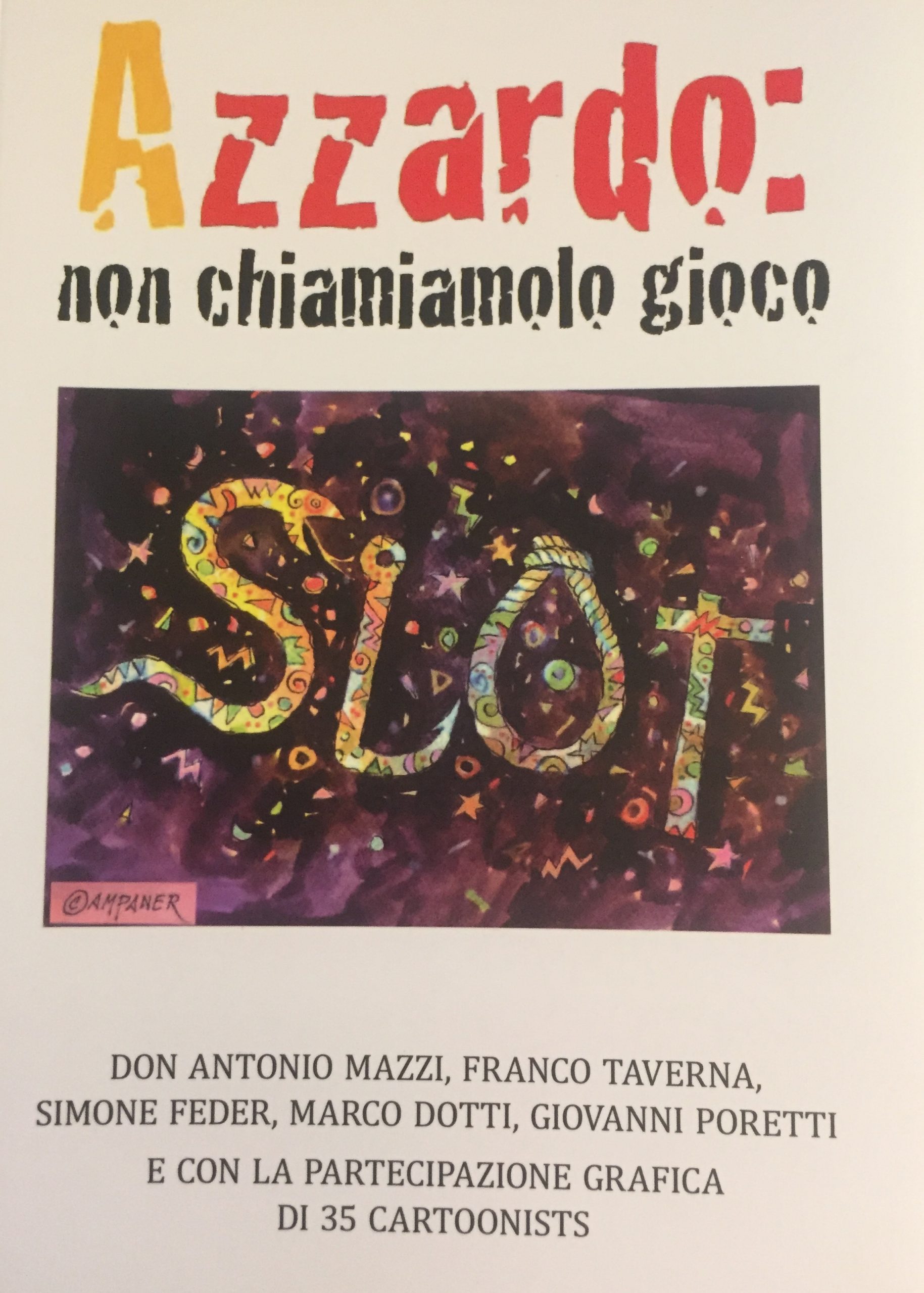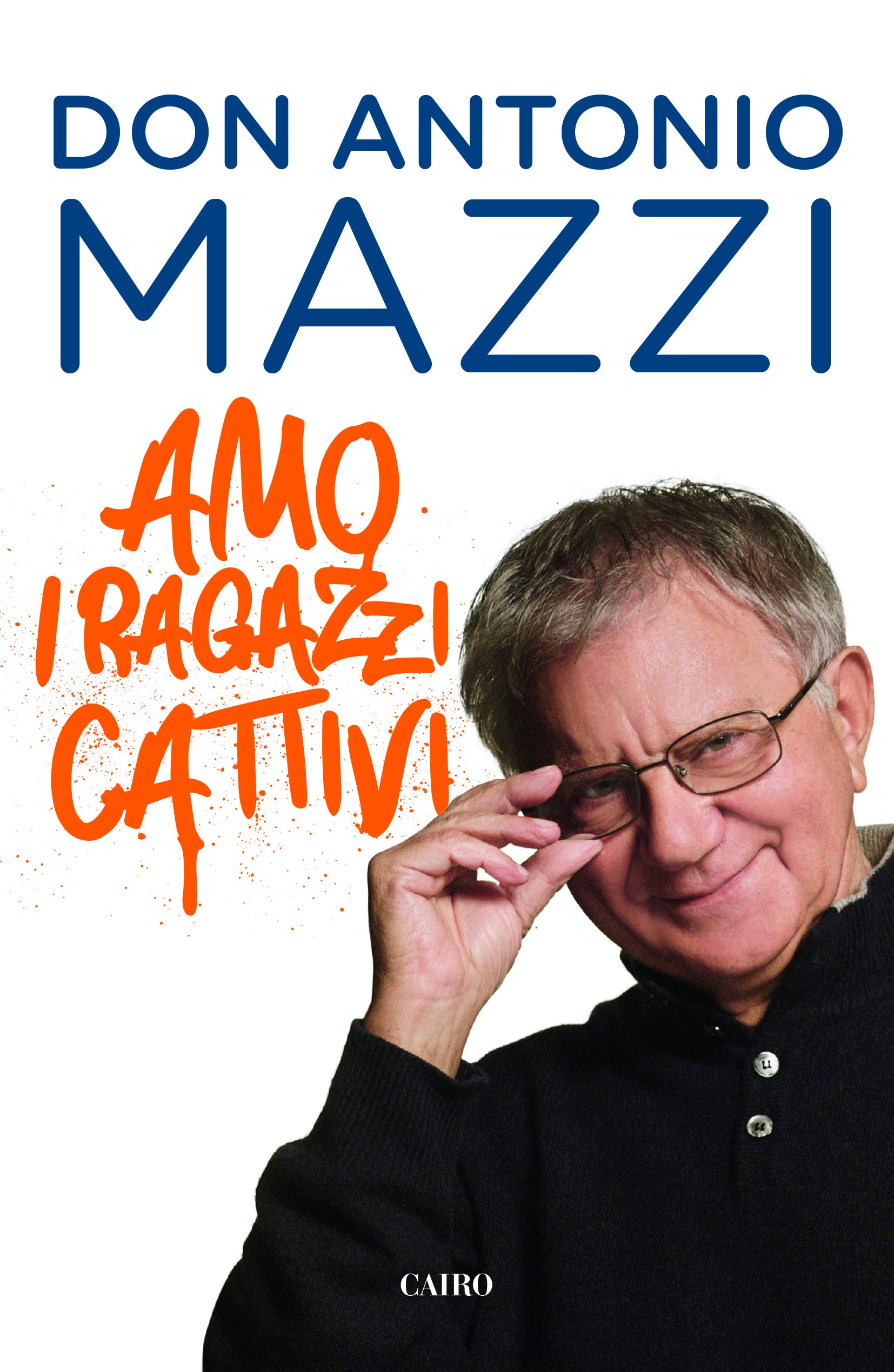Sono figlia di un panettiere. Da piccola sentivo mio padre che si alzava la notte per scendere in forno a fare il pane. Al mio risveglio c’era sempre un profumo di pane fresco e allora scendevo anch’io le scale che dal secondo piano portavano al forno, scalza, in punta di piedi, piano piano e lo vedevo tutto infarinato e stanco a cuocere le michette, quel famoso pane di noi milanesi polentoni, che regolarmente rubavo, calde e croccanti. I miei occhi di bambina si stupivano davanti alle creazioni: i filoncini, i ferraresi, il biove, le ciabatte, le michette. Tutto a farina bianca. Allora le farine ricercate quelle di segale, integrali, non c’erano.
I giorni in negozio erano per me meravigliosi. Tutti venivano a comprare il pane fatto da papà. Mia madre dietro il banco, metteva il pane nei sacchetti di carta, quelli marroni, grandi e piccoli a seconda della quantità di pane. Alcuni pagavano alla casa, alcuni segnavano su un libricino che mia madre teneva gelosamente custodito in un cassetto sotto la cassa. “Maria… metti in conto… sabato vengo a pagare”. E cosi succedeva, sempre, sempre. Il buon nome, la lealtà, l’onestà prevalevano sempre. Non si doveva mai rincorrere nessuno. In quel piccolo negozietto Despar sull’angolo di 4 strade, c’è il Nino e la Maria. Una certezza per quel pezzo di paese oltre la ferrovia dove regnavano i campi e null’altro.
Sono cresciuta con l’odore del pane. Poi ad un certo punto ho cominciato a farlo anche io. Con i mezzi casalinghi di cui disponevo.I primi risultati sono stati disastrosi, troppa acqua, troppa farina, il sale non c’era, il lievito non aveva funzionato. Tentativi maldestri per ottenere risultati fallimentari.
Ma ogni volta mettere le mani nella farina mi fa sentire ancora quel profumo e se chiudo gli occhi lo vedo là… alto, imponente, infarinato. Ci vuole tempo per fare il pane. In questo tempo sospeso si ha l’impressione di perderlo questo tempo, di non realizzare sogni e progetti, di farsi scappare via le occasioni e di non avere la forza necessaria poi per poter ripartire.
Allora, provo a mettere le mani in pasta. Provo a cucinare il pane come si faceva una volta.Impasto il pane e lo faccio lievitare due lunghi giorni e due lunghe notti. E’ il momento della lievitazione lenta, quella che ti fa prendere cura del cibo che cucini. Uso le mani, usa il lievito buono, Faccio lievitare l’impasto per giorni interi, non solo per ore. E in questo tempo di lunga attesa e cura, anche se non sembra accadere nulla, in realtà sta avvenendo un incredibile cambiamento. Nell’impasto e dentro di me. Imparo a prendermi cura del mio pane quotidiano, imparo a prendermi cura di ciò che nutre davvero la mia anima. E tutto accadrà. Come per magia.
In questo mondo veloce prepariamo in fretta gli ingredienti e vogliamo che il pane sia pronto il prima possibile. Ma lo conosco il sapore e il profumo del pane lievitato lentamente. E’ un sapore diverso, genuino, quasi sacro. Mentre aspetto il mio pane che lievita mi metto in connessione con il mio pane: lo guardo, lo sento, lo curo. Ecco: questo è il momento della lievitazione lenta. Ho già preparato gli ingredienti, ho già impastato. MI faccio da parte e mi gusto il meraviglioso spettacolo di questa trasformazione che sta avvenendo anche dentro di te.
 E poi la pazienza per provare e riprovare, leggere il tempo, sapere il prima e presupporre il dopo.E poi le giuste dosi perché troppa acqua rende liquido, poca acqua impossibile da impastare. Troppo sale rende salato, poco sale insipido. Troppo lievito non fa lievitare e il lievito a contatto con il sale annulla la lievitazione
E poi la pazienza per provare e riprovare, leggere il tempo, sapere il prima e presupporre il dopo.E poi le giuste dosi perché troppa acqua rende liquido, poca acqua impossibile da impastare. Troppo sale rende salato, poco sale insipido. Troppo lievito non fa lievitare e il lievito a contatto con il sale annulla la lievitazione
E poi impastare con le mani calde a contatto con il composto, dita agili e libere, in un connubio occhio mano dove l’occhio vede e guida. Impasto con movimenti lenti e importanti in modo che tutto trovi compimento uno nell’altro, andando a prendere chi ancora è rimasto fuori, quel piccolo sbuffo di farina che scappa dalle mani impetuose per rende l’impasto morbido, elastico non appiccicoso.