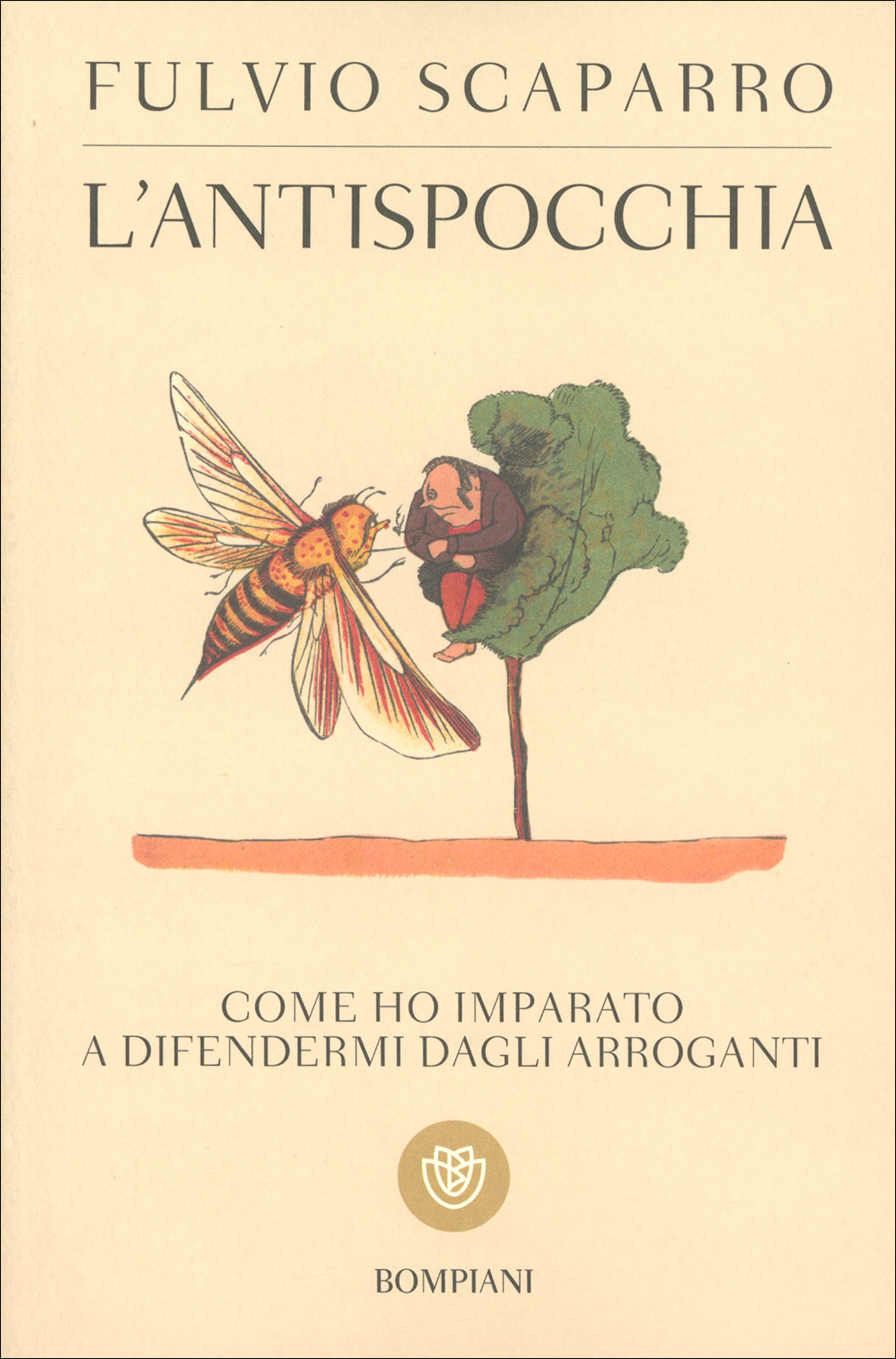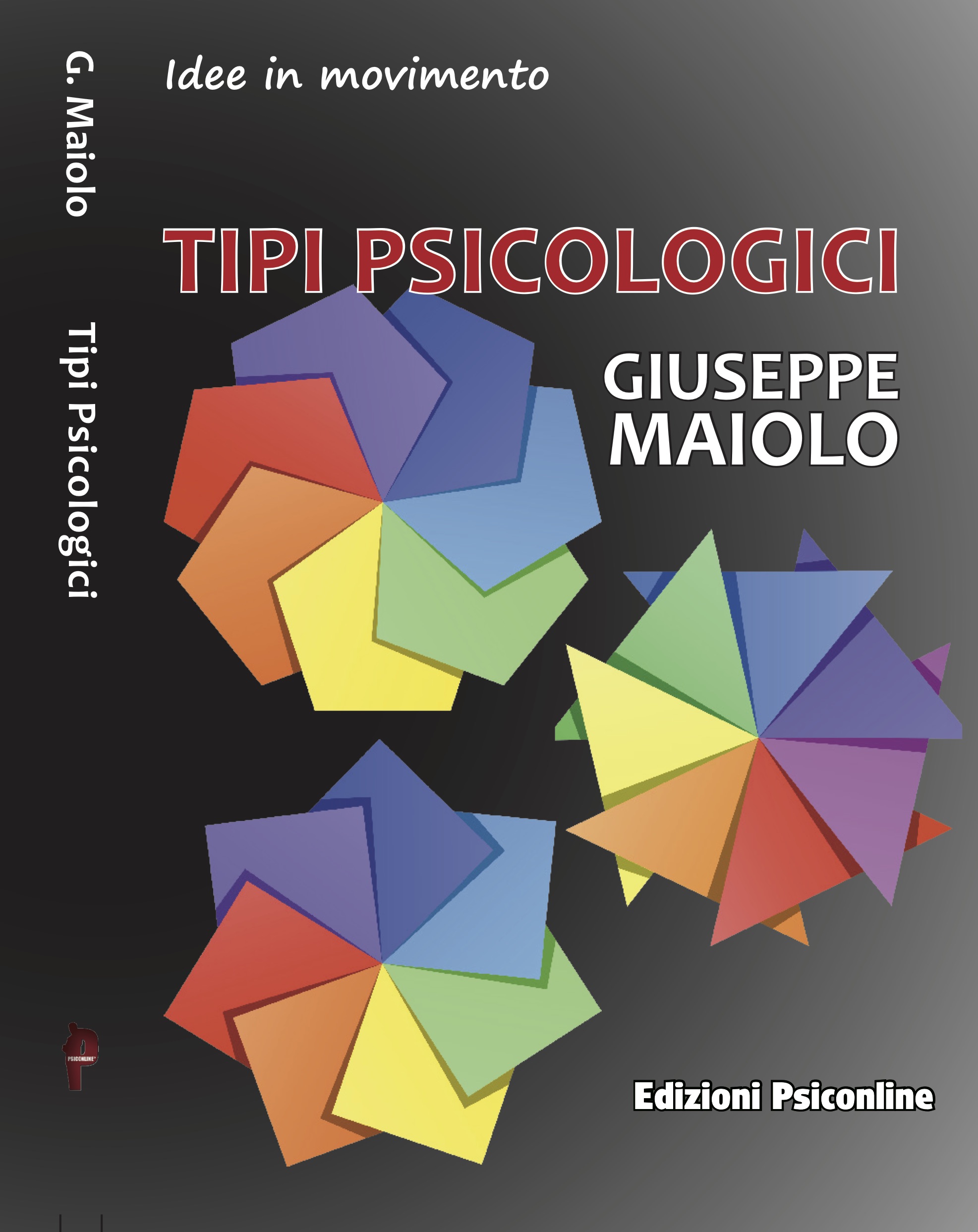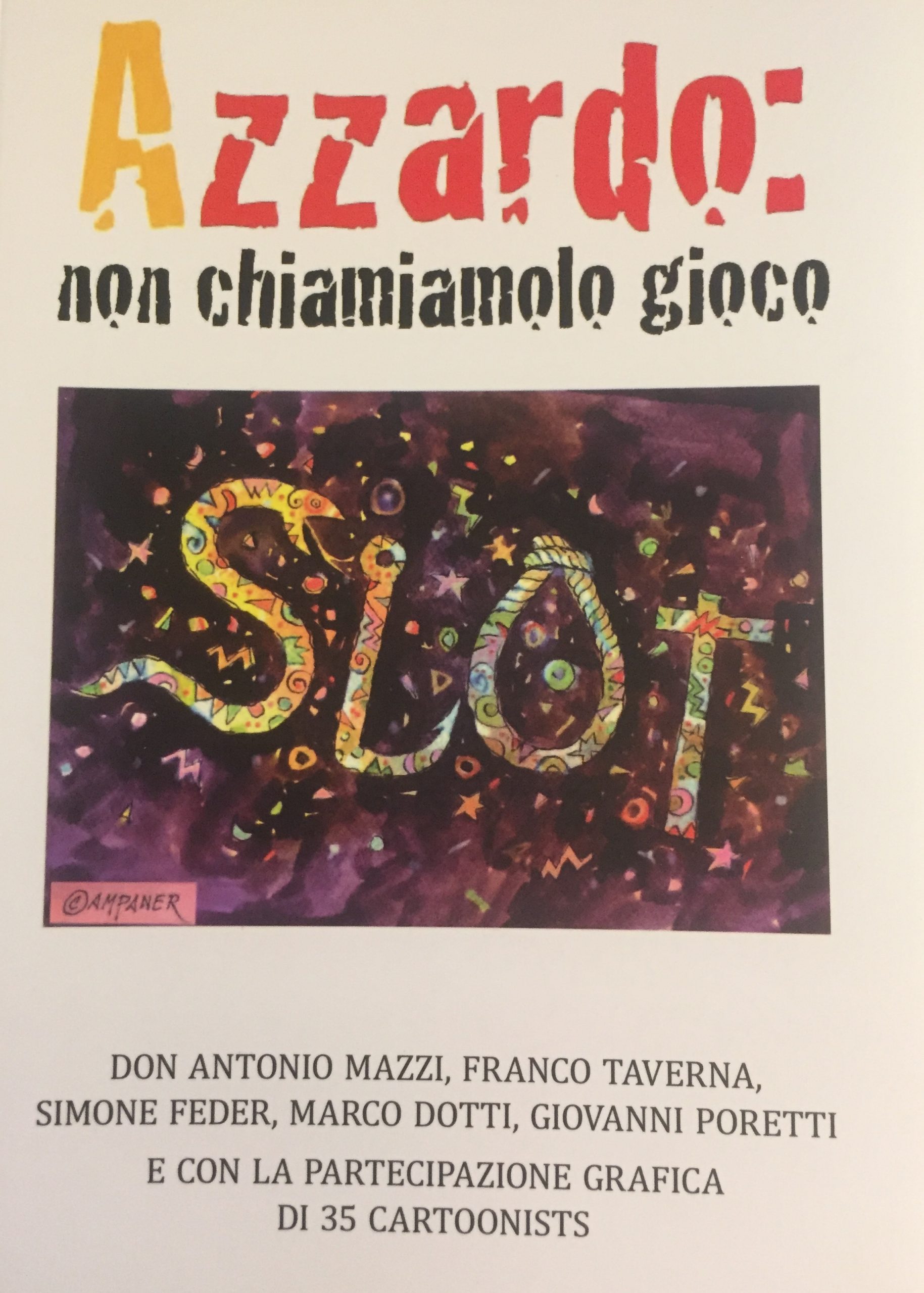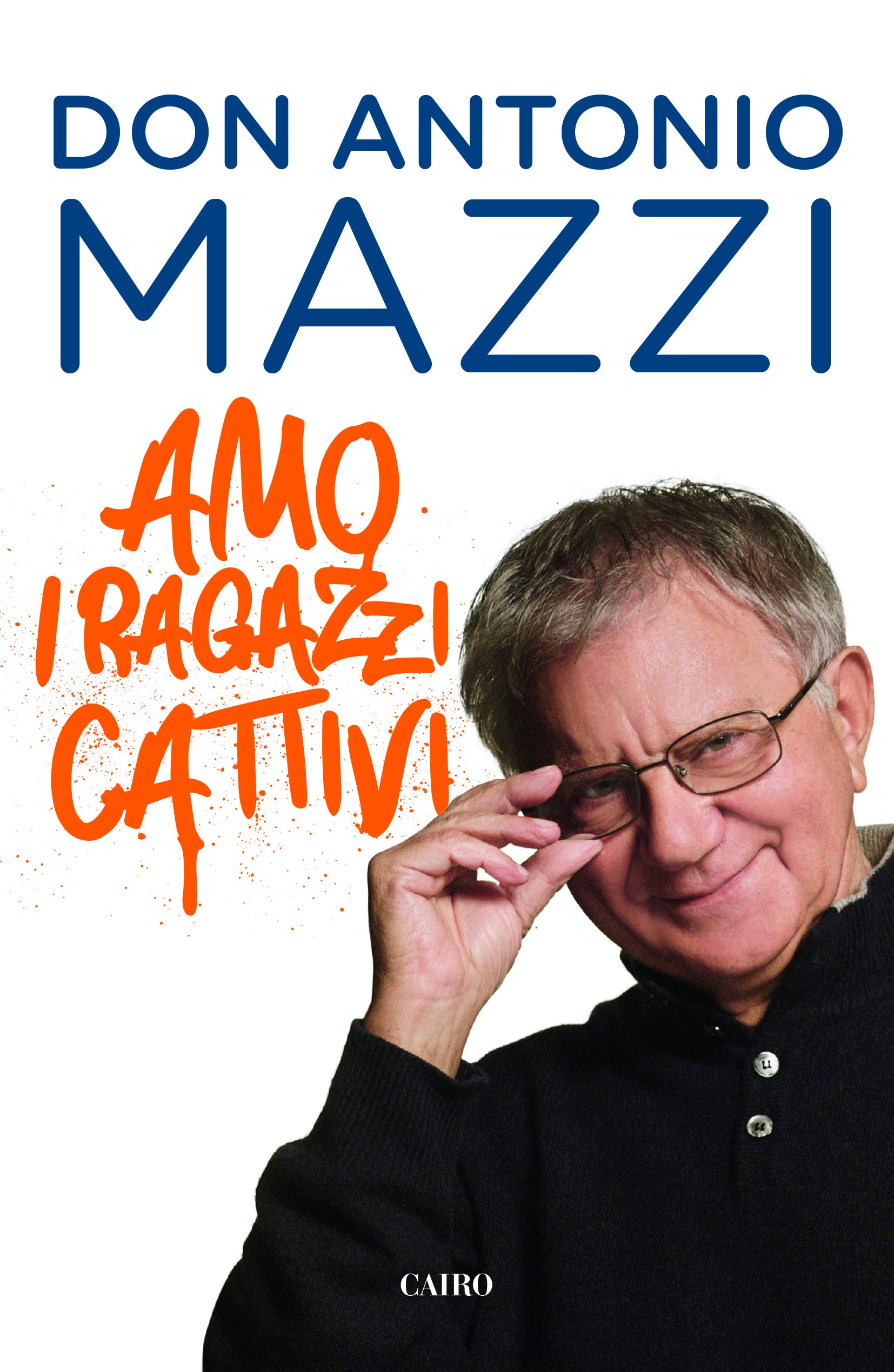Dall’odio alla vendetta, il passo può essere breve, perché entrambe sono passioni confinanti e potenti. “Sì, vendetta, tremenda vendetta!” infuria il Rigoletto di Verdi, insensibile e inabile al perdono.
Dice Erich Fromm, psicoanalista, “La vendetta è una passione talmente radicata in profondità, da essere sicuramente presente in tutti gli uomini” (Anatomia della distruttività umana, Mondadori) e corrisponde al desiderio di rivalsa per i torti subiti e al bisogno di pareggiare i conti.
Più di tutto è pulsione incontenibile che, anche quando non viene agita, rimane come fantasia di un bisogno tutto umano di risarcimento e, se vogliamo, attesa di qualcosa che prima o poi arriverà per ricompensare un dolore patito a lungo. In questo caso la vendetta è anche un pensiero legittimo, utile sul piano psicologico perché può aiutare a contenere una sofferenza mentale che genera sfiducia, rabbia e rancore, soprattutto quando non si raggiunge la dimensione del perdono. Che è l’unica forza risanatrice ma difficile da conquistare.
Dietro a ogni desiderio vendicativo, del resto, c’è sempre la convinzione che far pagare all’altro lo stesso dolore subito possa servire ad azzerare i conti e permetta a chi è stato offeso di ritrovare un nuovo equilibrio psicologico.
Una specie di consolazione, insomma, ma che contiene il rischio di diventare un’ossessione potente in cui i pensieri vendicativi non fanno stare meglio ma allagano la mente e alimentano fantasie antiche di “giustizia fai da te” le cui radici affondano nella terribile legge del taglione: “Occhio per occhio, dente per dente”.
La vendetta, ovvero quel desiderio implacabile di “fargliela pagare” spesso fa vivere in funzione di questo obiettivo ma in realtà non pareggia nulla e non elimina la sofferenza. Anche la stessa amputazione è solo un’illusoria compensazione che non cancella le offese né ripara il danno nei territori dell’anima. Non appaga e non gratifica, è solo ri-sentimento che come un cancro si espande per traiettorie indefinite e porta allo scoperto un lamentoso dolore per i maltrattamenti rimasti impuniti.
Una vendicatività inseguita di solito con rigidezza e crudeltà che non contiene un’idea di pacificazione interiore, tantomeno il perdono. E nemmeno funziona come “piatto freddo” servito a distanza di tempo perché rimane un malessere devastante di chi medita il male e alimenta dentro di sé un’infinita ruminazione mentale che non trasforma nulla e nessuno.
In questo modo la pace rimane un’illusione, per lo meno fino a quando restano conti in sospeso e la vendetta rimane ferita sanguinante da cui sgorga l’idea ossessiva del risarcimento, senza alcuna elaborazione dei traumi subiti.
Anche quando il “castigo” da infliggere sembra giustifichi la punizione violenta di chi ha commesso errori e ha usato violenza, la vendetta non ripara il danno individuale o collettivo e non assolve la coscienza.
Serve piuttosto un processo di pacificazione interiore personale e comune da costruire insieme e necessita un’educazione collettiva al perdono. Forse per cominciare si potrebbe accogliere quel verso di Alda Merini che dice: “La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.”