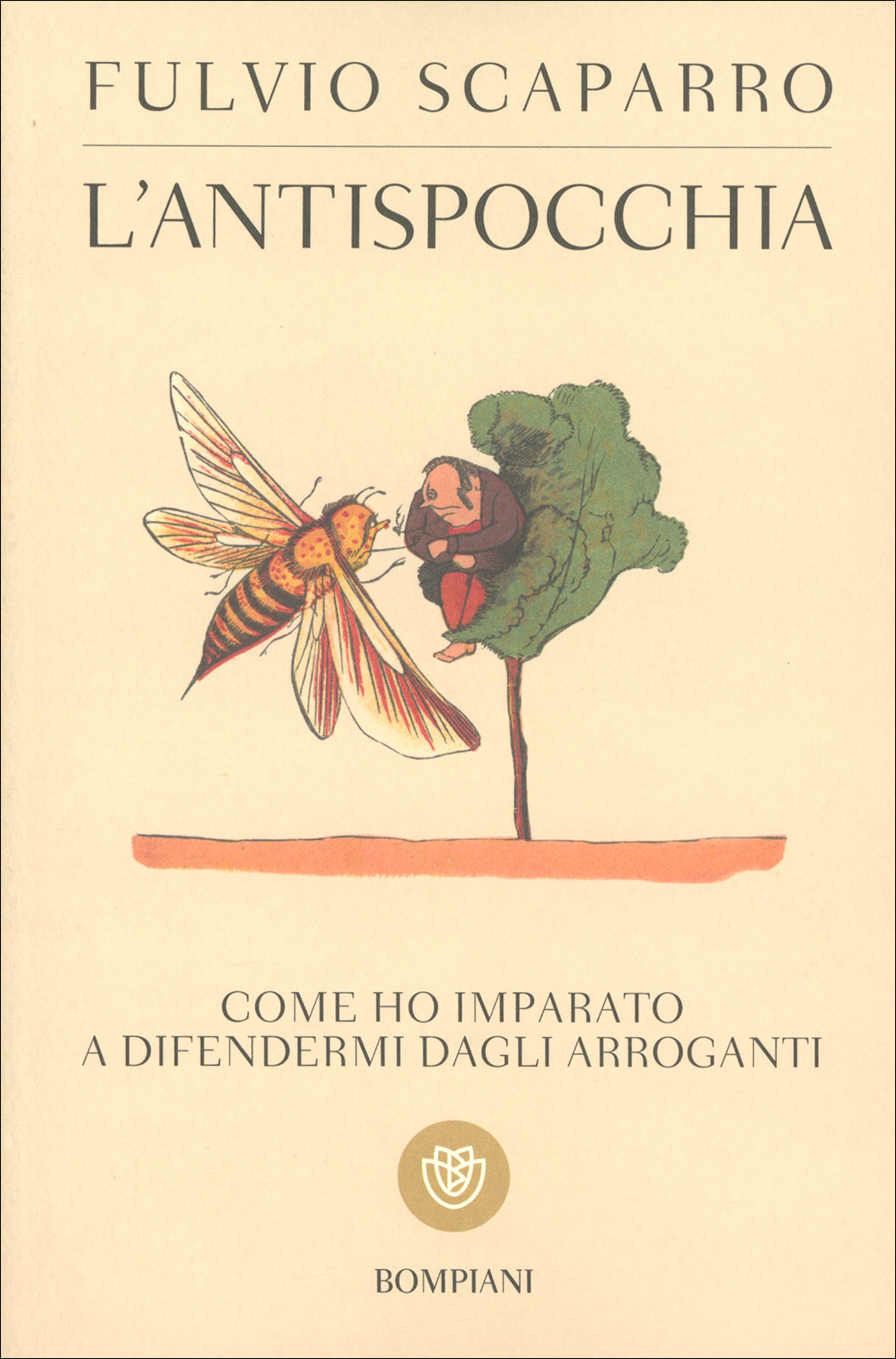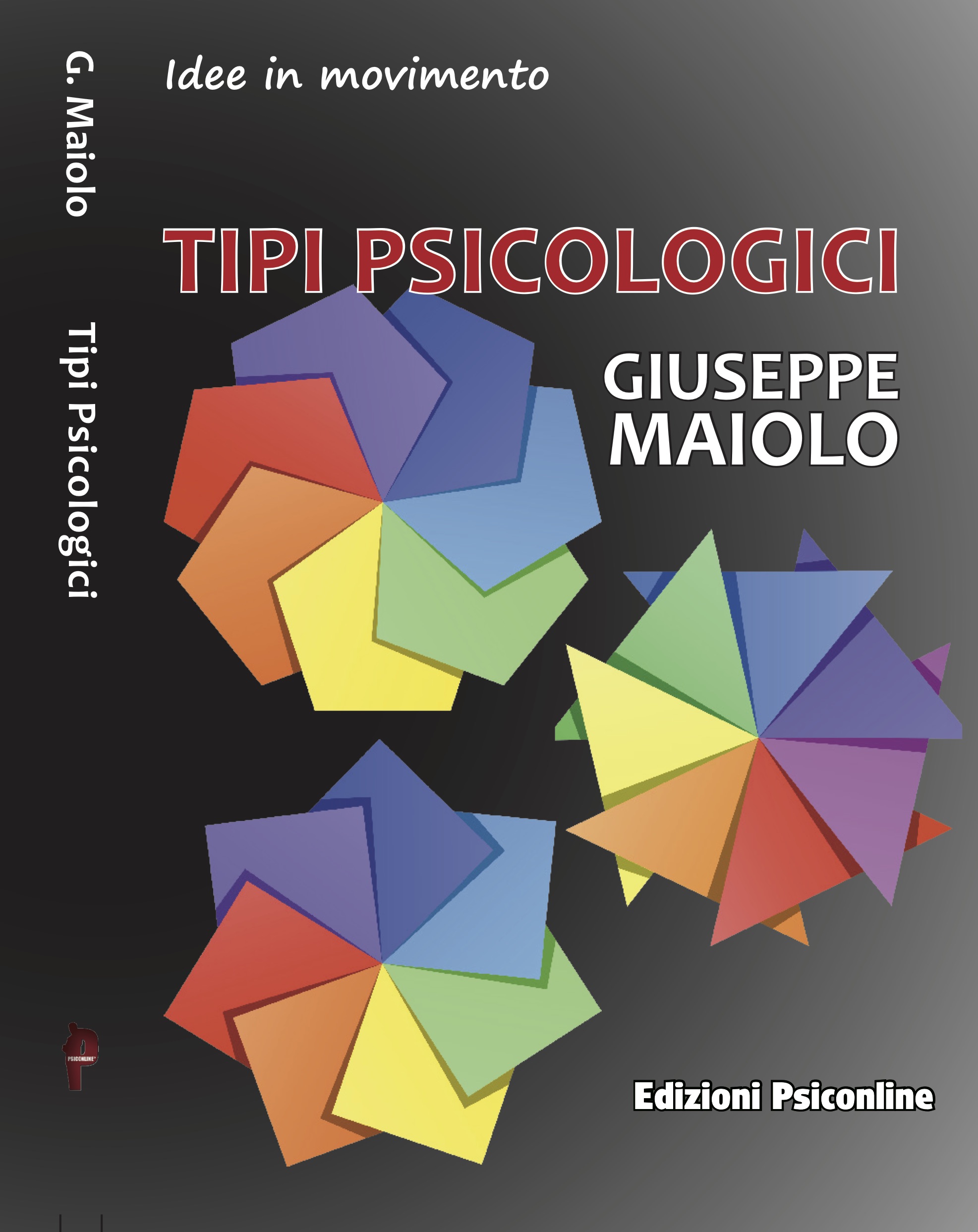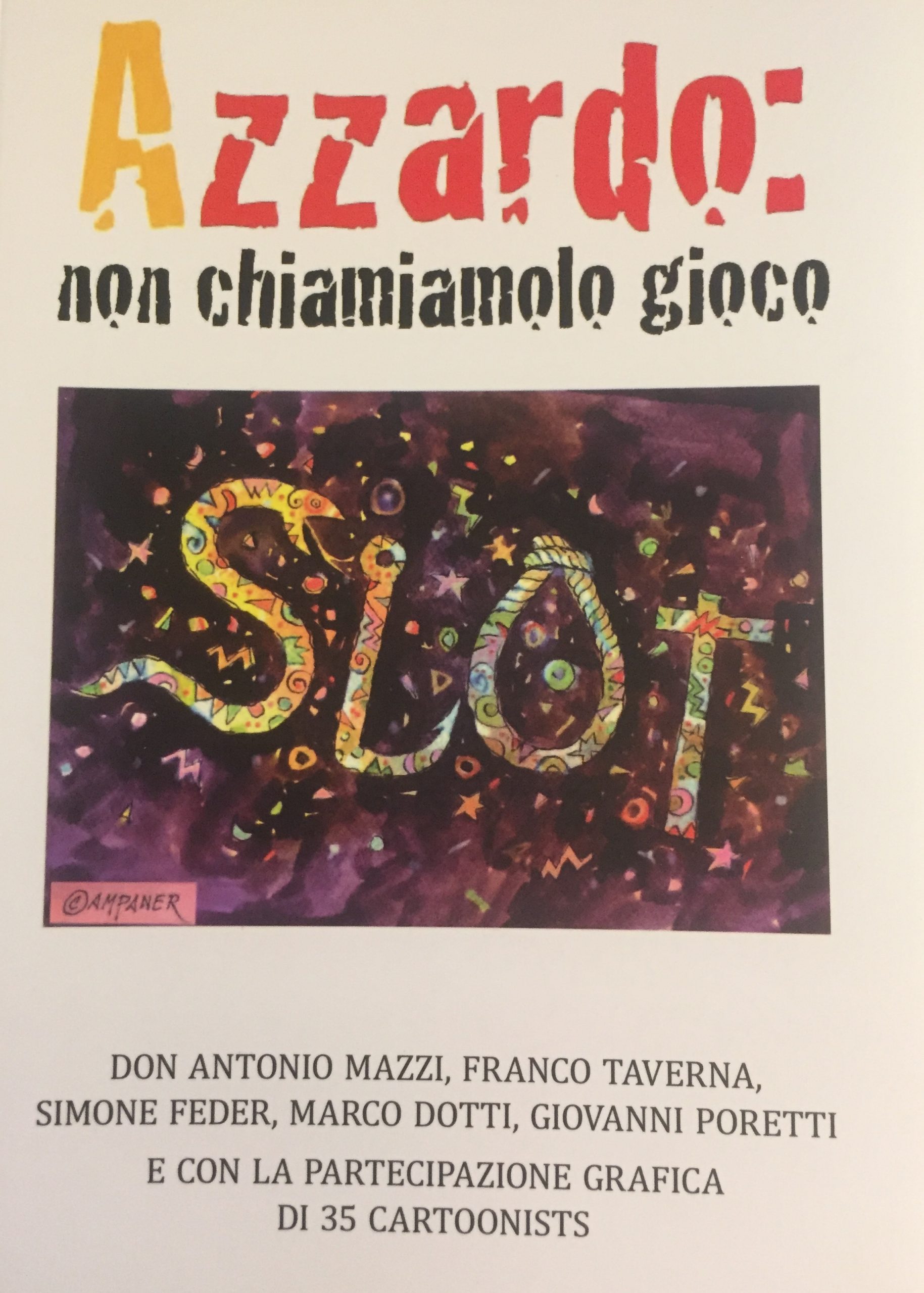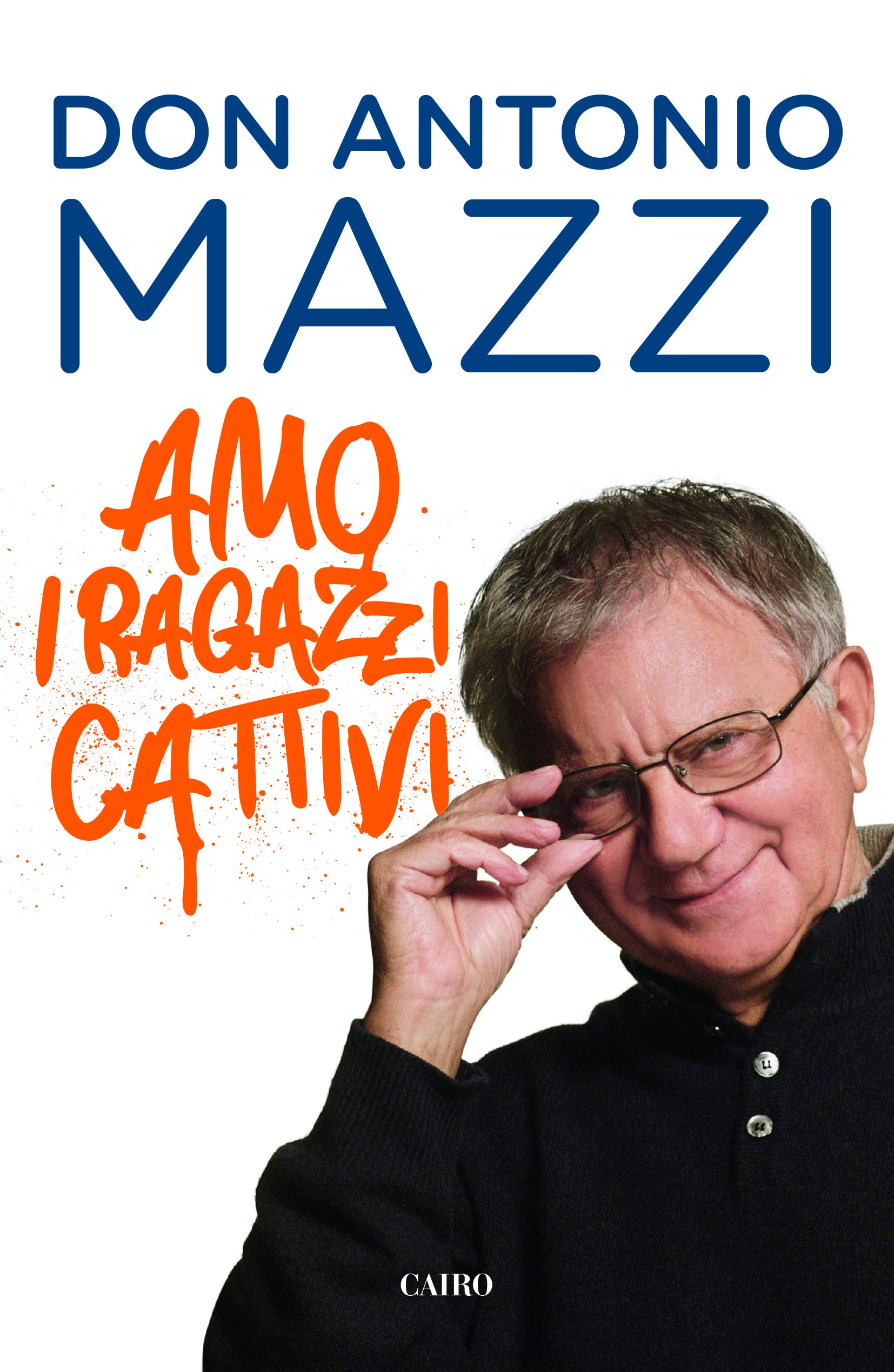Questo intervento vuole raccontare, partendo da una esperienza diretta, quale prospettiva può esserci per una indicazione psicoterapica all’interno di un più vasto progetto di recupero e sviluppo di soggetti in fuga da un passato inaccettabile ed alla ricerca di nuove terre. Al tempo stesso vorrei provare a sottolineare quegli elementi che trascendono il singolo caso, la singola situazione, e che possiamo pensare di riscontrare in situazioni analoghe. Come psicoterapeuta ho ben chiaro che, da un certo punto di vista ogni individuo è un mondo a sé, ma ho altrettanto chiaro che alcuni elementi, alcuni vissuti, li ritroveremo come costanti di determinate situazioni.
La ragazza del clan
Anna, così la chiameremo, è una ragazza appena maggiorenne proveniente da una famiglia con significativi problemi collegati ad attività criminali. Anna viene allontanata dalla famiglia ancora ragazzina e affidata dapprima ad una comunità, in seguito a famiglie affidatarie. Insomma vengono attivate tutte quelle risorse che in situazioni di questo tipo vengono messe in campo dalle istituzioni, risorse nei confronti delle quali la ragazza si manifesta fortemente ambivalente e rifiutante.

Di fatto è un sacerdote che segue da vicino la sua situazione a contattarmi per chiedermi se avevo tempo e disponibilità per pensare ad una psicoterapia con Anna che lamentava di avere bisogno di essere aiutata.
Risposi che non vedevo il motivo per dire di no, e che desse pure a questa ragazza il numero di telefono del mio studio. E’ questo, a mio parere, il primo aspetto che ritengo fondamentale sottolineare, se vogliamo trasformare una esperienza di questo tipo in un eventuale progetto. Istintivamente avevo trattato Anna come tratto chiunque si affacci al mio studio per chiedere un aiuto e questo elemento tornerà spesso nel corso della psicoterapia con me.
Anna era per me una ragazza che chiedeva un aiuto, non era la vittima sacrificale di una situazione insostenibile, intendo dire che pur avendo ben chiaro quale fosse il suo background, la sua storia personale, il sacerdote mi aveva messo al corrente della storia famigliare, avevo comunque pensato che fosse importante riconoscere al suo dolore una dimensione individuale. Ovvero Anna non era solo la sua famiglia ma era anche e soprattutto un individuo.
(Mi accorgo adesso mentre lo scrivo che “individuo” è l’antitesi dl clan, e che su questa antitesi si sarebbero sviluppate buona parte delle nostre sedute.) In realtà tutto questo tornerà sotto forma del suo negativo.
Dalla consultazione alla terapia
Cerco di spiegarmi meglio. Anna, cosa che non sapevo, aveva già avuto esperienze di sostegno psicologico, almeno due esperienze che l’avevano lasciata profondamente delusa ed amareggiata, (in realtà proprio perché si era sentita al tempo stesso giudicata e compatita) esperienze nelle quali non si era sentita presa in considerazione in quanto soggetto attivo della sua vita, ma in quanto vittima di una situazione che non dipendeva da lei e che la sovrastava.
Terminati i colloqui di consultazione decisi di proporle una psicoterapia psicoanalitica a cadenza settimanale e che sarebbe durata 8 mesi da marzo a novembre. Fissammo da subito la data di conclusione.
Questo modello psicoterapico presentava alcune caratteristiche che, a mio parere, bene si adattavano alla situazione clinica in atto, permettevano ad Anna di avvicinarsi senza eccessiva paura, e al tempo stesso riportavano alla luce i vissuti collegati alle esperienze di perdita e separazione. Vissuti che nel suo caso erano l’asse portante della sua sofferenza.
Non credo sia così facile crescere con un padre in carcere. Perdonatemi la brutalità ma come avrei potuto pensare che Anna potesse da subito fidarsi di me se le persone per lei più importanti l’avevano lasciata per andare in carcere. Terminata la fase di consultazione decidiamo di cominciare la psicoterapia vera e propria.

Anna e il tradimento
I primi mesi furono caratterizzati dal fantasma del tradimento. Anna spesso si guardava intorno, guardinga, come se temesse di essere registrata, si diceva certa che io parlassi di lei con il sacerdote che me l’aveva inviata. Insomma io ero la longa mano di chi voleva aiutarla, e fu questo il primo ostacolo da affrontare con Anna, lei era lì perché altri volevano che lei fosse lì, era come se non fosse lei ad avere chiesto un aiuto per sé. In questa prima fase era come se i suoi affetti fossero congelati.
In realtà questa componente persecutoria, che almeno all’inizio era marcata, era presente in tutte le sue relazioni affettive significative. Aveva vere e proprie esplosioni di gelosia nei confronti del fidanzato e della madre e parlava di questa sua esplosività sottolineando come adesso fosse mitigata rispetto a quando era adolescente. Alternava a questi momenti di rabbia autentici, momenti depressivi nei quali tutto perdeva significato. Mi sembrava del tutto evidente come Anna stesse riproponendo nella relazione terapeutica con me, ovverosia nel transfert, l’evento traumatico originario, il tradimento. Io l’avrei tradita, avrei inevitabilmente tradito la sua fiducia, così come avevano fatto e stavano facendo tutti.
Divenne a questo punto possibile farle notare che era vero, lei era stata tradita, la sua fiducia originaria era stata tradita dai suoi genitori che, a causa di comportamenti criminali, non avevano potuto adempiere adeguatamente alla funzione genitoriale, ovvero quella di prendersi cura dei propri figli.
E’ questo un secondo punto che credo potremmo riscontrare nella maggioranza di queste situazioni, l’essere stati traditi dalle figure genitoriali che si sottraggono così al loro compito. Soffermiamoci un momento e proviamo a pensare a quale può essere il dramma di un bambino che perde il genitore a seguito di un comportamento criminale, badate che non sto parlando dei figli delle vittime, a questi almeno resta la rabbia e l’odio per l’ingiusta perdita subita, la possibilità di idealizzare il genitore perduto e la possibilità di elaborare questo lutto, sto parlando di chi vede il proprio mondo crollare proprio a causa di coloro su cui aveva riposto tutta la fiducia. Se ci soffermiamo un momento credo possiamo renderci conto di quanto questo debba essere difficile.
Kindertransporter. I bambini affidati
Permettetemi di divagare pochi minuti e di poter ampliare questo concetto, che ritengo fondamentale per comprendere appieno quello che accade in certe situazioni, per fare questo voglio parlarvi, sia pure in modo assolutamente sintetico dei Kindertransporter. La traduzione dal tedesco è facilmente intuibile, Kindertransporter letteralmente “il trasporto dei bambini”. Dopo la “notte dei cristalli” tra il 9 e il 10 novembre 1938, quando esplose in Germania la caccia all’ebreo il governo inglese accettò di dare protezione, di accogliere sul proprio territorio i bambini ebrei che venivano così messi in salvo dai loro genitori. Si badi bene solo i bambini, non anche i genitori e in questa sede non ci interessa sapere il perché ma solo sottolineare questo fatto, i bambini erano separati dai genitori, questi bambini erano così accolti in famiglie disponibili, (una sorta di famiglie affidatarie ante-litteram), oppure in istituzioni prevalentemente religiose (le comunità terapeutiche dell’epoca). Questa situazione pur con le dovute differenze mi ricordava la situazione di Anna, o almeno come era da lei vissuta l’essere trasportata in altre terre e in altre famiglie.

Ma la cosa sulla quale voglio richiamare la vostra attenzione è come i Kindertransporter vissero il fatto che i loro genitori li avessero messi in salvo di là della manica, ebbene anche se può apparire strano, il sentimento prevalente fu di sentirsi in colpa per essere stati abbandonati, come se l’abbandono non fosse stato dovuto al pericolo reale rappresentato dal nazismo, ma fosse da ricercare in qualcosa che loro avevano fatto. La maggioranza di loro non riuscì ad affrontare, una volta diventati adulti, il trauma subìto con i propri figli e poterono farlo solo con i nipoti.
Un’ultima cosa se pensate che fossero pochi sappiate che si calcola che furono circa diecimila.
Non voglio dilungarmi inutilmente voglio però richiamare la vostra attenzione su una domanda che credo drammaticamente inevitabile se vogliamo occuparci di chi fugge dalla mafia. Se questo è il vissuto di un bambino che viene messo in salvo da genitori amorevoli, quale inestricabile groviglio di sentimenti può provare un bambino che perde l’oggetto d’amore a causa dell’oggetto d’amore stesso? Per essere più esplicito penso che l’accostamento più probabile sia con chi subisce la perdita di un genitore suicida.

Assenza, più acuta presenza
All’inizio del mio intervento ho detto che avrei cercato di sottolineare quegli aspetti che credo potrebbero costituire un bagaglio comune in coloro che hanno vissuto esperienze simili. E questo io credo essere un secondo punto che ritroveremo nella maggioranza di coloro che vivono l’esperienza che sto raccontando, detto più semplicemente il senso di colpa per essere stati abbandonati, tanto più precoce è l’abbandono tanto maggiore sarà la fantasia di essere causa dell’abbandono, la rabbia inizialmente inespressa e negata nei confronti del genitore abbandonico, riapparirà in manifestazioni di aggressività oppure di eccessiva mitezza.
Le crisi di gelosia di Anna, le sue esplosioni di collera altro non erano che la proiezione del suo timore di essere nuovamente abbandonata da coloro che amava, legarsi diventava così qualcosa di estremamente pericoloso.
Se ricordate ho detto all’inizio di questo intervento che la scelta di un trattamento breve con una data di conclusione già determinata non era stata casuale, sapere quando avremmo terminato, ed Anna lo ricordava perfettamente, disinnescava, in un certo senso questo pericolo. Potevamo separarci senza che io l’ abbandonassi e contemporaneamente qualsiasi cosa fosse successa non l’avrei abbandonata prima.
“Assenza più acuta presenza”, è questo l’inizio di una poesia di Attilio Bertolucci, che con la leggerezza dei poeti pone l’accento sulla dinamica assenza/presenza, su come spesso l’assenza debba per essere tollerata trasformarsi, rimandare ad una presenza. Era così, ovviamente anche per Anna. Per poter tollerare la rabbia conseguente all’abbandono aveva dovuto, e credo che anche questo possa essere un tratto caratteristico di queste persone, aveva dovuto idealizzare il suo passato rifiutando, almeno in parte, il suo presente.
Cerco di spiegarmi meglio. Da un lato era idealizzata la terra d’origine, ovviamente non gli affetti ad essa collegati ma proprio il luogo fisico e contemporaneamente veniva fantasticato, sia pure in termini persecutori (non poteva essere altrimenti) un controllo da parte del padre dal carcere.
In un certo senso potremmo dire che il tentativo che Anna operava era quello di salvare capra e cavoli, Il padre era sì in carcere ma da lì si occupava della figlia e per così dire vegliava su di lei. Ma lo faceva in modo incongruo da capoclan che delega la componente affettiva a comportamenti più o meno stereotipati. In tutto questo conflitto tra istanze individuali e richieste del clan di appartenenza Anna non riusciva, ed una parte di lei inconsciamente non voleva, non riusciva dicevo a pensare di potersi costruire una vita autonoma una vita che corrispondesse alle sue istanze individuali.

La rabbia come apertura al futuro
Mano a mano che il lavoro psicoterapico con me proseguiva Anna si sentiva sempre più in grado di affrontare esprimere i propri affetti, in particolare quelli ostili, contemporaneamente più poteva accettare di essere lei arrabbiata e più si riducevano le angosce persecutorie.
Ad un certo punto della psicoterapia, poco prime delle vacanze estive, Anna mi comunica che ha chiesto di poter andare a trovare suo padre in carcere, e questa era per lei una importante novità, si sentiva meno arrabbiata ma soprattutto si sentiva in grado di sopportare di essere arrabbiata senza regredire a quegli aspetti persecutori così presenti ad inizio della terapia. Cominciano così a farsi strada all’interno delle sedute delle timide aperture al futuro, la scuola il lavoro il fidanzato etc.
Lentamente stiamo avvicinandoci alla conclusione dei nostri incontri, e come ho detto poco fa Anna aveva da subito memorizzato la data in cui avremmo concluso e la conclusione fu come spesso accade quando si termina un lavoro significativo un po’ triste ed un po’ felice. Adesso tocca a me trarre delle conclusioni da questa esperienza, penso che qualche punto posso provare a metterlo.
Rimettere in gioco gli affetti
Comincerei con l’aspetto tecnico sottolineando che il modello psicoterapico preso in considerazione, ovvero una psicoterapia psicoanalitica breve, che ponga già da subito l’attenzione e l’accento sul termine, può risultare particolarmente efficace in situazioni di questo tipo per almeno due aspetti quello teorico/clinico e quello per così dire pratico, ma procediamo con ordine.
L’aspetto teorico/clinico, come accennavo sopra, ponendo da subito una data di termine, permette di avvicinarsi a tutti quei soggetti che possono avere delle significative difficoltà a tollerare elementi di dipendenza. Penso a persone come Anna ma anche, ad esempio, agli adolescenti. Penso a persone la cui radicalizzazione nel territorio non sia ancora definita.
L’aspetto pratico qui è ancora più evidente a mio parere. Le psicoterapie brevi nascono proprio per il desiderio di portare questa opportunità in situazioni istituzionali. Come è facilmente intuibile un trattamento breve, pur se significativo, ha un costo di gran lunga inferiore rispetto ad un trattamento psicoanalitico ortodosso ed anche rispetto ad una psicoterapia a lungo termine, dove in entrambi i casi si parla di anni di lavoro. Una riduzione dei costi permette di ampliare il raggio di azione.

E veniamo per ultimo a quali penso, sulla base della mia esperienza professionale non solo con Anna ovviamente, siano gli affetti in gioco nelle situazioni in cui vi sia una qualche forma traumatica riconducibile all’abbandono.
Sono quei punti che ho cercato di sottolineare in prima battuta mentre raccontavo la storia di Anna e che possiamo riassumere in questi termini: i sentimenti che accompagnano eventi abbandonici sono da un lato un profondo senso di colpa per essere stato abbandonato e questo senso di colpa non permette di riconoscere e di tollerare che siamo arrabbiati, e spesso troveremo la rabbia sotto forma di una sintomatologia depressiva. Chi vive queste situazioni teme la sua rabbia che è sentita come distruttrice e che deve controllare a tutti costi, anche a costo di rivolgerla contro se stesso.
Troveremo sempre, io credo, dei sentimenti fortemente ambivalenti e scissi. Troveremo l’inevitabile e purtroppo perdente tentativo di salvare l’oggetto abbandonante. In Anna era l’idealizzazione della terra d’origine, che nel linguaggio psicoanalitico potremmo definire come l’idealizzazione di quegli aspetti dell’infanzia idealizzati prima del tradimento, un inconscio tentativo di cancellare l’abbandono. E credo anche che con questa ambivalenza dovrà fare i conti chiunque si avvicini a queste situazioni, e forse può essere utile sapere che questa ambivalenza non è diretta a noi, ma è un tentativo della persona di proteggersi da un dolore troppo grande.
Molte sono le cose che Anna mi ha insegnato e questo è in fondo in comune con tutti i pazienti, quelli che Bion definiva i nostri migliori colleghi, ma se devo scegliere quale sia la più importante non ho dubbi, le prime vittime di un certo tipo di criminalità sono proprio i figli di questi criminali, perché sono coloro che vivono da un lato il dramma dell’abbandono, dall’altro non possono nemmeno esprimere la propria rabbia verso coloro che li hanno abbandonati, e forse è proprio questo il compito di coloro che pensano di potersene prendere cura.