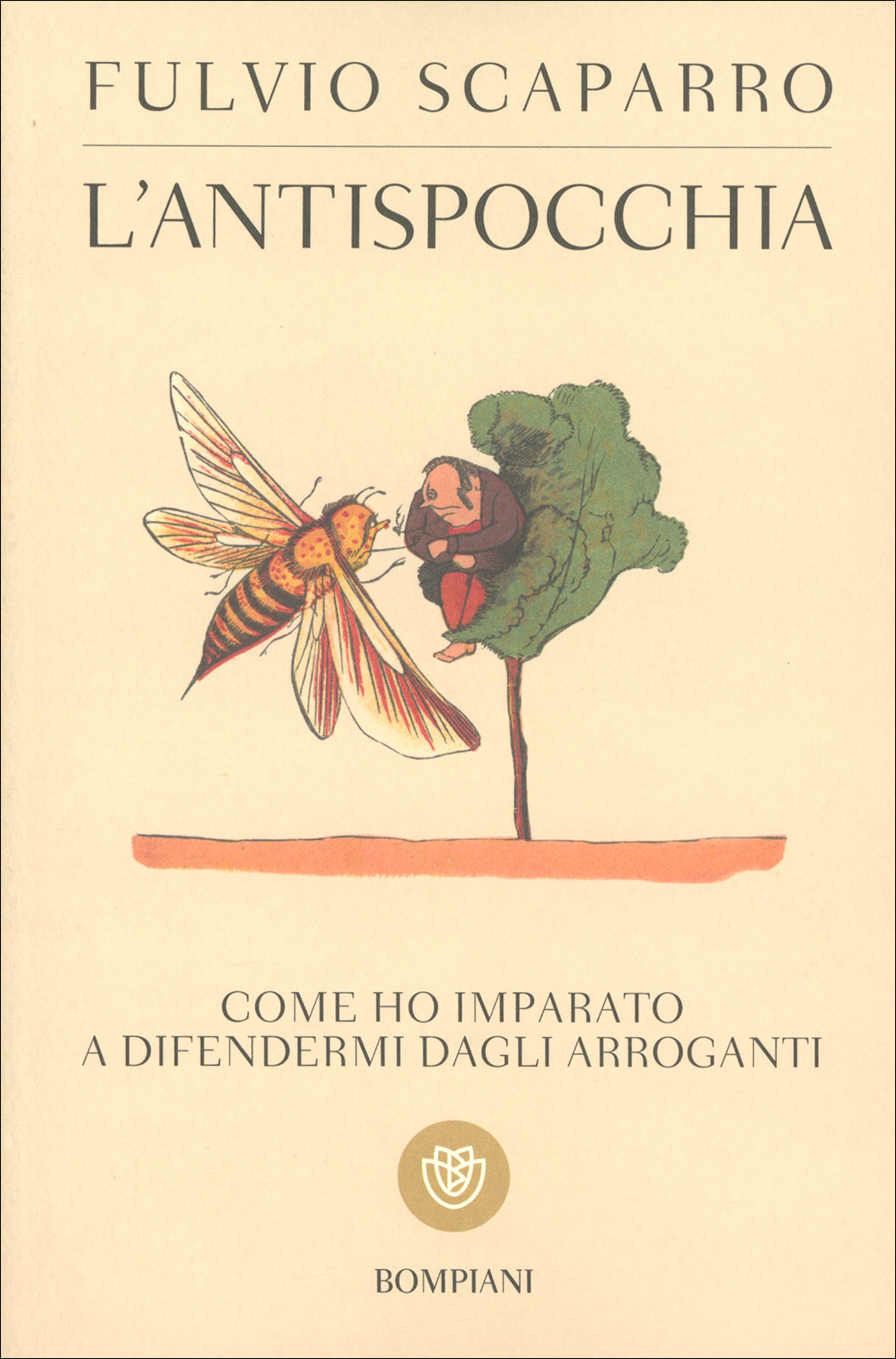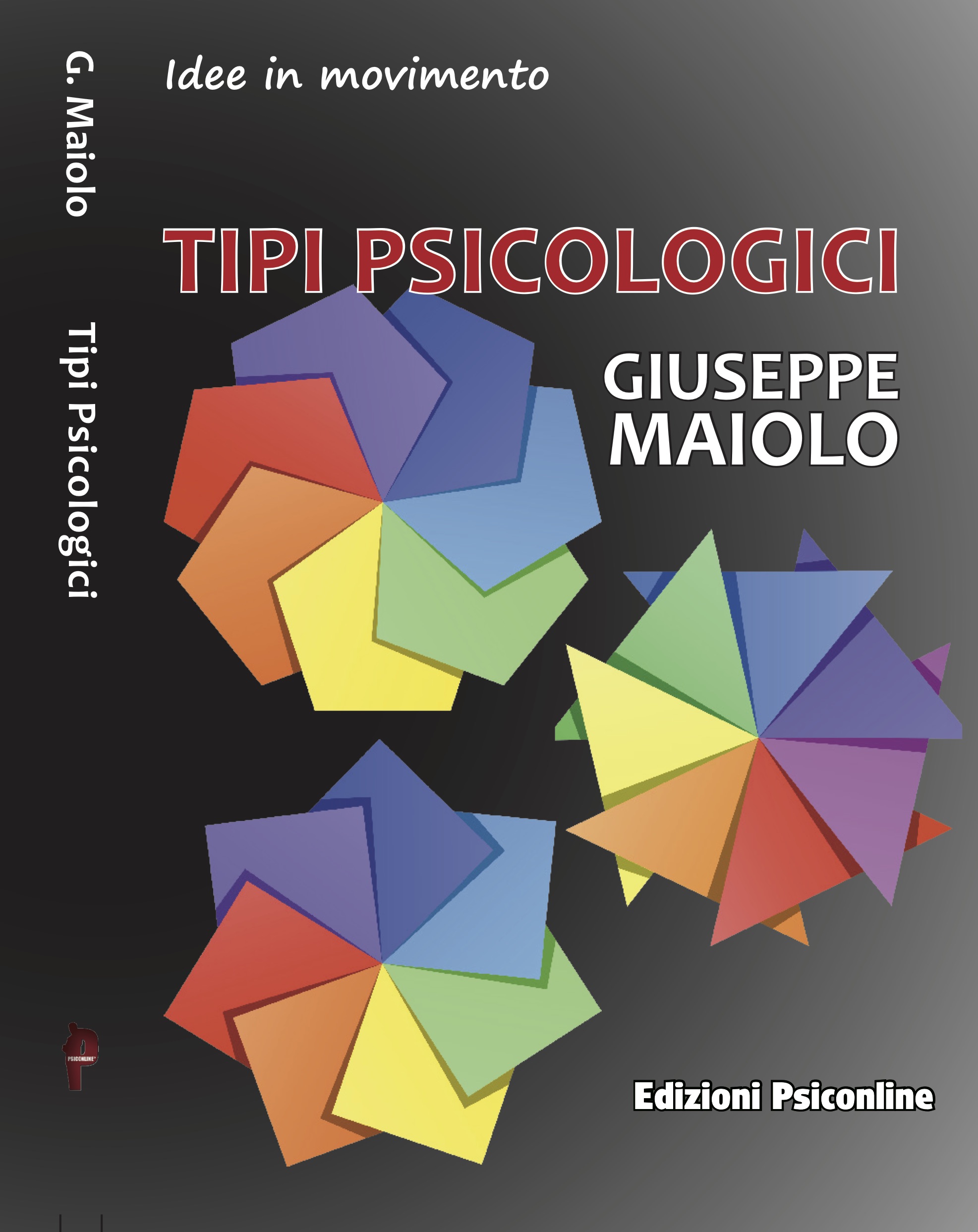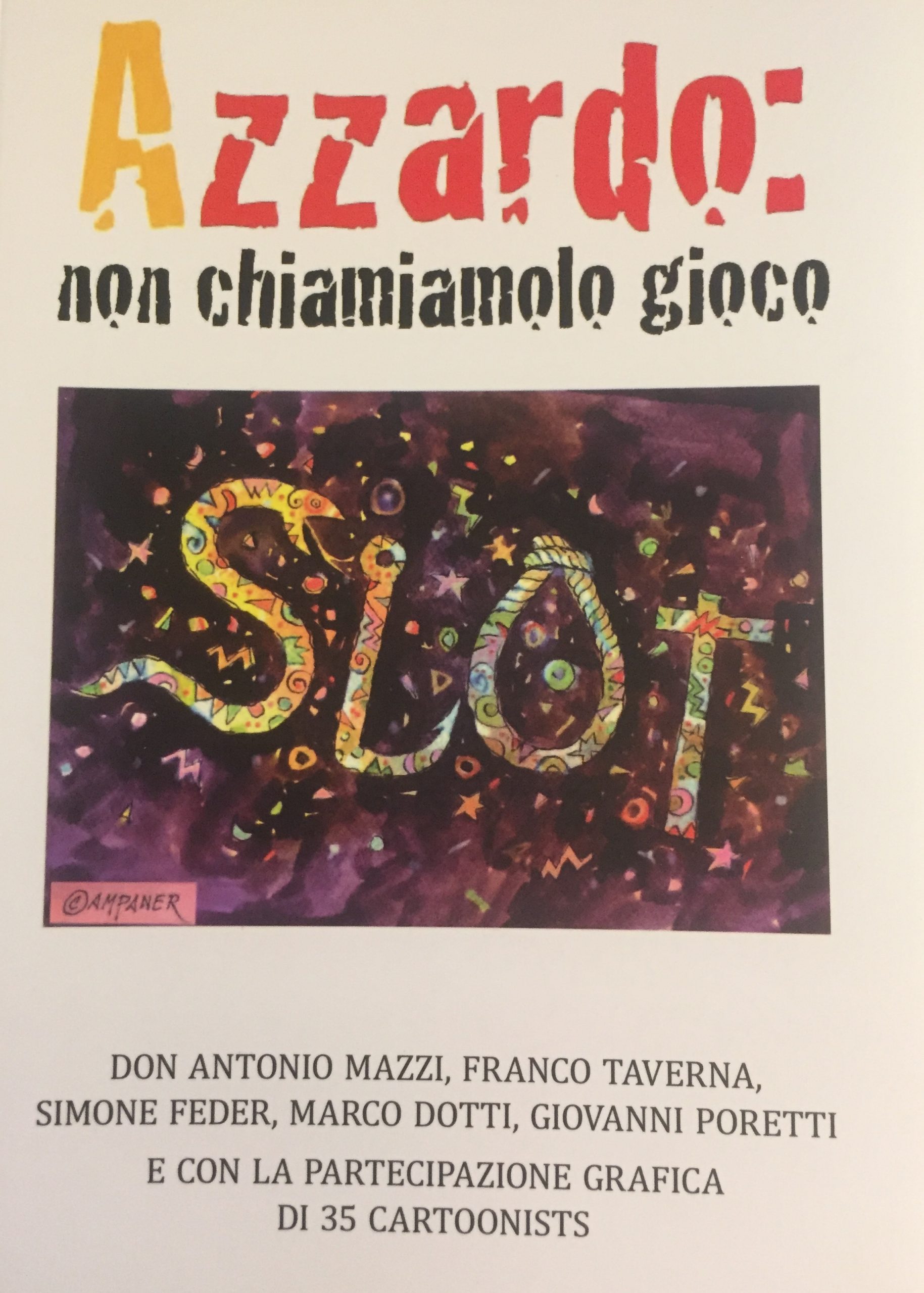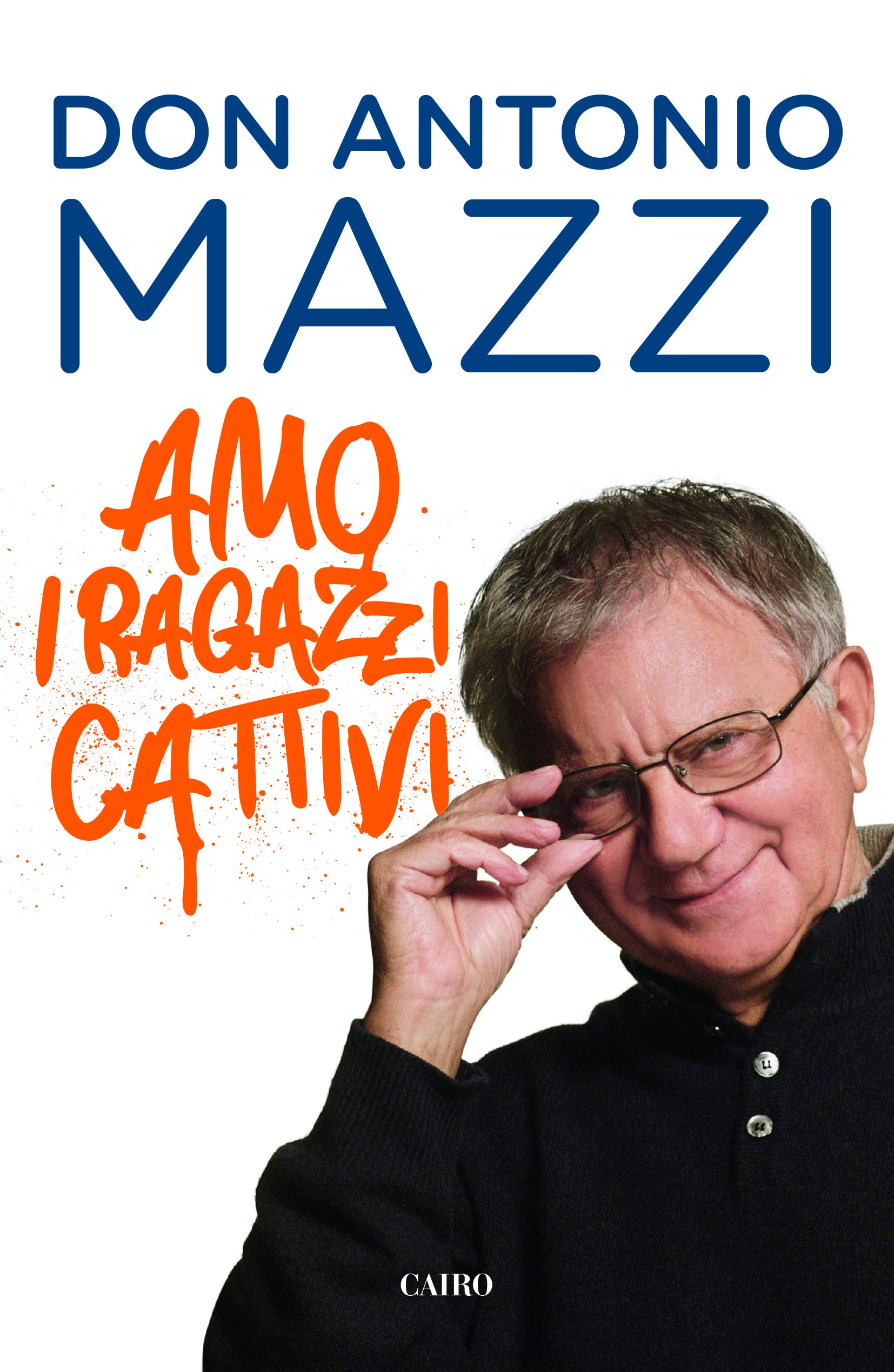In questo periodo leggo e ascolto molto sulle relazioni interpersonali condizionate dalla pandemia e anche riflessioni sul Movimento del ’68, spesso legato dai media alla lotta armata, ma la storia è fatta da tutti, quotidianamente e soprattutto da chi non ha mai usato le armi.
Questa è stata ed è la “nostra rivoluzione”
Quindi ho pensato di condividere alcune riflessioni proprio su questi concetti attraverso le mie esperienze e quelle di altri che hanno vissuto che ho conosciuto.
Mi sembra giunto il momento di parlare di un periodo della mia vita importante per quello che sono diventata oggi, se sono Tina è certo merito dei miei genitori ma soprattutto di questa esperienza, fondamentale e profonda, aver conosciuto e vissuto nelle Comunità di Capodarco.
Se ho una visione del mondo abbastanza ampia lo devo prima alla vita nella mia scuola speciale, dove la convivenza con le diversità è stata lunga e piena di vissuto, di incontri: la diversità era la quotidianità. Molto poi ha fatto la mia esperienza in comunità e il suo modello, che ancora porto avanti dentro di me e cerco di attuare nella vita di tutti i giorni.
Un modello, che, aggiornato ai nostri tempi, potrebbe essere la risposta alle conseguenze che la pandemia ha portato nella vita di relazione e negli obbiettivi da raggiungere per migliorare la qualità della vita di ognuno.
Sono andata a Capodarco nel ‘75, il Movimento del ‘68 l‘ho conosciuto in comunità, avevo smesso la scuola speciale a 24 anni e mi fu prospettato di andare a Capodarco dalla mia scuola, ma io pensavo… ad una vacanza al mare…invece…
 La Comunità di Capodarco (www.comunitàdicapodarco.it) nasce nel ’66 da un movimento fondato da un sacerdote, per me un mito: Don Franco Monterubbianesi, il movimento un poco alla volta si formò con persone disabili, tolte agli istituti dove erano parcheggiate senza un progetto di vita, spesso orfani o non voluti dalla famiglia oppure dalle case dove erano abbandonati a se stessi.
La Comunità di Capodarco (www.comunitàdicapodarco.it) nasce nel ’66 da un movimento fondato da un sacerdote, per me un mito: Don Franco Monterubbianesi, il movimento un poco alla volta si formò con persone disabili, tolte agli istituti dove erano parcheggiate senza un progetto di vita, spesso orfani o non voluti dalla famiglia oppure dalle case dove erano abbandonati a se stessi.
Don Franco andava per istituti con una vecchia ‘500 e prospettava alle persone disabili questo progetto di comunità, molto diverso dall’istituto, esso aveva un progetto d’autonomia ed indipendenza, attraverso il recupero di una formazione scolastica o di potenzialità residue.
Conobbi la Comunità di Capodarco di Fermo, nelle Marche, nella provincia di Ascoli Piceno nel 1975, dopo quasi 10 anni dalla sua nascita, alla base del progetto della Comunità di Capodarco c’era e c’è un processo di liberazione individuale e collettivo di coloro che non sono tutelati. La Comunità sceglieva di stare dalla parte di chi non ha diritti ed agire, perché i non tutelati e i non garantiti, si formassero una coscienza dei loro diritti e doveri, per diventare i soggetti della propria liberazione e riscatto.
Ciò era condiviso anche da molti giovani “cosiddetti sani” e anche da disabili che venivano da diverse regioni d’Italia, tutti con diverse formazioni, esperienze e culture: dal seminarista Don Giacomo al fratello di una comunitaria che ha ucciso i suoi genitori, dagli scout rivoluzionari a giovani usciti dalla strada, credenti “in cerca”, operai e universitari in lotta, donne alla ricerca di un marito “di qualsiasi genere” e donne alla ricerca di un proprio Dio, tossicodipendenti e persone disabili quasi tutti “incazzati” con la vita, temperamenti miti 4 fra cui io, insomma… Un vero cocktail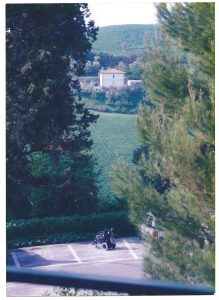
Questo processo innovativo è figlio degli anni della contestazione, e quindi della ricerca di un modo nuovo di vivere al di fuori degli schemi tradizionali e delle istituzioni: soprattutto la famiglia, nella migliore delle definizioni è considerata superata.
Nasce soprattutto fra i giovani l’esigenza di fare esperienze collettive sia in politica, che a scuola o nel quartiere.
Per molti handicappati questo impegno cambia radicalmente la vita, viene coniato un nuovo termine: vita alternativa, come ad esempio quella delle comuni o comunità dove si vive insieme e si condividono relazioni, fini, beni economici, ecc.
“Vivere insieme”
al di fuori delle proprie famiglie o dall’istituto diviene uno degli scopi sul quale si fondano le numerose comunità che sorgono su tutto il territorio nazionale.
Con la nascita delle comunità i disabili “invisibili” si vedono, si riconoscono l’un l’altro, nasce in loro un’identità confusa ma viva, con il desiderio di scoprirla sempre più, anche attraverso l’esperienza di altri. Nelle associazioni non vengono più rappresentati solo dai genitori o dai delegati, ma loro stessi diventano i protagonisti consapevoli delle difficoltà da affrontare per raggiungere le mete che si prefiggono, spesse volte molto ardue.
L’ideale assoluto della condivisione diventa la realtà della condivisione possibile.
Il pensiero comunitario si basa a tutt’oggi su alcuni principi di fondo:
– il rifiuto dell’atteggiamento pietistico nei confronti di chi è in difficoltà e il superamento di ogni assistenzialismo;
– lo stile della condivisione, del coinvolgimento profondo con la storia dell’altro, del pagare di persona, uno dei principi in cui mi ritrovavo totalmente ma che osservavo essere difficile, viverlo nella quotidianità per molti.
– la territorialità dell’intervento per evitare di chiudersi nella propria struttura ed aprirsi alle realtà circostanti;
– la quotidianità come spazio in cui tutti hanno la possibilità di crescere e di emanciparsi attraverso il lavoro, momenti di vita comune, attività di servizio sociali.
La cosa che mi colpi nel vivere questa esperienza era che ogni disabile, anche gravissimo aveva un compito, quello che era in grado lo doveva fare, era il suo modo di partecipare alla vita di comunità e dare il suo contributo. Si costruirono laboratori artigianali, come cucito, pittura, serigrafia, intarsio, e via così.
Delle cose positive ho scritto fin ora, ma la comunità ha anche le sue difficoltà, di cui vi scriverò assieme ad alcune testimonianze, non solo personali, alla prossima puntata.
(1 – continua)