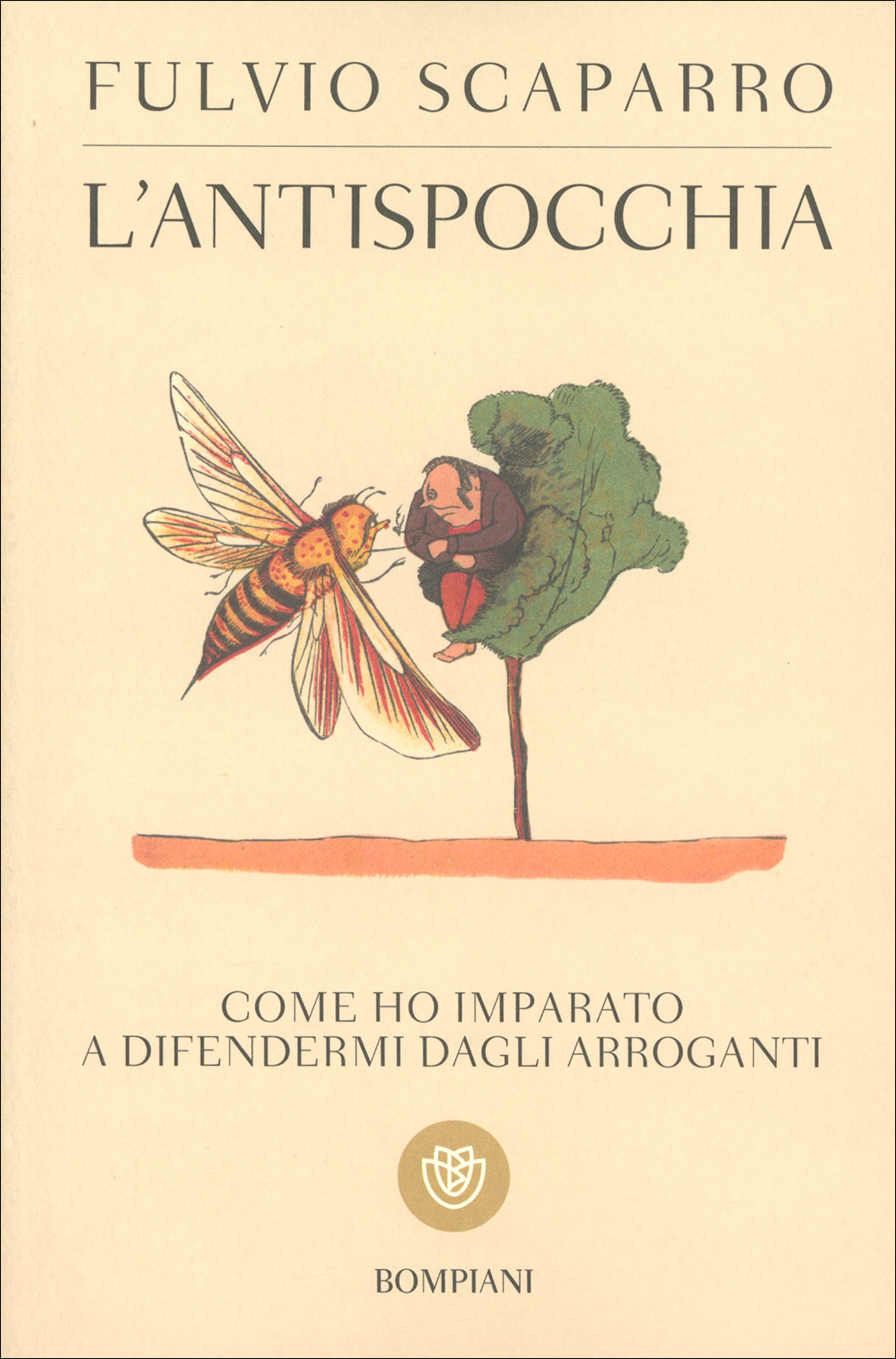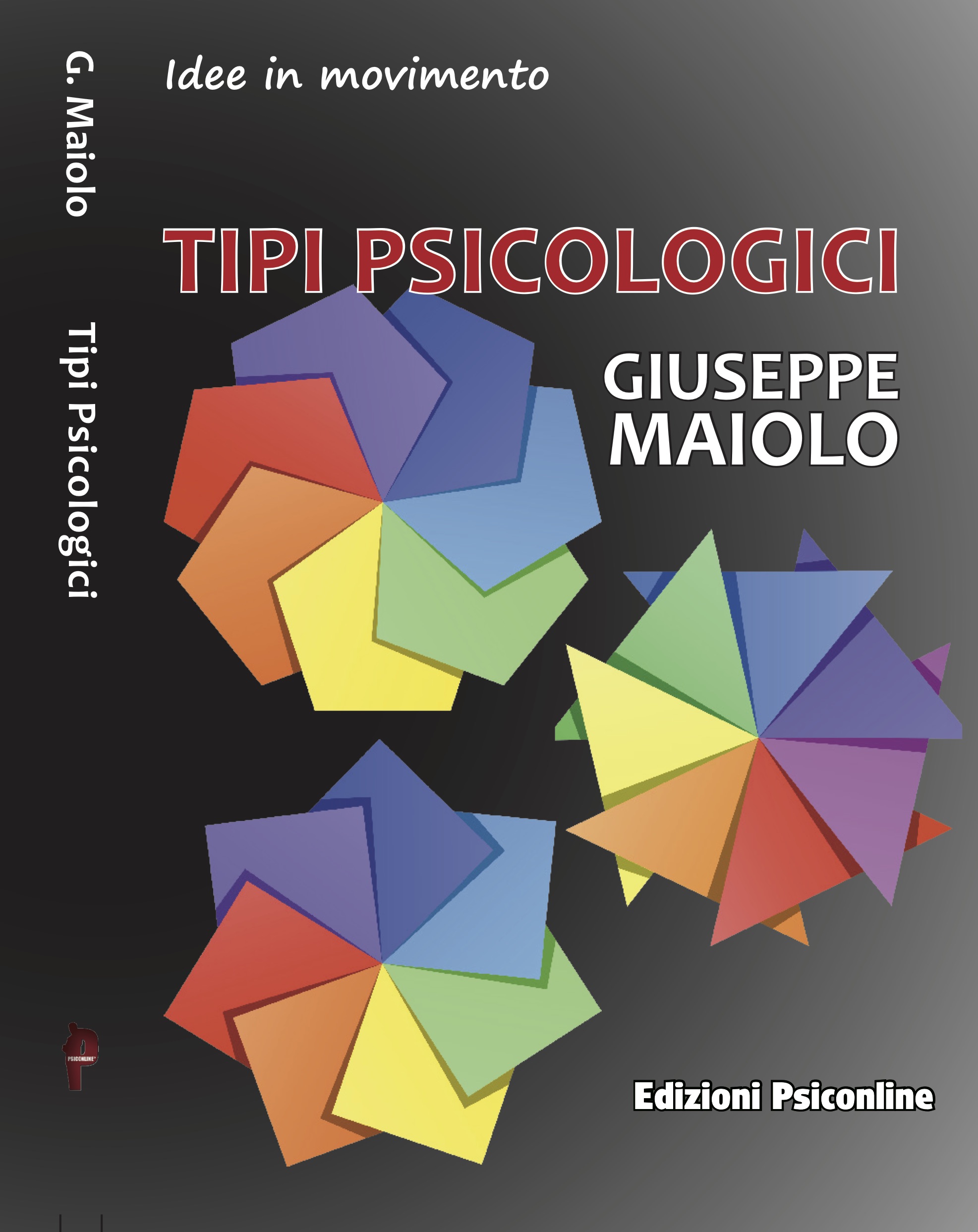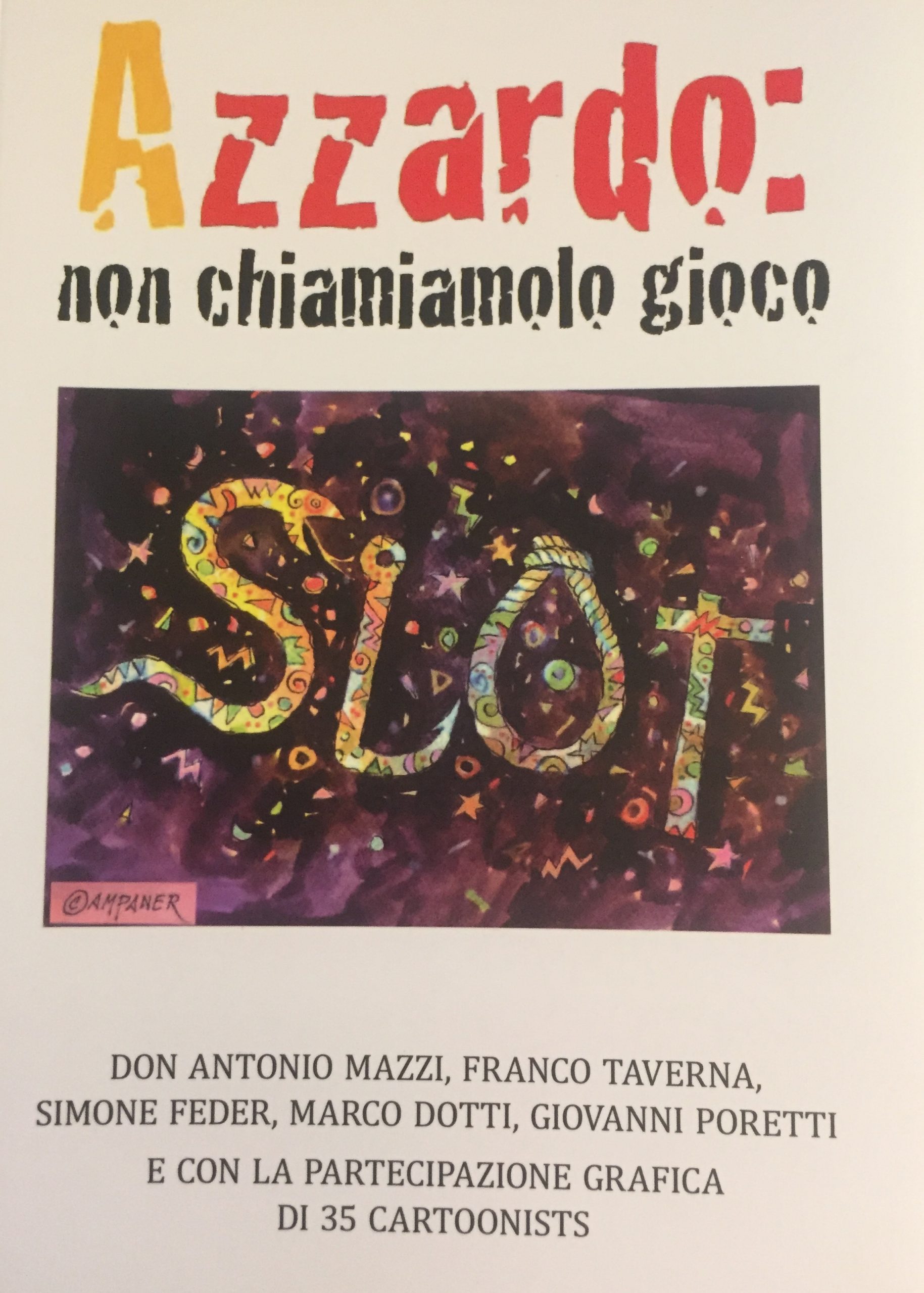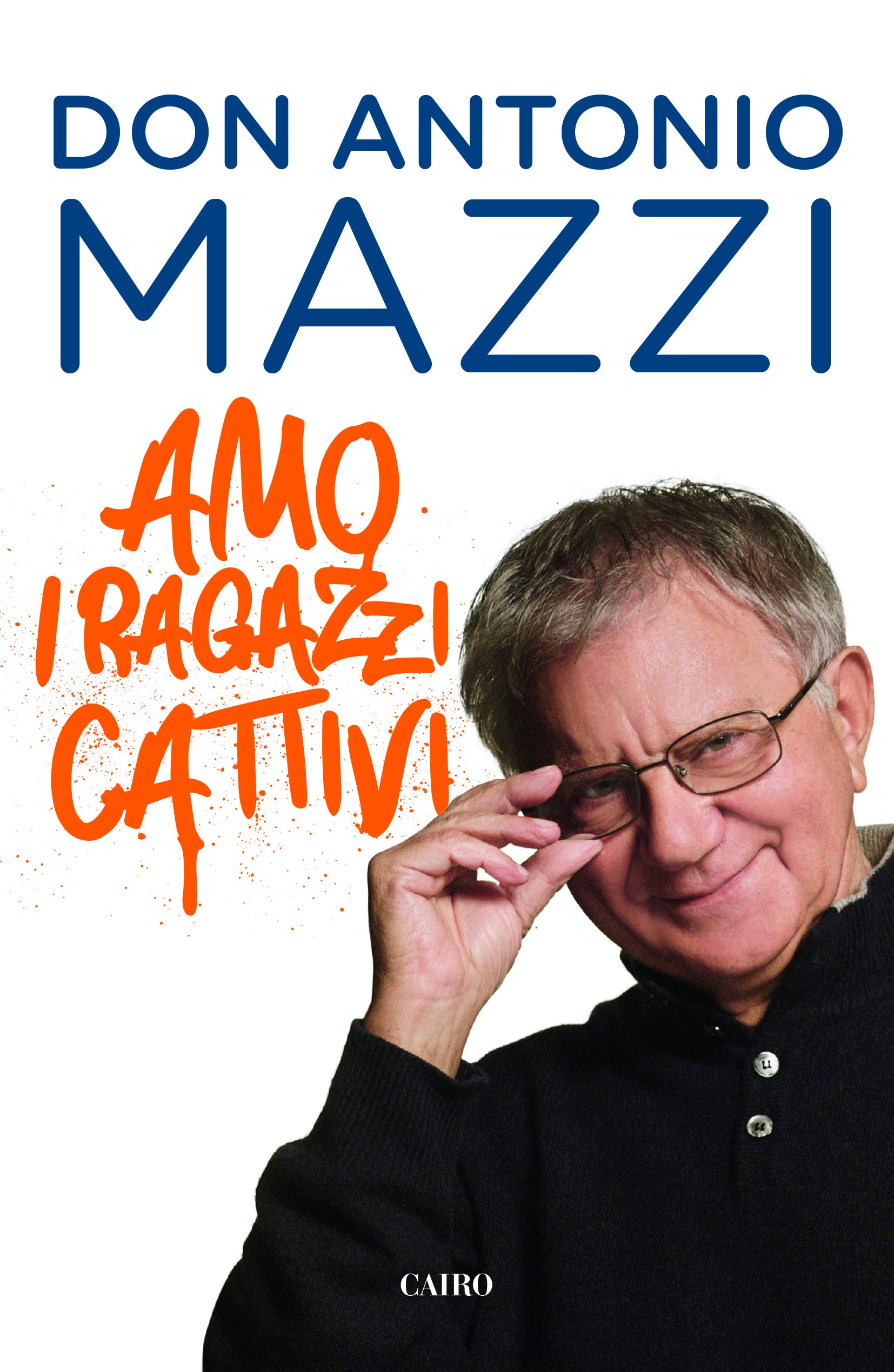Del senno di prima
Ricordate Kim Phúc, la bimba vietnamita protagonista della fotografia simbolo della guerra in Vietnam? La vediamo correre nuda, sconvolta, in lacrime dopo che il napalm ha bruciato il suo villaggio. Con lei ci sono altri bambini in fuga, terrorizzati. Gli unici adulti sono sullo sfondo, soldati che avanzano con cautela, armi in mano. Confrontiamo questa foto con una delle tante scattate durante l’invasione dell’Ucraina che, mentre sto scrivendo è ancora in corso. Non è l’unica guerra in corso nel mondo ma tocca l’Europa e quindi ha un risalto mediatico ben superiore a tutte le altre.

Notiamo che la madre ucraina fugge dal suo Paese invaso portando in braccio la sua bambina e sulle spalle uno zaino con le poche cose che è riuscita a metterci dentro. Entrambe le foto, prese in scenari di guerra diversi, hanno in comune l’orrore di ogni evento bellico ma possiamo notare una differenza: Kim Phúc e gli altri bambini vietnamiti che corrono spaventati sono soli, i loro genitori non ci sono forse morti nel bombardamento o comunque dispersi, la bimba è con la sua mamma.
Prendo spunto da queste foto per riflettere sul perché i bambini vivano la tragedia delle guerre in modo diverso se hanno vicino persone care e animali e oggetti che facevano parte della loro quotidianità in tempo di pace. È un’esperienza vissuta da che mondo è mondo ogni volta che chi ci ha preceduto nel tempo si è trovato in condizioni di grave pericolo. “Prima donne e bambini” è un comando cavalleresco prima che marinaro strettamente legato alle esigenze di sopravvivenza della specie.

Titolo su un quotidiano del 31 marzo 2022: “Un ucraino su dieci scappa all’estero. Metà di loro con pupazzo: sono bimbi”. La funzione del pupazzo, della bambola, dell’animale di peluche è chiara a molti lettori cultori di Schulz e delle avventure di Linus con la sua copertina. Forse meno saranno coloro che collegano la copertina all’oggetto transizionale descritto da Winnicott, pediatra e psicoanalista che ho più volte citato. Amava il paradosso uno dei quali, “il bambino non esiste”, potrebbe far sobbalzare il cuore di chiunque non avesse voglia di leggere la spiegazione che ne dà Winnicott stesso: non esiste “il bambino” in astratto ma sempre in relazione con altri esseri umani e con un ambiente. Di questi temi Winnicott si è occupato per buona parte della sua vita professionale, anche quando è stato chiamato ad organizzare la vita dei bambini sfollati dalle grandi città del Regno Unito esposte ai bombardamenti nazisti nel corso della seconda guerra mondiale. Non fu l’unico.
Lui e altri colleghi del Regno Unito si trovarono giocoforza a disporre di un osservatorio privilegiato per lo studio dei legami familiari. Tra di loro c’erano opinioni differenti: proteggere l’incolumità dei bambini allontanandoli dai genitori e mettendoli al riparo fuori dalle grande città bersaglio dei bombardamenti o lasciarli in città sotto la protezione della loro famiglia. Prevalse la prima soluzione e un buon numero di bambini furono sfollati nelle Child Guidance Clinics nella campagna londinese dove lavorarono eminenti studiosi tra cui, appunto, Winnicott. Il lettore potrà trovare i dettagli nelle sue opere di Winnicott tra le quali suggerisco Il bambino deprivato. Le origini della tendenza antisociale (Milano, Cortina, 1986):

Sul tema ho da riferire un’esperienza personale di cui ho ricordi molto vividi. Dall’età di cinque anni sono stato un bambino prima in fuga e poi sfollato. Sto parlando degli anni dal 1942 al 1945 quando non avevo un Winnicott che si occupasse di me ma solo mia madre, una zia, un fratello, maggiore di cinque anni, e un cuginetto di tre: non c’erano più uomini adulti in questo gruppo familiare perché, per non coinvolgerci, vivevano lontani, impegnati a sopravvivere alle conseguenze della caduta del fascismo che aveva azzerato la loro posizione sociale precedente alla guerra.
Posso quindi dare testimonianza in prima persona del peso decisivo che la presenza di una madre o di una donna che ne faccia le veci può avere filtrando o attutendo l’impatto dei più piccoli con le terribili esperienze della guerra. Io e mio fratello siamo fuggiti da Tripoli in aereo prima che vi arrivassero gli inglesi vincitori della battaglia di El Alamein.
Siamo arrivati a Roma dove ci sistemammo in qualche modo fino all’inizio dei bombardamenti alleati sulla Capitale. Le sirene, giù ammucchiati nelle cantine, gli adulti con le orecchie tese per capire dove sarebbero cadute le bombe, io rannicchiato accanto a mia madre e mio fratello giocherellando con la torcia dinamo che facevo fatica ad azionare con una sola mano. Fummo presto costretti a sfollare insieme a mia zia e al cuginetto verso le Marche dove un tempo la famiglia delle due sorelle, marchigiane di nascita, aveva proprietà terriere e ancora qualche appoggio di parenti alla lontana e di anziani contadini che avevano lavorato per la loro famiglia in tempi lontani. Era il periodo in cui migliaia di famiglie italiane sfollavano dalle città minacciate dagli eventi bellici cercando rifugio nelle loro “piccole patrie”, i paesi di origine in pianura o in montagna sparsi qua e là nella Penisola.

Posso solo immaginare lo stato d’animo delle donne del mio piccolo gruppo familiare, sole, con la responsabilità di tre bambini, alla ricerca di una casa dove vivere in quegli anni bui. A distanza di tempo ho capito che uno dei grandi meriti di queste due donne è stata la loro capacità di non trasmettere la loro disperazione e paura a noi bambini.
La guerra infuriava nelle Marche anche se con modalità diverse da quelle che avevamo vissuto in Libia e a Roma. Dopo qualche mese di relativa tranquillità che ricordo con nostalgia perché erano giorni trascorsi sempre all’aria aperta giocando con gli amici o vivendo la vita dei campi sotto la guida di qualche contadino, la guerra si presentò nella sua veste più dura.
Arrivarono i tedeschi in ritirata, ci furono rastrellamenti alla caccia di partigiani, due dei quali furono trovati, fucilati sul posto e i loro corpi appesi nella pubblica piazza. Durante il coprifuoco le pattuglie giravano per il paese sparando contro qualunque finestra illuminata e uccidendo in questo modo anche un uomo al quale ero affezionato – lo chiamavo zio – perché mi portava in campagna sulla sua Guzzi, esperienza indimenticabile.
Sempre tra la tragedia e noi si alzava il muro protettivo delle madri che cercavano di non farci vedere ciò avrebbe potuto spaventarci o, quando era impossibile nasconderci le conseguenze peggiori della guerra, facevano in modo di allontanarci dalla scena o minimizzavano la situazione raccontandoci versioni dell’accaduto che finivano inevitabilmente, se non con un lieto fine, con parole di speranza. Subimmo anche una perquisizione in casa che mise a dura prova l’autocontrollo di zia e mamma.
Un soldato tedesco, armato di tutto punto, bussò con violenza alla porta. Voleva sapere se avevamo armi in casa e dove fossero gli uomini. Qui mia madre e mia zia diedero il meglio di sé. Cercarono di apparire tranquille e perfino ospitali, offrirono un caffè e un po’ di pane, riuscirono non so in che modo a spiegare al soldato che gli uomini erano rimasti a Roma e che loro non solo non avevano armi ma che non avrebbero nemmeno saputo cosa farne.

Aprirono le stanze al soldato che si guardò intorno e parve soddisfatto di ciò che vedeva. Se ne andò salutato con cordialità da mamma e zia che, appena chiusa la porta, si abbracciarono sopraffatte dall’emozione per il
pericolo scampato. Il soldato non aveva chiesto di vedere la soffitta. Lì avrebbe trovato tre fucili da caccia e molte cartucce, lasciate lì dal simpatico “zio” che mi aveva iniziato alla motocicletta. Se il tedesco le avesse trovate non ci sarebbe stato scampo per le mie donne coraggiose.
Poi arrivarono gli americani e poco dopo la notizia della liberazione di Roma, venne a prenderci il marito di mia zia che si era procurato un piccolo autocarro a tre ruote dove riuscì non so come a stiparci tutti. Il viaggio fu lungo e faticoso attraverso strade disastrate e ancora non molto sicure.In una salita dovemmo scendere tutti e trovare nelle vicinanze un contadino che per pochi soldi attacco il veicolo a un paio di buoi portandoci fino in cima. Lungo il percorso vedemmo in almeno due occasioni due cadaveri sul ciglio della strada che le madri si affrettarono a definire “persone addormentate” per non spaventarci.
Anche questo viaggio, benché estenuante, noi bambini l’abbiamo vissuto come un’avventura: la realtà dellaperquisizione, dei drammi vissuti dal paese e del lunghissimo viaggio di ritorno, l’abbiamo conosciuta anni dopo. A noi bambini era rimasta la memoria di un periodo nell’insieme ricco di esperienze anche se turbato da qualche raro cedimento emotivo delle madri che non sempre riuscivano a fingere sicurezza e perfino ottimismo.
Solo molto più tardi avrei capito e apprezzato la potenza dello scudo materno.