Le biografie personali che negli ultimi fatti di cronaca hanno visto protagonisti adolescenti che hanno perso la vita, necessitano di tutto il nostro rispetto e mai di un giudizio. Tuttavia è necessario cercare un senso ai comportamenti estremi e agli eccessi che i giovani mettono in atto. Conta il bisogno di mettersi alla prova oppure il lutto per la propria infanzia smarrita e il sentimento di perdita dell’onnipotenza infantile.
Ma probabilmente dovremmo capire perché i segnali di pericolo non stanno funzionando o se non vengono ascoltati quelli che hanno il compito di comunicare dove stanno i confini.
Osservando la frequenza con cui oggi gli adolescenti si fanno del male e sfidano la morte, è che stanno prevalendo le pulsioni incontrollate e quell’acuto bisogno adrenalinico soddisfatto con esperienze forti e di confine.
Accanto a questo però si insinua anche il dubbio che stia mancando la partecipazione degli adulti al processo interno di crescita dei giovani.
Perché non è solo il controllo quello che definisce il livello di protezione e di difesa dei minori dai rischi correnti e soprattutto da quelli emergenti nel web.
Oltre a questo, cui l’adolescente cerca fisiologicamente di sottrarsi, serve esserci e non solo stare a guardare cosa combina e quanto sia sbagliato il suo modo di agire.
Serve partecipare in maniera autentica alla loro vita quotidiana, che non significa semplicemente chiedere l’amicizia sul social per leggere cosa posta, quali sono gli amici, le sue preferenze e i pensieri più comuni.
È necessario piuttosto chiedere apertamente come vanno le cose in Internet, informarsi sul mondo virtuale dell’adolescente e su come è percepito, avere idee più chiare sul tipo di relazioni che i figli intrattengono in rete e quando chattano.
Non si va nella zona rossa del rischio elevato e non si muore a causa della frequentazione del web.
Pensarlo è un errore che spinge in una direzione fuorviante perché non sono i mezzi che usiamo a farci andare fuori strada.
Caso mai è la scarsa competenza alla guida e insieme la sottovalutazione della potenza che hanno i nostri nuovi strumenti di comunicazione.
E non è neanche la tecnologia di oggi a spingere verso il confine estremo dell’esistenza o a sfidare senza consapevolezza il pericolo.
Lucio Battisti nel 1970 cantava «Emozioni» dove in una strofa diceva «…guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire».
È la conferma che tutto questo avviene da sempre con la medesima necessità.
Ciò che è fortemente cambiato è il romanzo familiare, ovvero l’assenza della narrazione.
Manca il fatto di non riuscire più a mettere in comune la storia degli adulti con quella dei figli, l’esperienza sempre uguale del bisogno delle prove, la necessità di affrontare la paura e guardare in faccia la morte quando ci si svincola dall’infanzia.
Nessun adulto di riferimento dice più all’adolescente «Sai che anch’io, alla tua età, ho provato le cose che senti tu e ho voluto vedere se poi è tanto difficile morire».
Il silenzio ora è quello che accompagna la relazione educativa e che lascia da soli i figli davanti ai tanti display che attorniano l’esistenza.
Un silenzio che parte da lontano, da quando ai bambini non raccontiamo più fiabe e agli adolescenti non offriamo la possibilità di confrontarsi con il dolore interno, sempre presente in ogni generazione.
Quello stesso dolore che un tempo poteva essere affrontato a scuola leggendo i classici come il «giovane Werter» o l’«Ortis» e mandando a memoria «A Silvia» di Leopardi, ora è presente come vuoto assoluto e buco nero.
Forse è questo il vuoto da riempire.
Giuseppe Maiolo






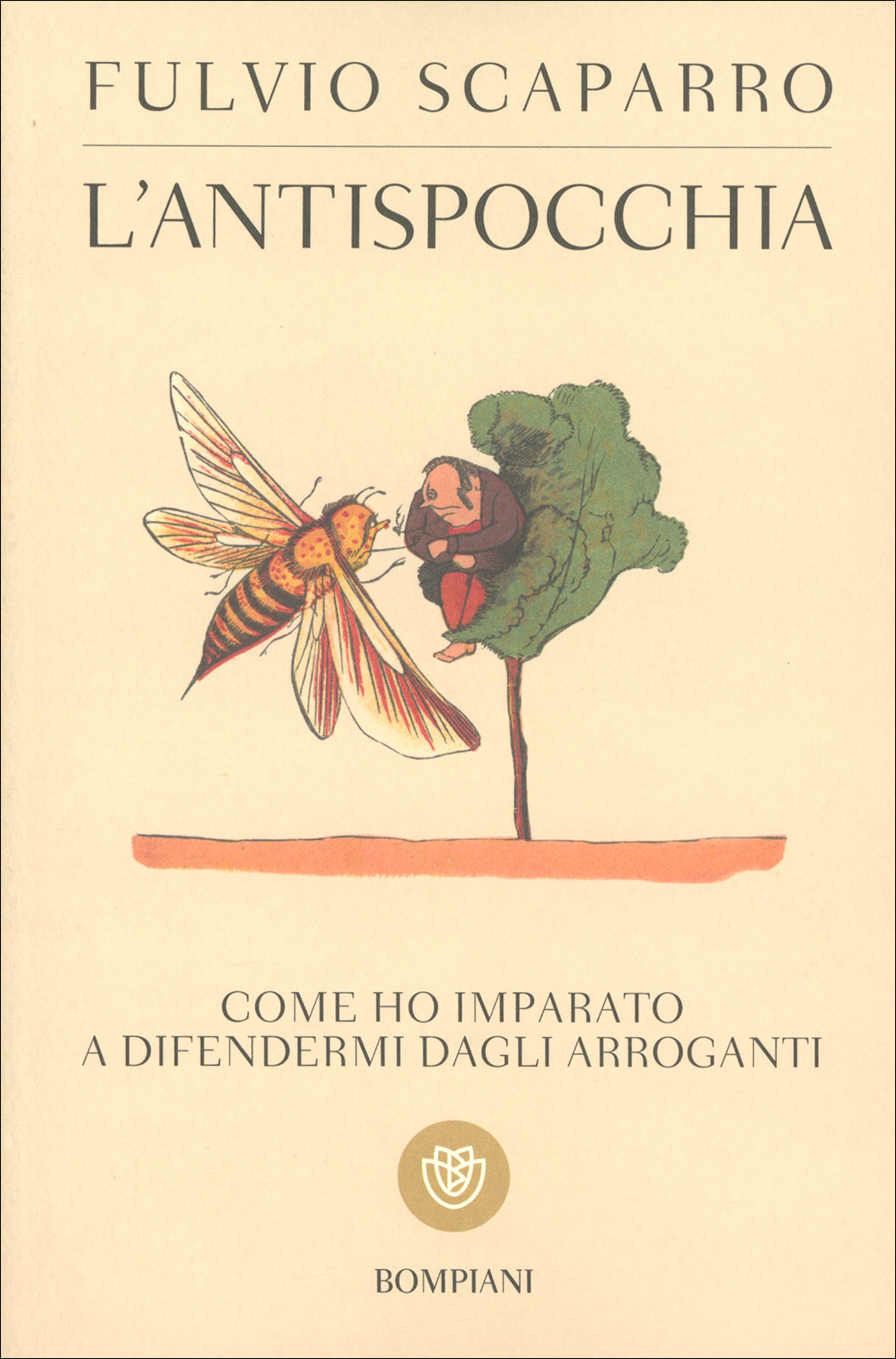

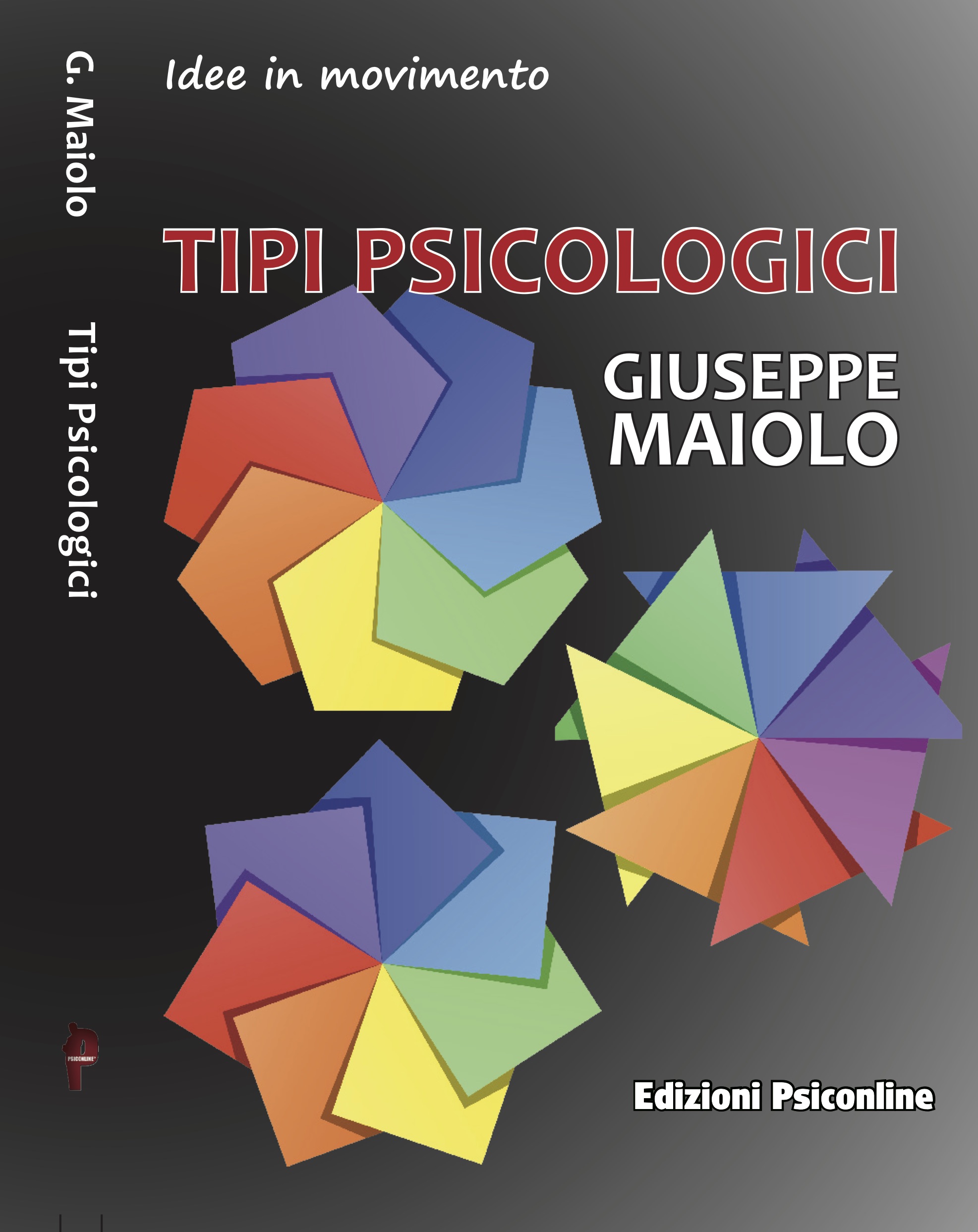












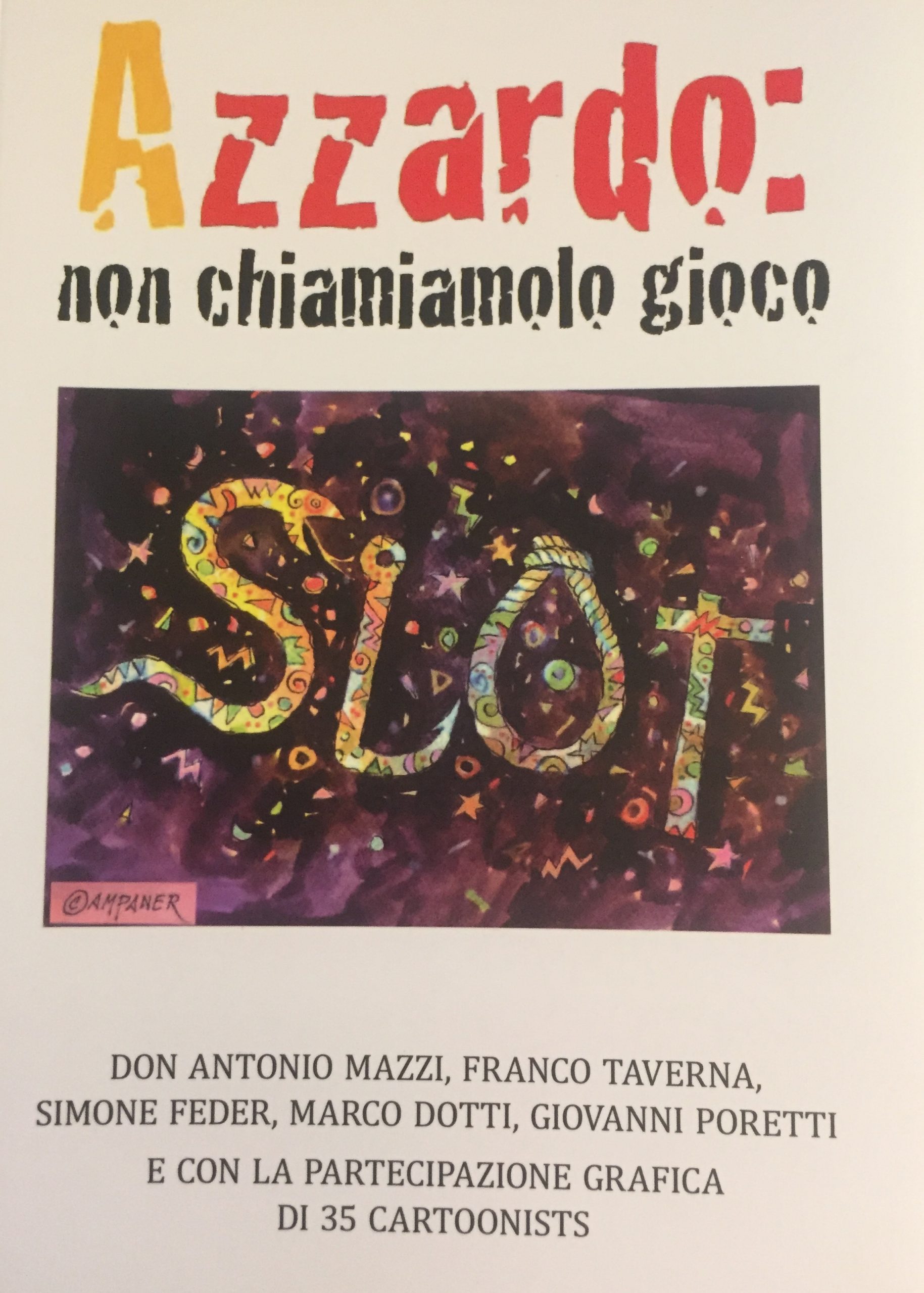


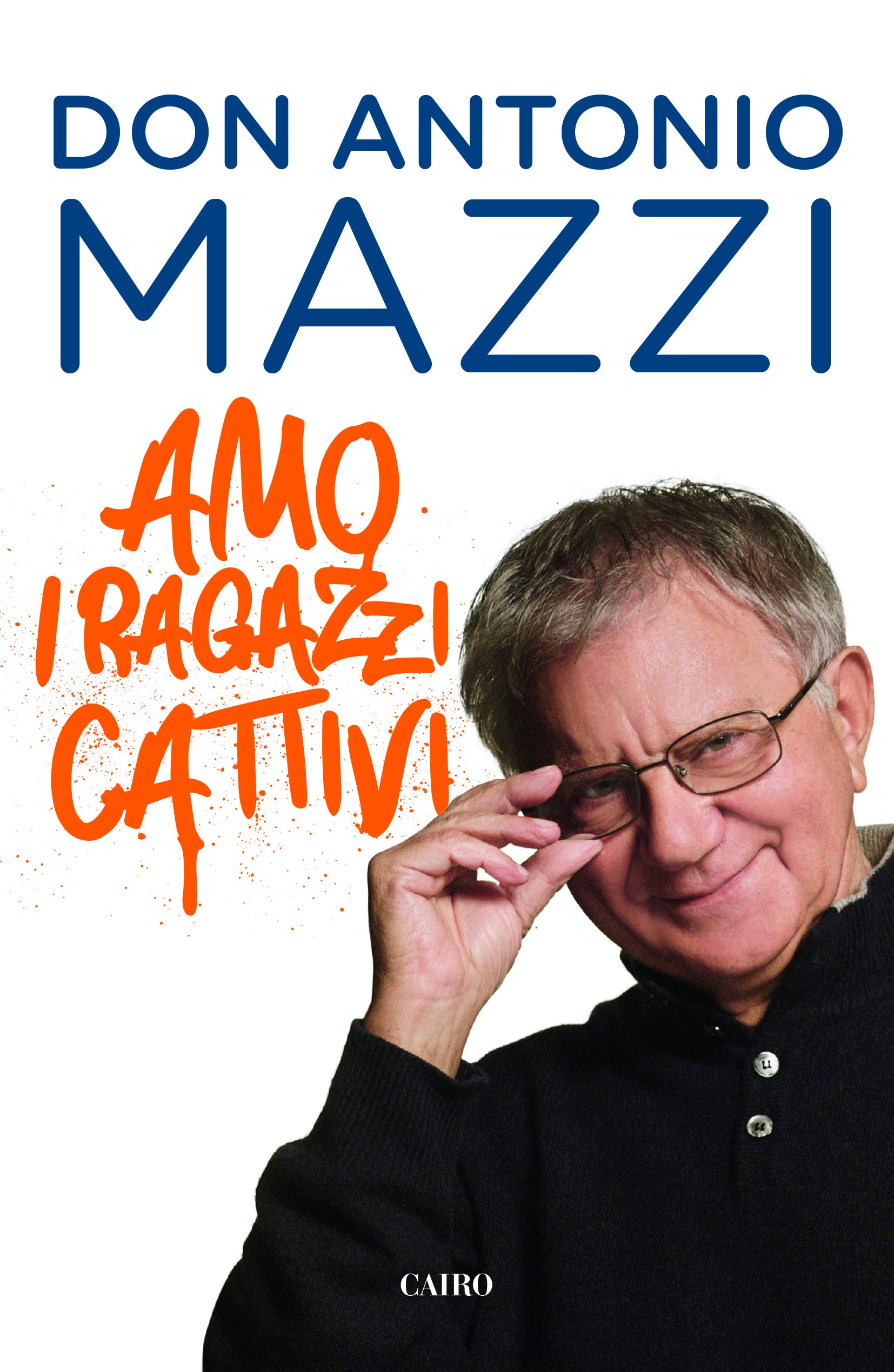














Leave a Reply