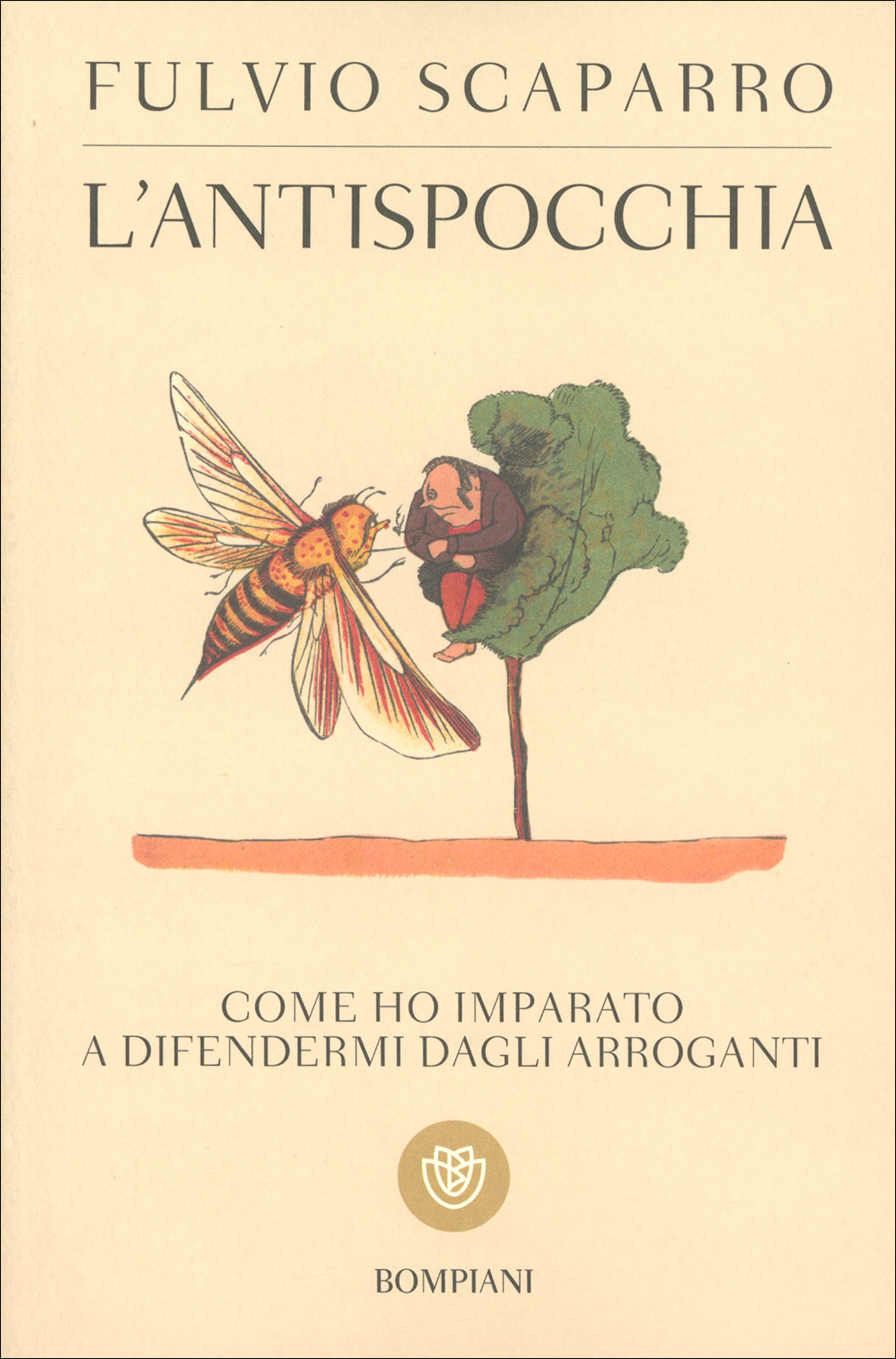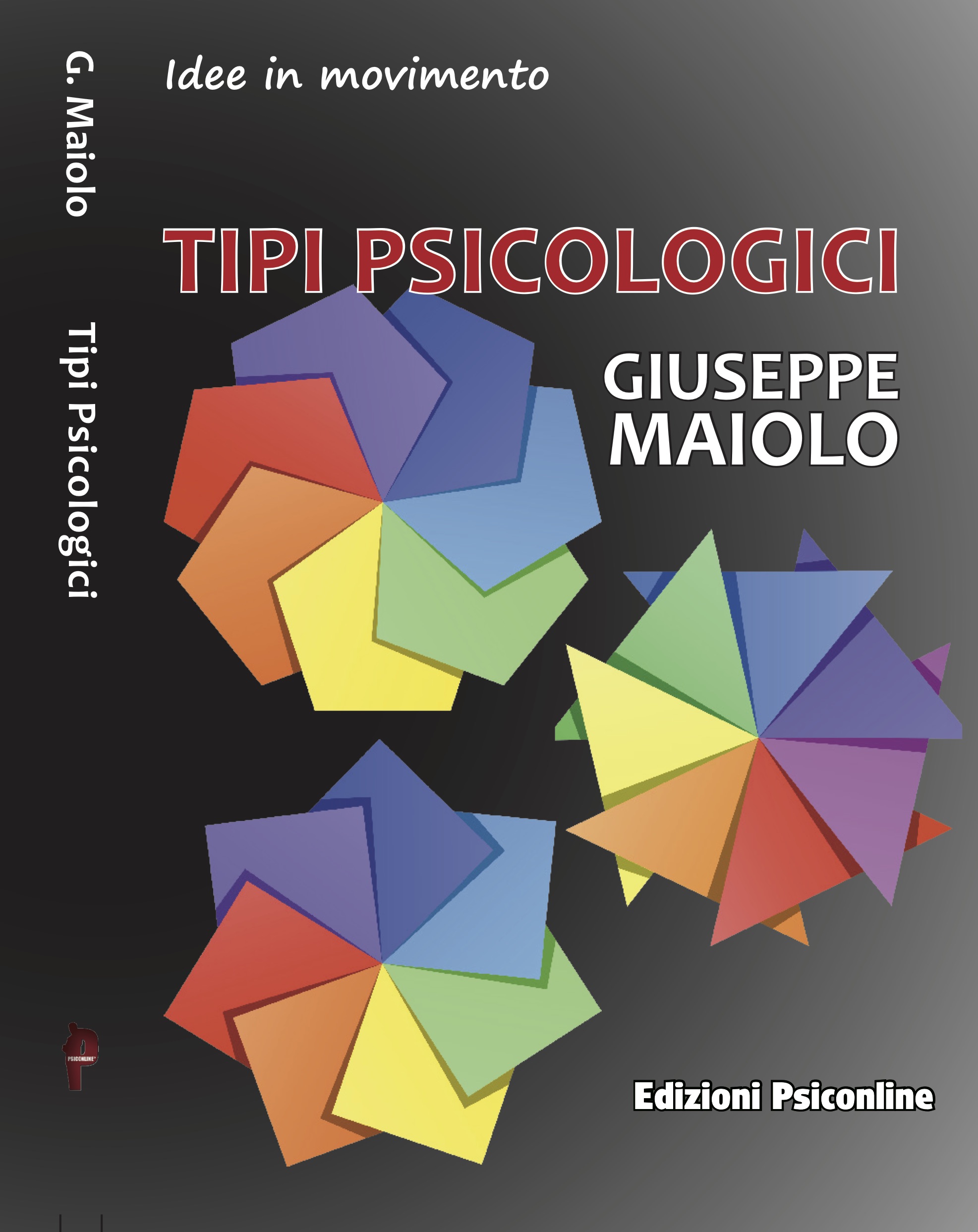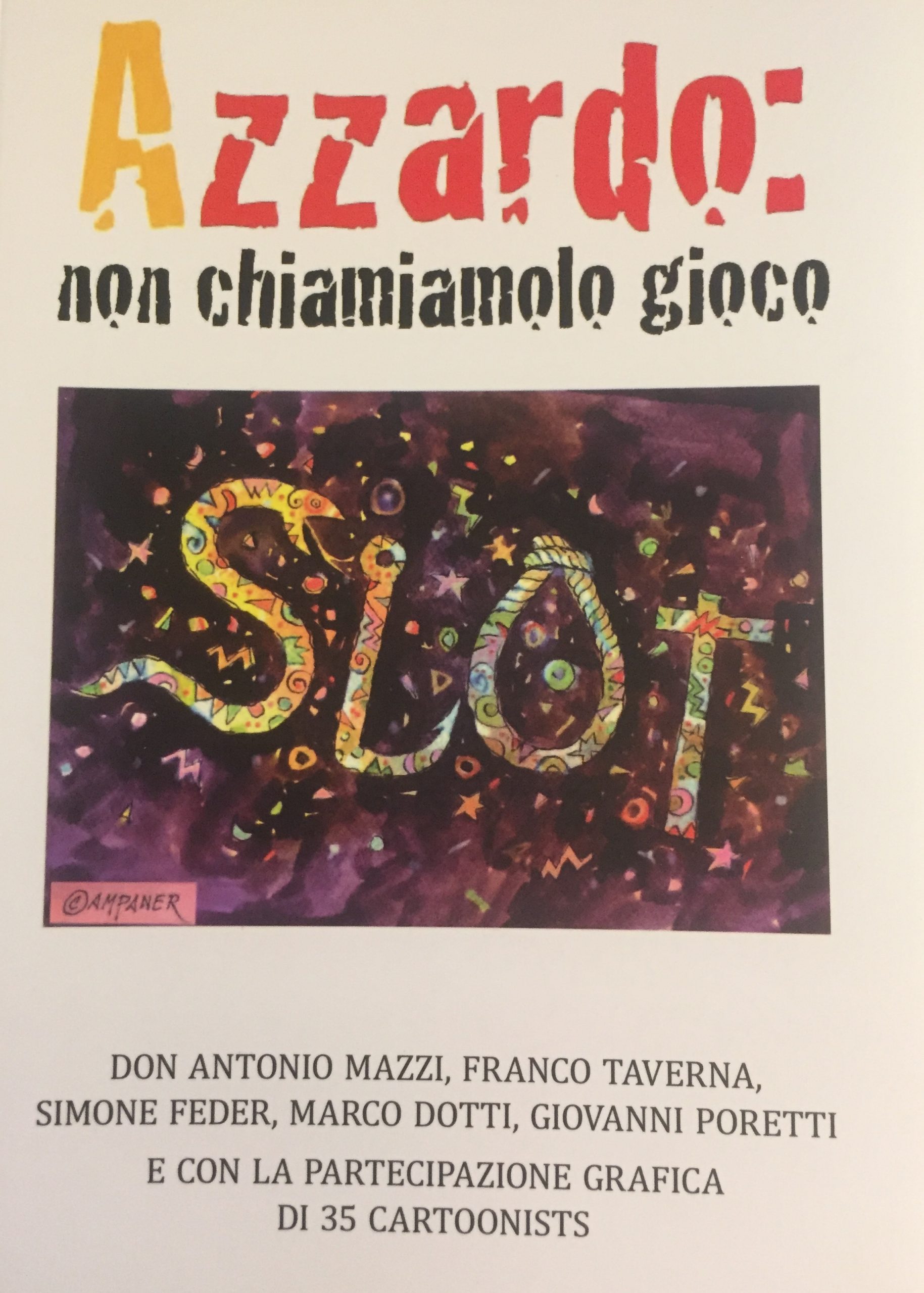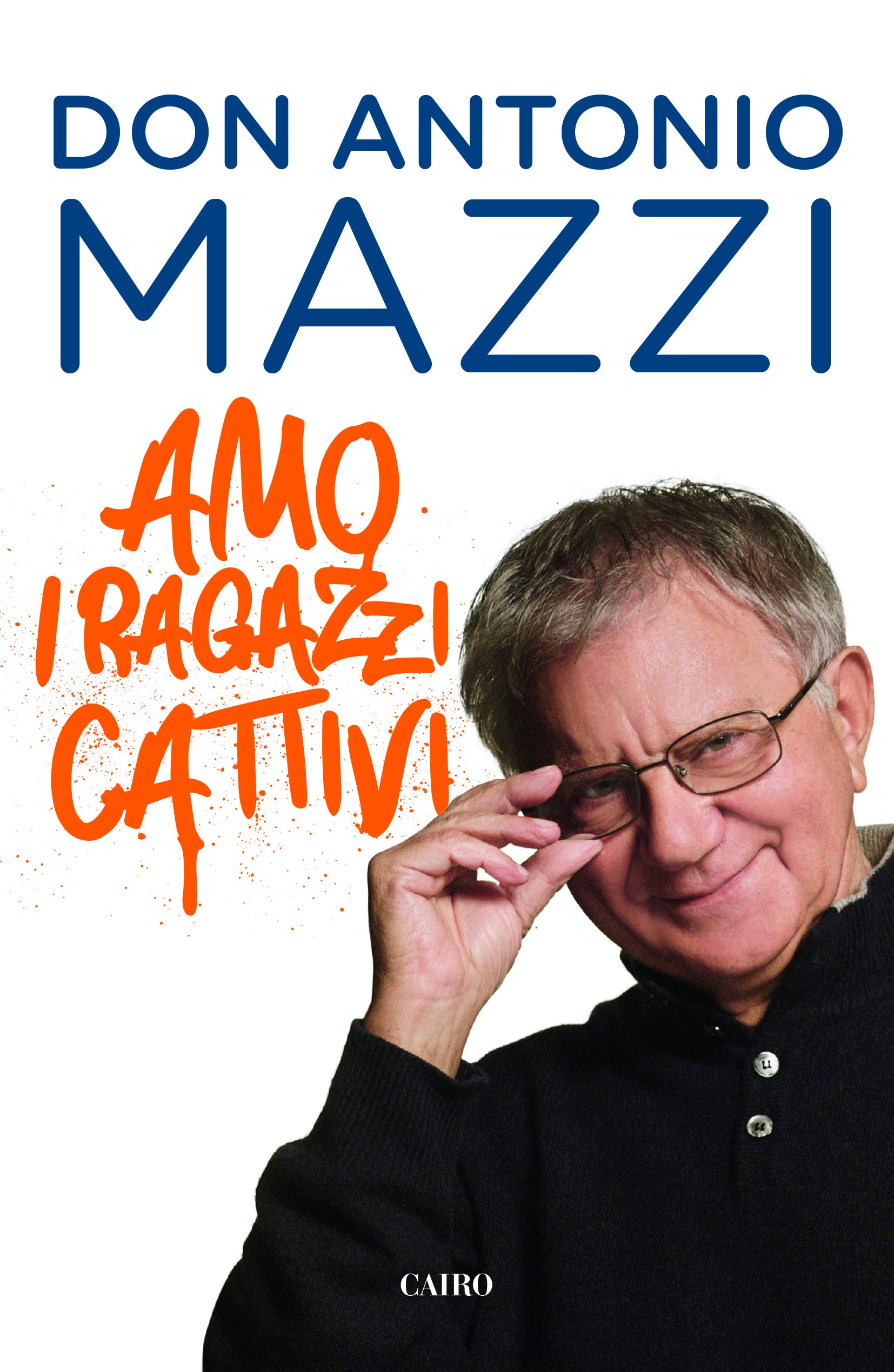Esplosioni di bombe, immagini di edifici distrutti, volti, lacrime. Bagliori di quella guerra che dal 24 febbraio di quest’anno ha invaso l’Ucraina, l’Europa, le nostre menti. Dalla scatola “cattiva Maestra”, che ormai condiziona le coscienze in quasi tutte le famiglie, gli spezzoni di una tragedia si alternano a trasmissioni infarcite da alterchi pseudo colti, spesso aggressivi e inutili esercizi egotici.
La sensazione che ne rimane per la gran parte dei comuni ascoltatori è spesso di una assoluta impotenza, una presa di coscienza del fatto che ormai manciate di potenti possono gestire la vita di miliardi di persone, in processi distillati in stanze oscure e lontane, cripte dove si celebrano culti alle divinità economiche con un’attenzione alle vite umane paragonabile a quella di un antiparassitario spruzzato su un gigantesco termitaio.
Che fare? mentre la bagarre tragica infuria, scagliando con forza centripeta milioni di persone lontano dai luoghi delle bombe e del terrore della morte, chi si accosta a questi temi con un barlume di spirito critico si guarda dentro cercando di “fare qualcosa”, per non sentirsi inerme spettatore schiacciato dagli eventi.

Secondo le Nazioni Unite 4 milioni di profughi ucraini, in poche settimane, sono fuggiti dalla guerra, lasciandosi tutta la loro vita alle spalle. Ma le guerre sono in tante parti del mondo e i numeri sono altissimi. Nel mondo, nel 2020 i dati dell’Alto Commissariato per i Rifugiati ci hanno raccontato di oltre 82 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa e la propria città per trasferirsi altrove; 48 milioni sono rifugiati “interni”; il 73% degli altri 42 milioni è accolto in Paesi confinanti; solo una piccola percentuale di richiedenti asilo riesce ad avvicinarsi ai confini dell’Europa, a seguito di un viaggio molto rischioso, che spesso porta morte e dolore.
Ognuno di noi è coinvolto, a suo modo, in queste guerre. Siamo interconnessi e se “una farfalla batte le ali a Pechino a New York arriva la pioggia invece del sole”. L’umanità dolente che trasmigra, arriva nelle nostre città, è fra noi, non è più la proiezione asettica della scatola magica, con i dibattiti, e i numeri delle statistiche.

È l’avvocatessa trentenne, Daryna*, che a pranzo, a casa mia, perché lavora come badante di una mia carissima amica, racconta del suo viaggio da Kiev, dove ha lasciato il marito, che fra poco dovrà arruolarsi. È partita soprattutto per quella figlia di sette anni che piangeva, sempre, per il terrore delle bombe e che finalmente ha ritrovato serenità, vive qui e si inserirà nelle scuole della nostra città. La giovane parla con occhi lucidi della generosa accoglienza di una famiglia, che ha risposto immediatamente alla sua richiesta di alloggio e che l’ha inserita subito nei contesti lavorativi.
È una garbata nonnina, Martina*, ultra novantenne, veneta, che incontro a Lio Piccolo, vicino Venezia. La rivedo con gioia, ero già stata qui l’anno precedente e l’avevo conosciuta mentre passeggiava nel suo giardinetto fiorito che costeggia la strada del paesino. È una dei pochi abitanti rimasti nel minuscolo Borgo e sta ospitando da qualche anno, come sua badante, una signora ucraina che adesso ha due figli arruolati per questa guerra e piange giorno e notte. La nonnina racconta, commuovendosi, della intensa sintonia con questa madre che vive nel dolore, perché anche Martina è madre e parecchi anni fa ha perso una figlia giovane. E ha conosciuto la guerra, era ragazza allora, è stato terribile, sperava che mai più sarebbe tornata…

Le porte dei privati si aprono per accogliere, come già si erano aperte per gli altri migranti. Ed è doveroso ricordare anche eccezioni a volte disgustose, in verità, come chi respinge i rifugiati che non siano del colore atteso. Per fortuna l’eccezione conferma la regola. La gente che assiste attonita e impotente alla follia della guerra può solo costruire reti interconnesse, reti di umanità, dove sentirsi viva perché d’aiuto a chi soffre, dove ritrovare la pietas e la consapevolezza del proprio esistere, attraverso la solidarietà.
Solo questo può salvarci dalla disperazione e dalla sfiducia nel futuro. Dobbiamo avere cura di noi, della nostra resilienza a questo stress che ci travolge e da cui potremmo non avere scampo.
Quale cura può essere migliore del prendersi cura di chi arriva? Potremmo essere noi, domani, a dover lasciare la nostra terra, la nostra casa e cercheremmo come adesso fanno loro, cura e serenità. Se la speranza dovesse abbandonare il cuore dell’uomo, allora davvero per questa umanità non ci sarebbe salvezza.

Invece ancora nascono i gruppi per la raccolta di beni di prima necessità, in tutte le città, a vari livelli. E iniziative, tante, di Enti e Associazioni, tese a favorire l’integrazione nei contesti sociali per le persone che arrivano. Ancora gli umani sentono la necessità di intrecciare reti di generosità, di ritrovare il filo che ci lega gli uni agli altri. Tutti.