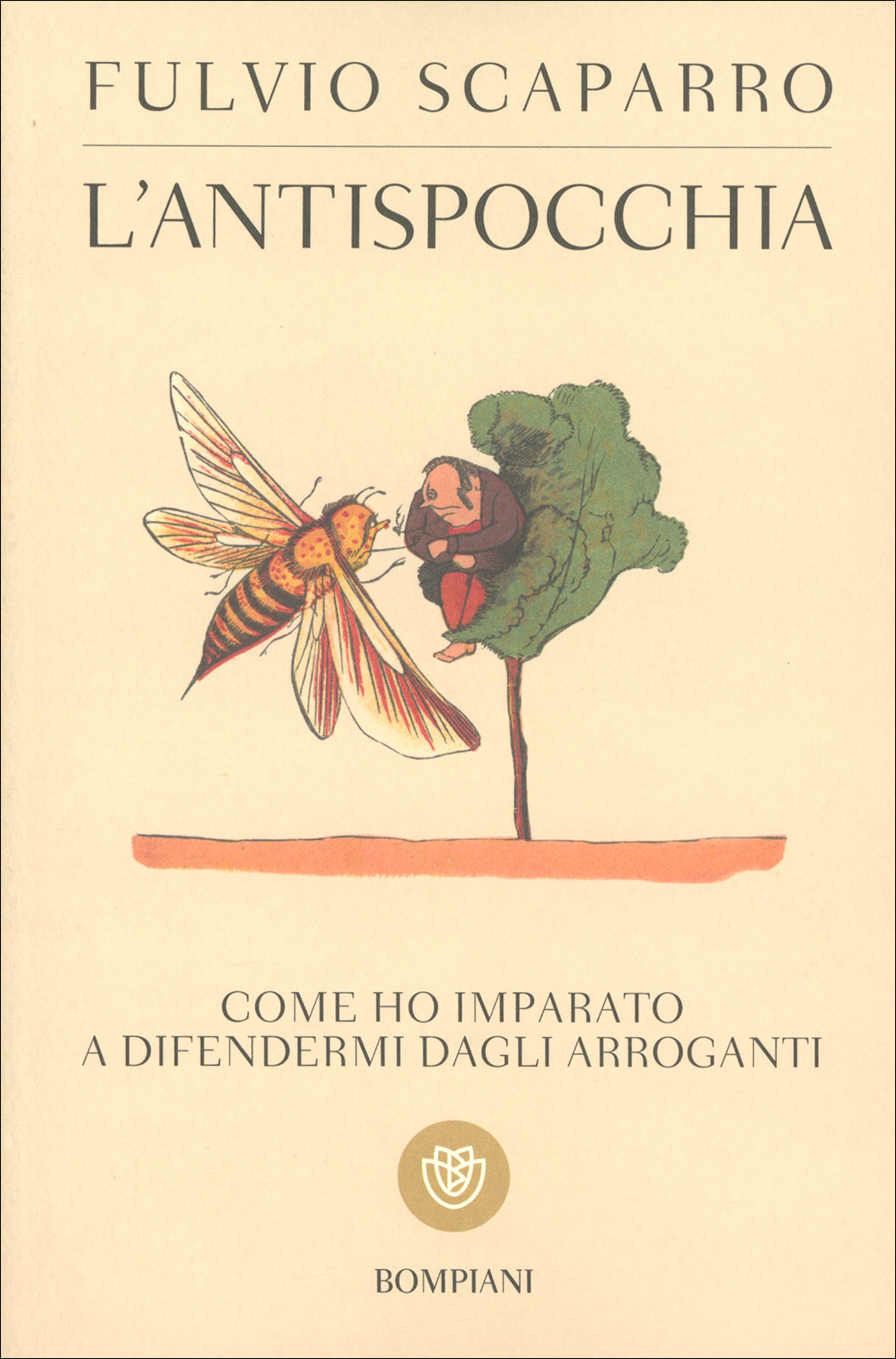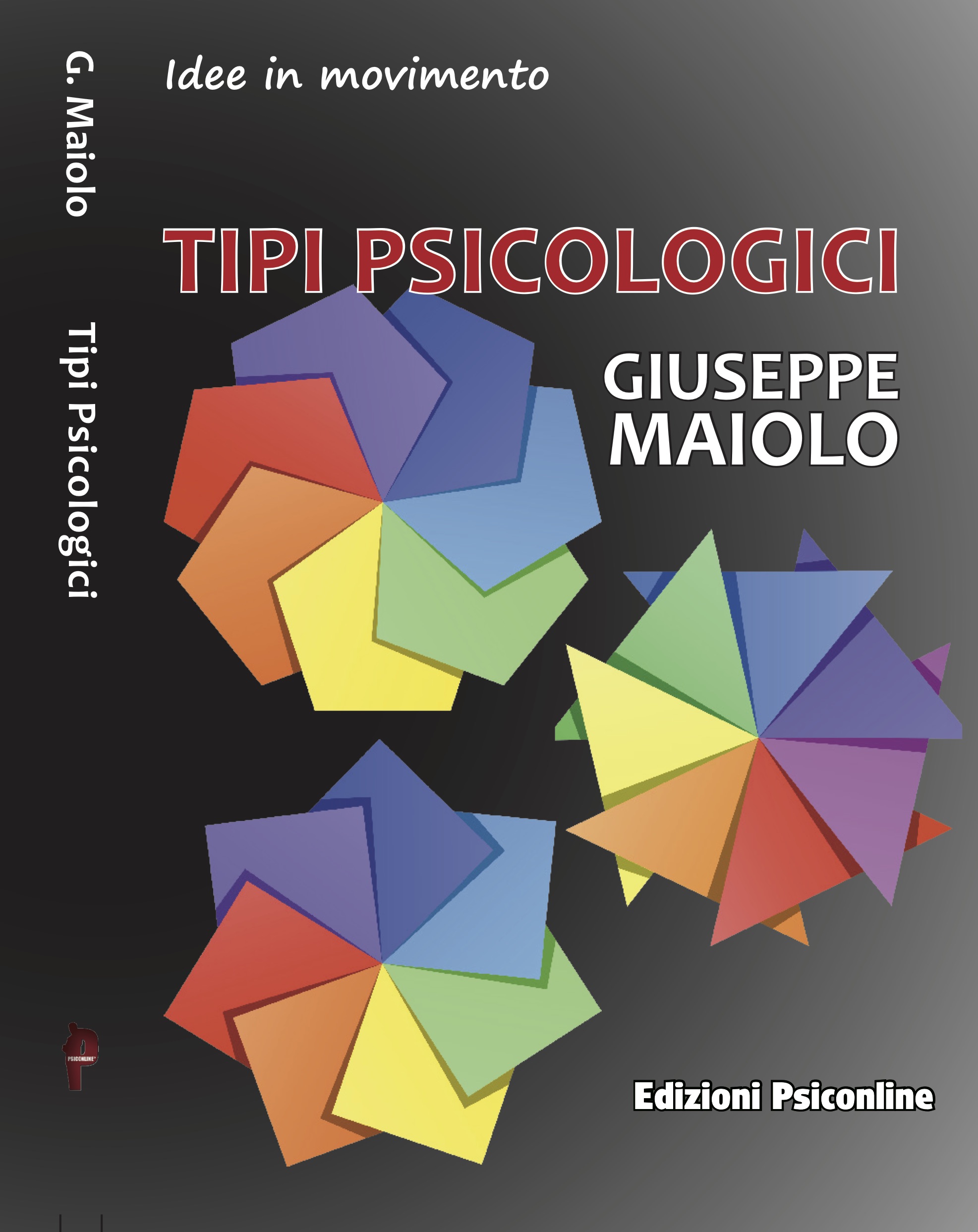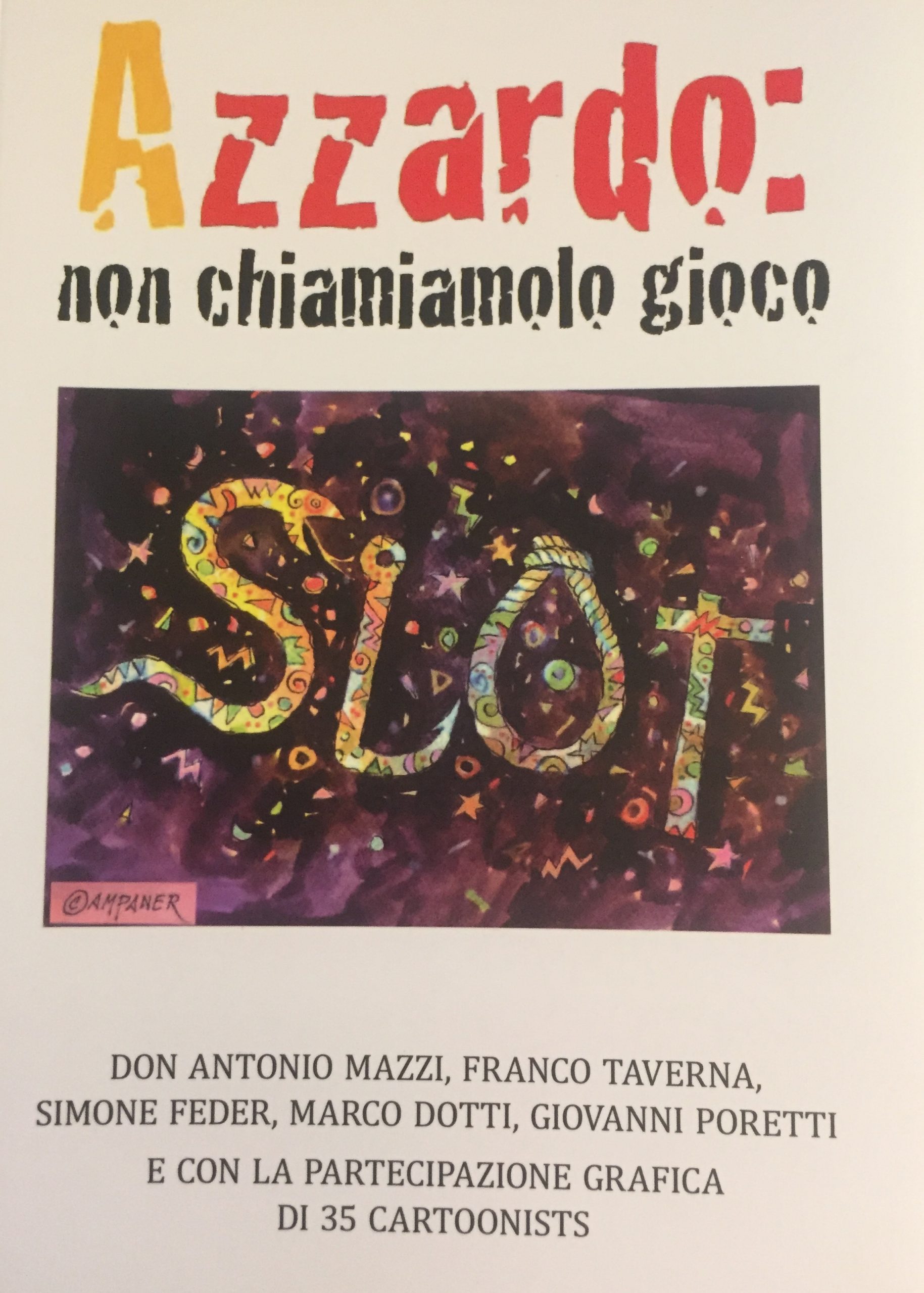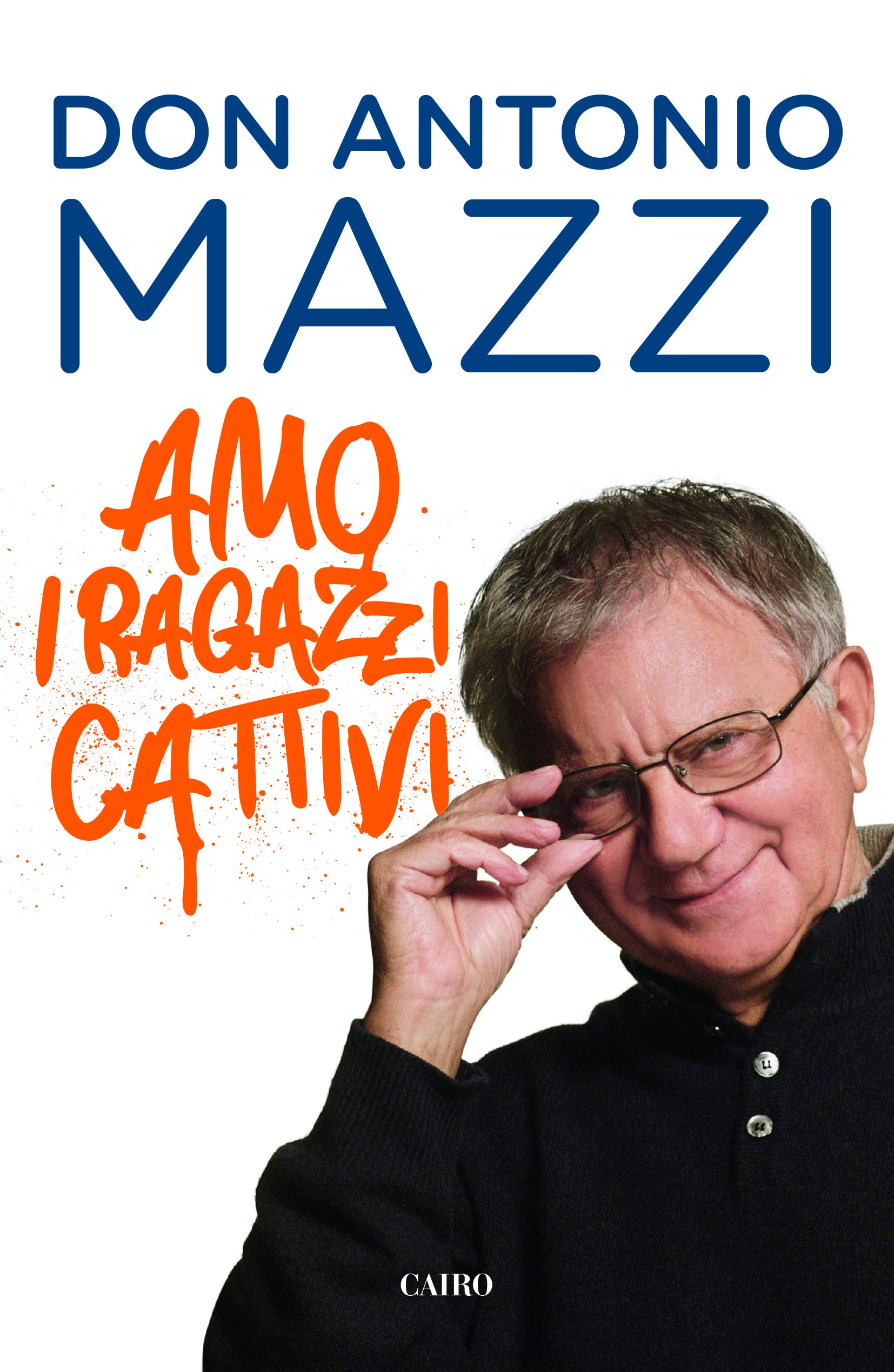Il 27 gennaio si ricorda la “scoperta” del campo di concentramento di Auschwitz: l’armata russa e tutto il mondo capirono l’orrore, forse se ne resero conto soltanto allora, o forse molti sapevano e avevano taciuto, per vigliaccheria, per paura, per indifferenza.
Ma non c’era stato un solo campo di concentramento: a circa 80 chilometri da Berlino, a Ravensbruck, nascosto in un bosco lussureggiante, i nazisti, su un terreno di proprietà probabilmente di Himmler – colui che credeva di essere la reincarnazione di Enrico I di Sassonia e che diceva di sé “sono un boia senza pietà” – costruirono un campo di lavoro destinato esclusivamente alle donne. Si ritrovarono lì non soltanto donne ebree, ma anche oppositrici politiche, zingare, disabili, asociali, prostitute e lesbiche, testimoni di Geova provenienti dai territori nemici, dunque anche dall’Italia. Se “imperfette”, erano eliminate crudelmente perché considerate “indegne di vivere”, per seguire cioè un dettame “umanitario” che imponeva di evitare il deterioramento dell’intera nazione e la contaminazione della razza.
In genere, secondo quanto soltanto nel 2003 ha rivelato il giornalista Gustavo Ottolenghi, donne e uomini, prigionieri politici italiani, venivano prima condotti nel campo di Vallecrosia, piccolo comune in provincia di Imperia, poi a Fossoli, successivamente a Ravensbruck, infine a Bergen Belsen.
Sono state tre studiose liguri –Laura Amoretti, Donatella Alfonso e Raffaella Ranise – a fare ricerche su Ravensbruck e a scoprire che il campo fu liberato il 30 aprile 1945, ma se ne ebbe notizia dopo il 1989, anno della caduta del Muro di Berlino e nel 1995 fu possibile accedervi, dopo che i russi lo avevano abbandonato. Grazie a documenti e testimonianze dirette di sopravvissute o ai racconti delle loro figlie, Amoretti, Alfonso e Ranise sono riuscite a raccogliere notizie su quel luogo di dolore e di morte, dove le donne erano private di tutto, offese, umiliate, rese sterili, anche se erano delle ragazzine. Se poi avevano dei figli, a questi non toccava una sorte migliore…Le Aufseherinnen, cioè le guardiane, perfette esponenti ariane, erano capaci di furia bestiale, violente e arroganti, così le mediche, i medici, i carcerieri. Le donne sane venivano sfruttate come operaie, perché nel campo erano state aperte due fabbriche, la Texled e la Siemens.
Dal 1943 la Croce Rossa e il filantropo conte Bernardotte si adoperarono per fare arrivare al campo dei pacchi viveri.
Le donne, nonostante tutto, non cedettero al male, seppero creare amicizia e solidarietà, si aiutarono a vicenda, adottarono i bimbi superstiti dopo la morte delle loro mamme, furono persino capaci di realizzare un piccolo spettacolo teatrale e di scrivere poesie.
Per questi motivi le tre studiose hanno scelto come sottotitolo per il loro libro “Destinazione Ravensbruck” l’orrore e la bellezza nel campo delle donne.
Naturalmente, hanno raccontato anche il disagio ulteriore delle prigioniere italiane considerate dalle altre poco affidabili, hanno parlato di prigioniere dai cognomi noti, come Geneviève, nipote del generale De Gaulle, e Milena Jesenska, amante di Kafka e del documentario “Le rose di Ravensbruck. Storie di deportate italiane” realizzato nel 2005 dalla figlia della deportata Mirella Stanzione.
Di tutto questo e di tanto altro hanno parlato durante un webinar le tre autrici agli iscritti al Corso “La letteratura del ‘900: memoria, anniversari, linguaggi” presso l’Università della terza età e del tempo disponibile di Trento e Cavalese.
A conclusione dell’incontro, io stessa, che ho voluto condividere con i miei studenti questa esperienza, ho letto una poesia scritta da Catherine Roux, internata nel campo e liberata il 5 maggio 1945:
Mio Dio, non ho più vestiti addosso,/non ho scarpe/non ho borsa, portafoglio, penna,/non ho più nome. Sono stata/etichettata 35282./ Non ho i capelli/non ho più un fazzoletto,/non ho più foto di mia mamma/e dei miei nipoti,/non ho più l’antologia in cui,/ogni giorno, nella mia cella di Fresnes,/ho imparato la mia poesia,/non mi è rimasto niente./Il mio cranio, il mio corpo, le mie mani/sono nude.
La memoria è un dovere, lo dobbiamo a chi non ha più la possibilità di raccontare.