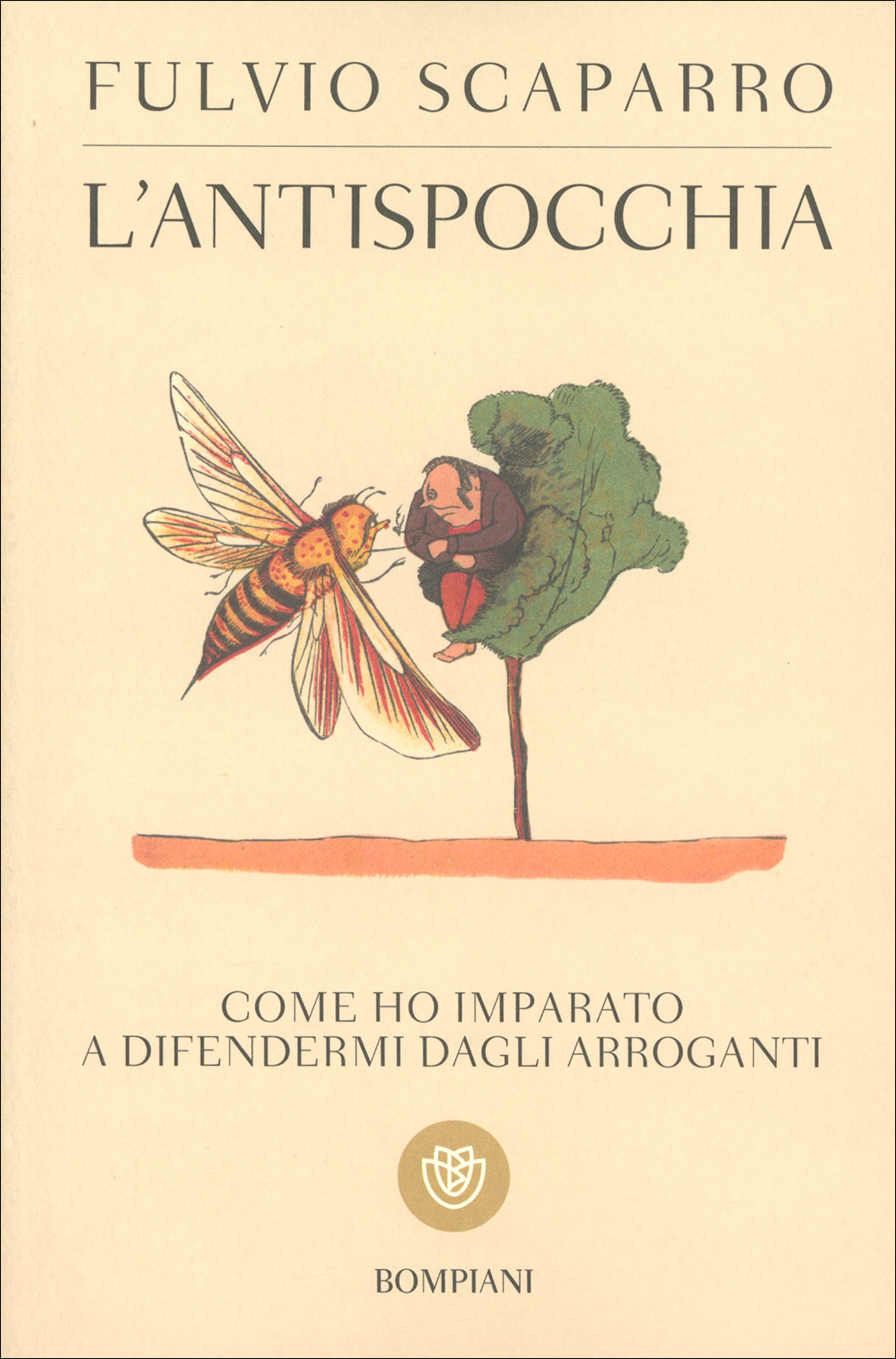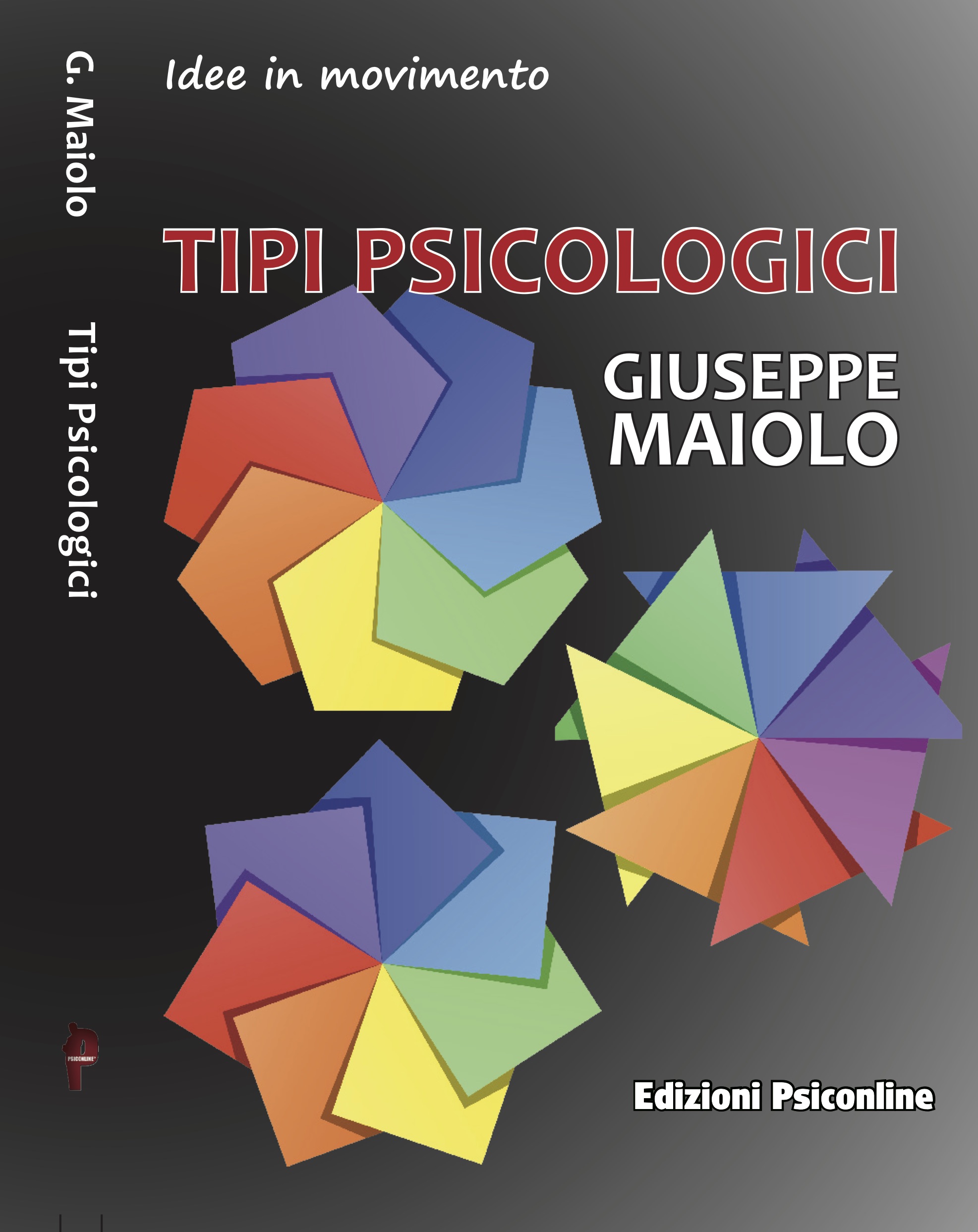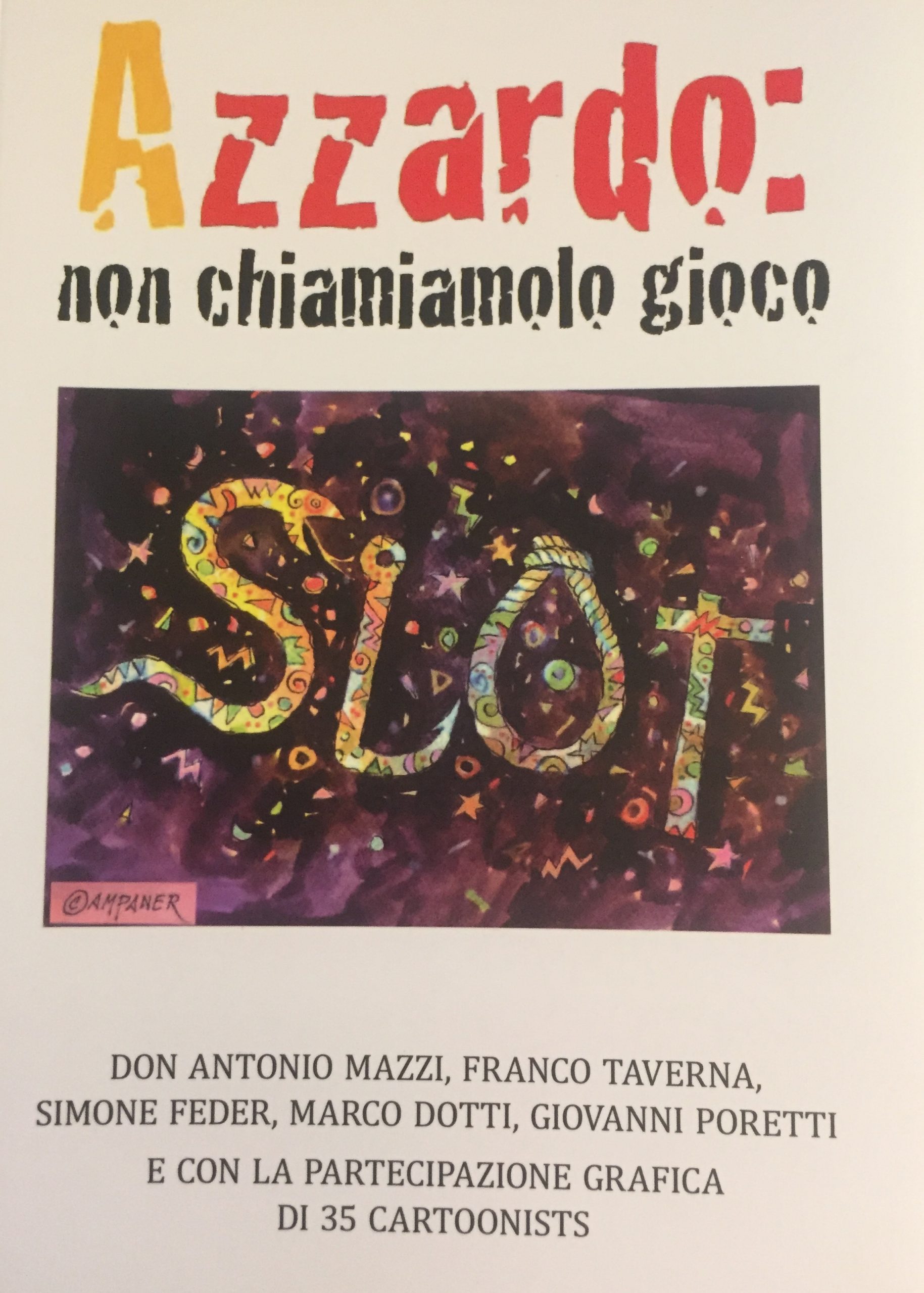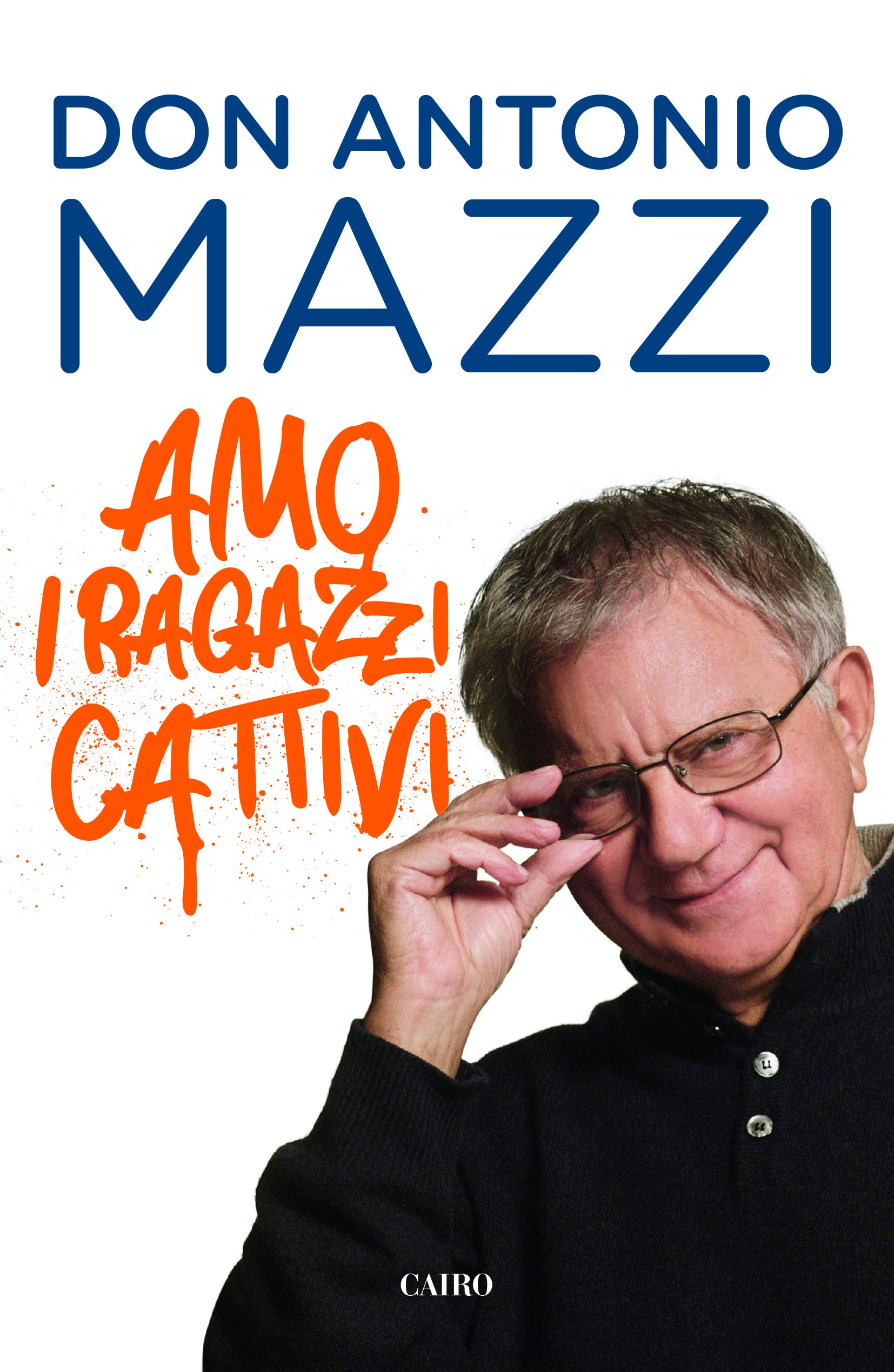La Comunità
Riprendo il mio articolo sul Blog di giugno, “La rivoluzione del ’68: la mia esperienza alla Comunità di Capodarco, per soffermarmi sull’innovazione che il modello comunitario proposto dal Movimento di Capodarco, portò nella società e nel mondo della disabilità.

Gli anni 70/80 furono anni rivoluzionari in tutti i ceti sociali, e le persone disabili attraverso un percorso di formazione nel modello comunitario, fondarono tante piccole comunità in tutta Italia; comunità composte da persone disabili fisiche, mentali, caratteriali e persone cosiddette “sane”. Le comunità nascevano velocemente spesso nel luogo d’origine degli stessi comunitari che tentarono di portare lo spirito e la loro esperienza nel loro territorio.
Le storie erano di varia umanità, che si intrecciavano l’un l’altra nel riconoscersi e ritrovarsi a vivere insieme, fino a che non si comprendeva più chi era il disabile fisico e chi era il sano.
Per assurdo, ma neanche tanto, erano le persone disabili fisiche ha diventare cura, per chi, “sano” si era avvicinato a loro, la definirei una “cura personalizzata”.
Intendo dire che le persone sane si avvicinavano ad un disabile che aveva con lui delle affinità e viceversa il disabile si approcciava al sano che più gli era congeniale. Spesso era la rabbia il denominatore comune che avvicinava sani e disabili.
Per paradosso ciò che ha reso rivoluzionario il modello comunitario ovvero la condivisione era allo stesso tempo il fattore più difficile da realizzare.
Condividere la propria vita era in realtà l’aspetto più difficile da vivere, e a mio modo di vedere lo è ancora.
La vita nelle comunità non era e non è facile: ogni persona disabile e non, che ne viene a far parte, porta con sé oltre il suo handicap anche un bagaglio di frustrazioni, di costrizioni, di esperienze negative e una buona dose di emarginazione; a questo si aggiungono le naturali difficoltà di convivenza di persone fino a quel momento estranee, con il proprio carattere, le proprie abitudini e altro.
Ad esempio: persone sole che approdano alle comunità provenienti da una vita individualistica, a volte ripiegata su di sé, trascorsa talvolta in istituzioni, gestite soprattutto da religiosi, dove l’handicappato trascorre buona parte del suo tempo a superare solo le difficoltà dovute all’handicap; oppure persone con problemi giudiziari, persone abbandonate, disagiate, genitori che non volevano figli con disagio mentale, spesso violenti, donne uscite dalla prostituzione, persone con storie di vita sempre “oltre” e così via.

Queste persone si unirono per scelta libera e/o per opportunismo a persone di diversa disabilità e/o a volontari per condividere la vita insieme, come la comunità aveva loro insegnato.
Le dinamiche del quotidiano con relazioni così intense e inconsuete erano molto forti a tal punto da mettere in discussione la propria esperienza ed educazione, soprattutto per chi veniva invece da una famiglia “cosiddetta normale”.
L’unico che sembrava essere a suo agio era mio padre, ed io ne ero sconvolta e allo stesso tempo orgogliosa, durante quell’esperienza, per lui l’handicap degli altri pareva non esistere, si dava da fare in comunità volendo aiutare tutto e tutti, era sempre allegro, parlava tanto ed era sempre “di compagnia”, ora non sembrerebbe così un atteggiamento strano, se non fosse che sembrava un altro uomo. Mio padre a casa, era un uomo taciturno, silenzioso anche con me, tanto da farmi pensare che mi rifiutasse, non frequentava compagnie e l’aspetto pratico lo lasciava a mia madre, lui lavorava come avvocato e basta.
La voglia di vivere
Ma a Capodarco si rivelò, da allora non detti più per scontato mio padre, debbo alla comunità anche questo.Nell’estate del 1975 durante un campo di studio e lavoro, eravamo in un’assemblea dove ognuno di noi, nuovi arrivati, si presentava e al quale veniva assegnato da Don Vinicio Albanesi, attuale presidente della comunità, un incarico necessario alla gestione del campo.

Io “annaspavo”, la mia scuola speciale mi aveva indirizzato lì per fare un’esperienza di vacanze fuori casa, tutto intorno a me mi sembrava un mondo nuovo di cui io non facevo parte e che cercavo di comprendere il più velocemente possibile. Gli altri disabili mi sembravano “marziani”, fino ad allora l’incontro con “i miei compagni di viaggio” era stato rassicurante, all’interno della scuola o di associazioni affini, ma a Capodarco tutto ciò veniva messo in discussione. Giovani uomini e ragazze: capelloni, mezzi nudi, fumatori e fumatrici incalliti, giovani disinibiti dal gergo triviale, musica e chiacchiere ad alto volume.
Il silenzio non esisteva, l’energia e la voglia di vivere era palpabile.
Successivamente fui invitata alla Comunità “La Buona Novella” di Fabriano, ero andata in precedenza a Capodarco a ritrovare amici dopo l’estate, Don Graziano, responsabile dei comunitari che volevano conseguire un diploma, mi disse: ”Fai un salto a Fabriano così puoi fare la maturità”.
Io andai e notai subito i lati positivi, c’era un grande cortile con una vasca con tanti pesci e poi una tettoia per quando pioveva e panchine di pietra qua e là, e poi verso la fine del cortile c’era un altro grande riparo con un albero di cachi immenso: era tutto accogliente al massimo; ma la parte più bella era la cucina, grande tanto che ci si poteva incontrare e stare lì a chiacchierare, quante nottate in cucina, con spaghettate alle 3 di notte, insomma luoghi aperti, accoglienti, dove anche le persone disabili potevano vivere una vita dignitosa ed anche libera rispetto ad istituti, case di cura o famiglie iperprotettive.
A Fabriano ho studiato e a Gubbio ho conseguito la maturità magistrale insieme ad altri comunitari.
Credo che sia stata l’esperienza più arricchente che si possa fare nella vita e come succede nei ricordi belli e lontani, tutta l’esperienza è stata stimolante al massimo, quindi mi perdonerete se in alcuni momenti, vi parrò poco obbiettiva ed aulica nel ricordo.
Certo la vita comunitaria, aveva delle regole, non scritte ma dibattute in riunioni, dove si esprimevano le difficoltà ed i progetti.
La vita comunitaria e la condivisione

La comunità dava molto ma voleva altrettanto, certo che un luogo che “ti rende persona” richiede, a chi desidera essere protagonista della sua vita, una presa di coscienza di sé e della possibilità di cambiamento in meglio della propria vita, quindi oltre ad avere dei diritti richiedeva anche dei doveri, uno fra i quali: LA CONDIVISIONE.
Questo bisogno veniva espresso fin dai primi giorni in comunità sia nell’assemblea sia nella vita pratica, i disabili, che si potevano muovere un pochino meglio, aiutavano chi era maggiormente in difficoltà, ad esempio imboccandoli, senza fargli pesare niente, oppure chi aveva una mano sana aiutava chi non ne aveva nemmeno una, ma la cosa principale è che nessuno doveva far pesare all’altro il suo impegno, ad esempio chi aveva qualche soldo in più, poteva portare qualche dolce che altri non potevano acquistare.
Chi sottolineava la necessità del suo aiuto veniva subito ripreso.
Approfondendo il concetto di CONDIVISIONE, intendo dire che essa non era un gesto momentaneo, dettato solo da buoni sentimenti, ad esempio un servizio che una persona sana offriva ad un disabile come a sanare una sua parte mancante, ad esempio portandolo occasionalmente al bagno, o a un concerto. Ma faceva parte di un sistema di vita che coinvolgeva tutti i comunitari: praticamente, emotivamente e spesso affettivamente.
Mi viene alla mente che i volontari quando si creava un’occasione di divertimento, al di fuori della comunità: come un cinema o andare a ballare o andare a socializzare con l’altro sesso, non chiedevano la compagnia solo dei normodotati ma principalmente venivano coinvolti le persone disabili, non c’era quella distinzione che si viveva all’epoca ed ancora oggi si percepisce nell’aria. Questa era la vera rivoluzione.
Ed anche quelli che erano lontani dalla condivisione comunitaria per formazione ed educazione, giorno per giorno attraverso la vita pratica, che portava successivamente anche a confidenze e a rapporti d’amicizia, venivano coinvolti fino ad esercitare loro stessi la pratica della condivisione.
Mettere in comune lavoro, denaro, conoscenza, partecipazione e, non meno importante il dolore vissuto, portava a condividere una vita intera e spezzava la solitudine di molti, non solo disabili. Non è un caso che nacquero i primi matrimoni “misti” in comunità: fra sani e disabili, e tradizionali fra disabili e disabili, volontarie e volontari, tutti matrimoni spesso con bambini, che io per mia fortuna ho visto spesso felici.

Inoltre in quegli anni ho conosciuto disabili diventare genitori così in gamba, da desiderare di averli avuti io.
In particolare una donna che viveva sdraiata su una carrozzina con il cuore seriamente malato, senza muovere un dito, rimase incinta, le furono detti i rischi del parto, lei decise di portarlo a termine, il bimbo nacque e divenne “il bambino di tutti, il bambino della comunità”.
Quando precedentemente ho scritto che la propria esperienza ed educazione, veniva messa in discussione, soprattutto per chi veniva invece da una famiglia “cosiddetta normale”, penso a me stessa, ragazza disabile, insicura e con una timidezza proverbiale e a Mirco ragazzo sano, lavoratore bergamasco; incontrare Mirco, anche lui con una voce da tenore, e “sentirmi al sicuro” fu immediato, sensazione di cui ho goduto come altri nei decenni a seguire.
Mirco racconta:
” Quando arrivò Don Sandro Bianchi Cassina nella parrocchia dove vivevo, trovò un gruppo di adolescenti e di giovani tra i 15 ed i 22 anni che frequentavano settimanalmente la casa di riposo per anziani del quartiere. Avendo capito che il nostro gruppo era sensibile alle problematiche sociali, ha iniziato a stimolarci proponendoci varie esperienze in quel campo. In particolare ci avvicinò al mondo dei disabili, che a quei tempi venivano chiamati anche con il termine di handicappati.
Nell’estate del 1973 ci ha proposto di fare un’esperienza molto particolare e ci ha portato a fare un campo di lavoro estivo nella ***Comunità di Capodarco di Fermo nelle Marche. Per il nostro gruppo di giovani è stata un’esperienza inizialmente scioccante, ma stimolante e nello stesso tempo coinvolgente. Abbiamo potuto toccare con mano la miseria umana, culturale e sociale che molti degli ospiti avevano alle loro spalle, nonché le difficoltà concrete che le persone disabili avevano ad inserirsi nella società, perché escluse dal mondo del lavoro e spesso anche dal contesto sociale del proprio paese o città di residenza.
Descrivere tutte le attività che abbiamo fatto durante l’esperienza del campo, dal lavoro manuale, ai servizi di corvè, alla formazione, all’informazione, ma soprattutto l’entusiasmo, la voglia di fare di noi giovani, insieme con le persone disabili, il confrontarsi sulle problematiche sociali, la voglia di vivere delle persone, molte delle quali per anni avevano vissuto, specialmente nel meridione, situazioni di emarginazione e segregazione, è abbastanza difficile perché è molto complicato mettere nero su bianco le sensazioni, le gioie e le sofferenze vissute in quell’esperienza di condivisione così importante e formativa per me.
Il progetto della Comunità di Capodarco fu molto innovativo per l’epoca.

Per come avevo vissuto questa esperienza e per quello che ha smosso dentro di me, al ritorno ho iniziato il mio impegno fuori dall’oratorio e mi sono coinvolto nel volontariato sociale. Conoscere l’esperienza di Capodarco, la sua organizzazione, lo stile essenziale di vita, mi ha molto coinvolto e così appena potevo nei fine settimana, nei vari ponti festivi, o durante le ferie, ecc.… ritornavo in quella realtà per viverla sempre più intensamente e per ricaricarmi. Nel marzo del 1977 ho lasciato la mia famiglia a 27 anni e mi sono aggregato ad un gruppo di persone che avevano deciso di lasciare la Comunità madre di Capodarco, per fondare una succursale nuova in Lombardia prima ad Endine e poi a Bergamo, coinvolgendomi totalmente nel progetto comunitario.
Fare vita di comunità ha voluto dire mettere tutto in comune, in base alle singole possibilità sia fisiche e sia economiche di ogni persona, disabili compresi. Praticamente tutte le risorse economiche, per la verità poche, venivano messe in una cassa comune e insieme si affrontavano le scelte di vita e le relative spese per la sussistenza di tutte le persone che vivevano al suo interno. Come si può ben immaginare la vita in quel “caravanserraglio” era abbastanza complicata, insomma i problemi non mancavano, da quelli economici a quelli relazionali, tipici della convivenza tra persone provenienti da mondi ed esperienze di vita molto diverse.
Alcuni avevano imparato un lavoro manuale, pur con tutti i limiti fisici che molti di loro avevano: come lavorare il rame, realizzando oggetti vari, mentre le donne dipingevano tessuti con la tecnica del batik e della serigrafia. I lavori poi venivano commercializzati tramite mostre, fiere, od altre iniziative, il ricavato, unito alle pensioni di invalidità delle persone handicappate, serviva per l’acquisto del materiale da lavoro, oltre che per la sussistenza della vita comunitaria.
Alla fine degli anni ’70 abbiamo cominciato a desiderare di avere una struttura più piccola ma tutta nostra per essere completamente autonomi ed indipendenti. L’edificio lo abbiamo trovato alla periferia nord di Bergamo, una piccola cascina dismessa che abbiamo acquistato e ristrutturato. Abbiamo fondato una cooperativa che abbiamo denominato: Comunità Lavoro Autogestione Servizi (CLAS), questo il significato del nome: Comunità: scelta di vita, condivisione; Lavoro: che si sostiene con il proprio lavoro; Autogestione: vivendo del proprio lavoro è autonoma e si autogestisce senza l’intervento di enti pubblici; Servizi: all’interno della comunità si svolgevano attività di assistenza e fisioterapia per le persone disabili ed altri servizi sociali per il quartiere.
Nel 1984 ci siamo ristrutturati scindendo la vita comunitaria da quella lavorativa. Abbiamo così fondato l’Associazione Bianzanella per gestire la Comunità e tutti gli aspetti burocratici amministrativi delle persone in essa coinvolte, mentre la cooperativa si è occupata della parte lavorativa.
In quest’esperienza nella quale mi ero coinvolto completamente nonostante le varie difficoltà di convivere con persone diverse, mi sentivo vivo, realizzato, responsabile, tanto che sin dall’inizio con il consenso di tutti ho preso in mano la cassa comune, con tutte le responsabilità che questo incarico comportava, in un momento che di soldi ne giravano pochi. Io ho vissuto tutte le fasi di questa avventura in prima persona, ed insieme ad Alberto (deceduto per tumore nel 2007), mi sono occupato di tutti gli aspetti burocratici, amministrativi e commerciali prima della Comunità e poi della cooperativa di lavoro e alla bisogna, quando il lavoro era molto, andavo anche in produzione.
La vita della Comunità è continuata, se non ricordo male, fino al 2008/2009 quando si è conclusa, fondamentalmente perché è venuto a mancare l’asse portante della Comunità, Alberto”.

La nostra rivoluzione
Ecco, cari amici ed amiche, attraverso Mirco, che ringrazio per aver contribuito con la sua testimonianza ed alcune fotografie, vi ho introdotto con un altro breve spaccato di esperienze e vissuti nel movimento delle comunità di Capodarco di Fermo, perché la storia è fatta da tutti, quotidianamente.
Questa è stata ed è: la “nostra rivoluzione”. Lo spirito comunitario insegna a tutti, uno per uno ad essere protagonista della propria storia ma anche della storia di tutti, in questo è molto formativo soprattutto attualmente, dove la sfiducia nel cambiamento porta all’individualismo e all’immobilismo.
Mirco Perini ora, è un uomo di 68 anni, la sua esperienza di vita ha contribuito a fare di lui un uomo protagonista della società e del suo territorio, attraverso battaglie sociali e partecipazione politica. Dopo aver lasciato le comunità è stato sindaco ed assessore della sua cittadina.
Io stessa ho portato nella mia vita lo spirito della comunità, pur non facendone parte da moltissimi anni, l’ho condiviso con persone alle quali voglio bene, alla cerchia degli amici, al mio quartiere, alla mia città, al mondo intero. Sono una bambina nata nel dopoguerra, ragazza ribelle e rivoluzionaria degli anni ’70, psicologa negli anni ’80, artista da sempre, donna matura negli anni 2020, ritenuta elemento di spicco della fascia dei deboli rispetto al COVID…
SONO UNA DI VOI