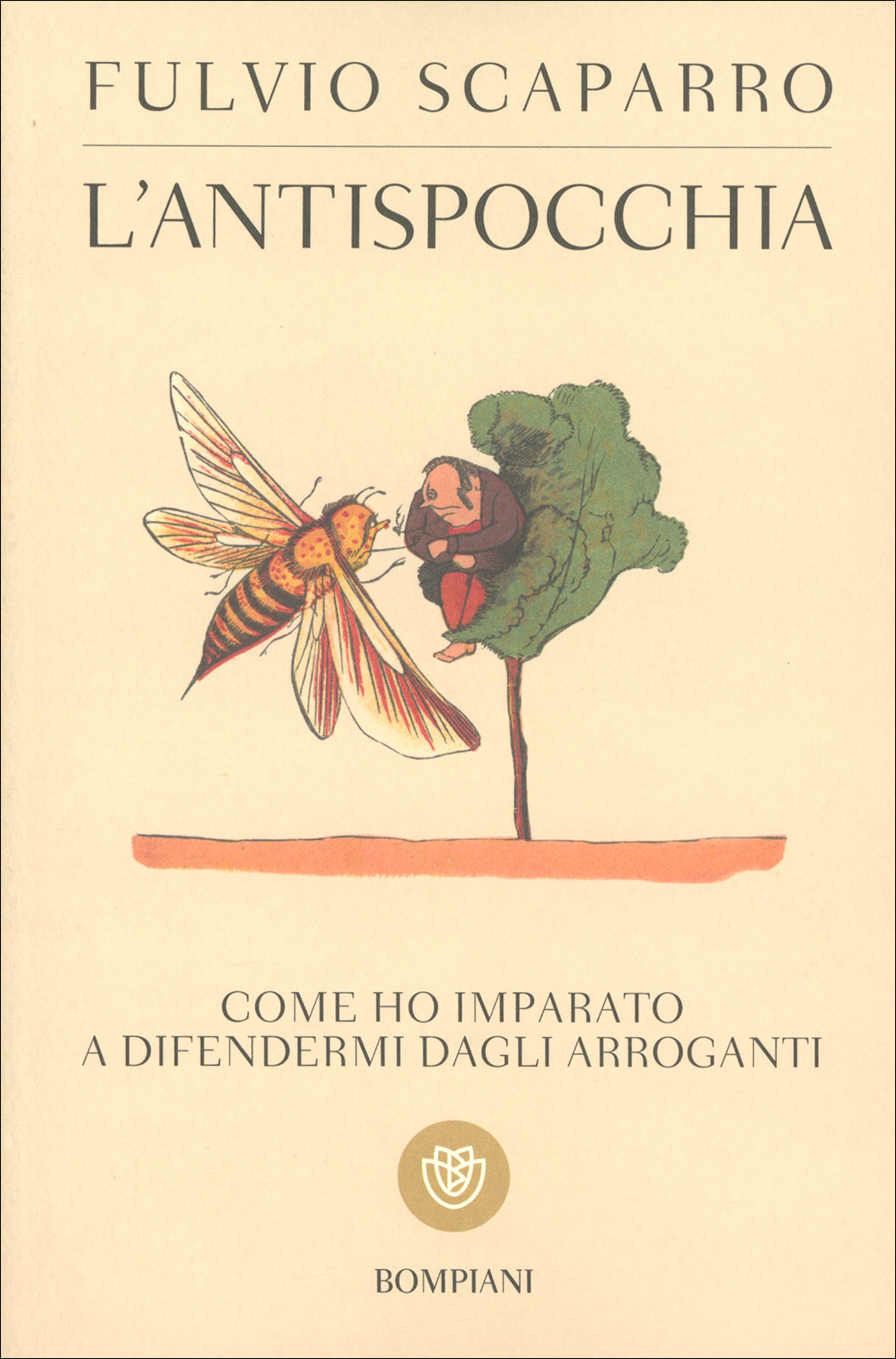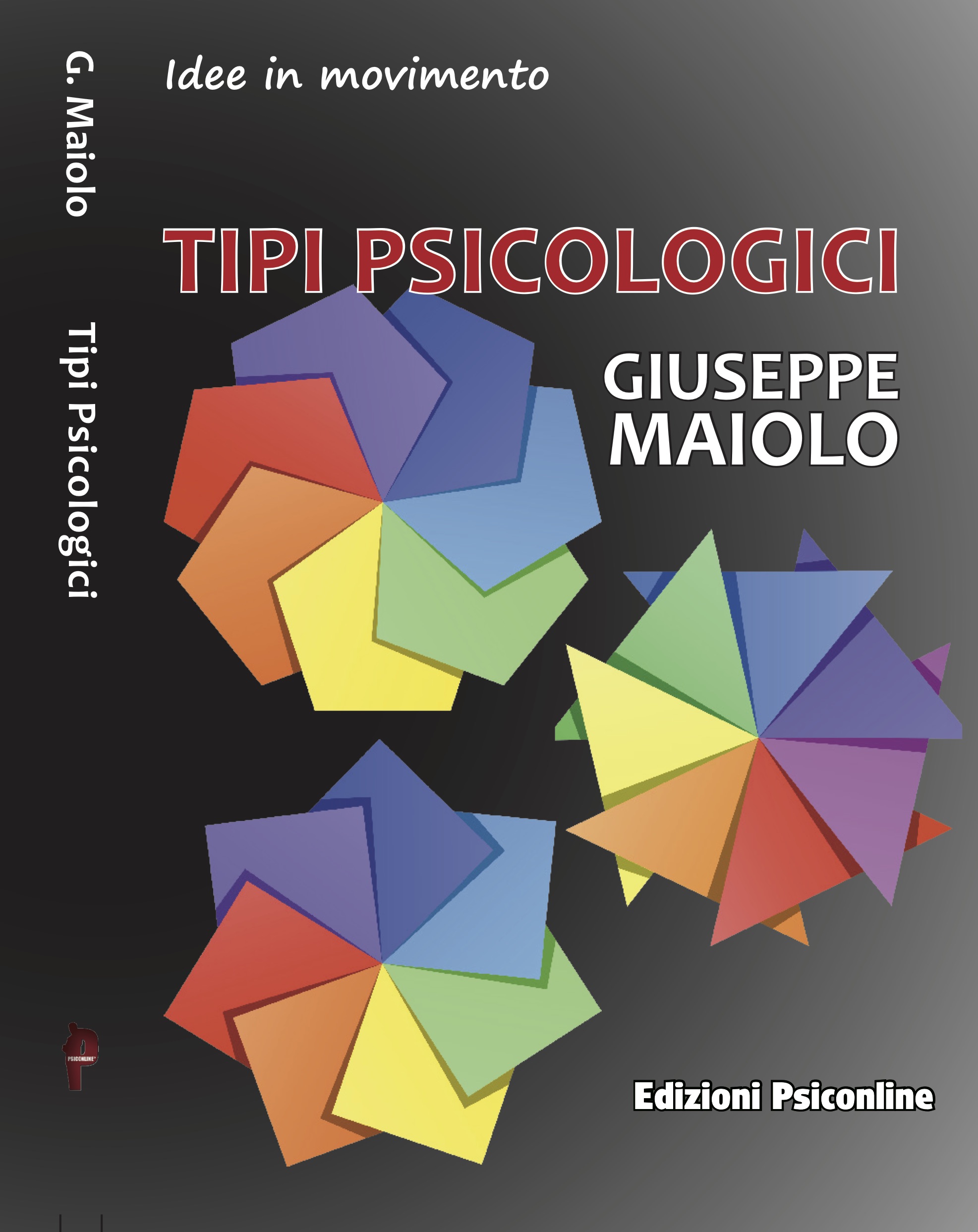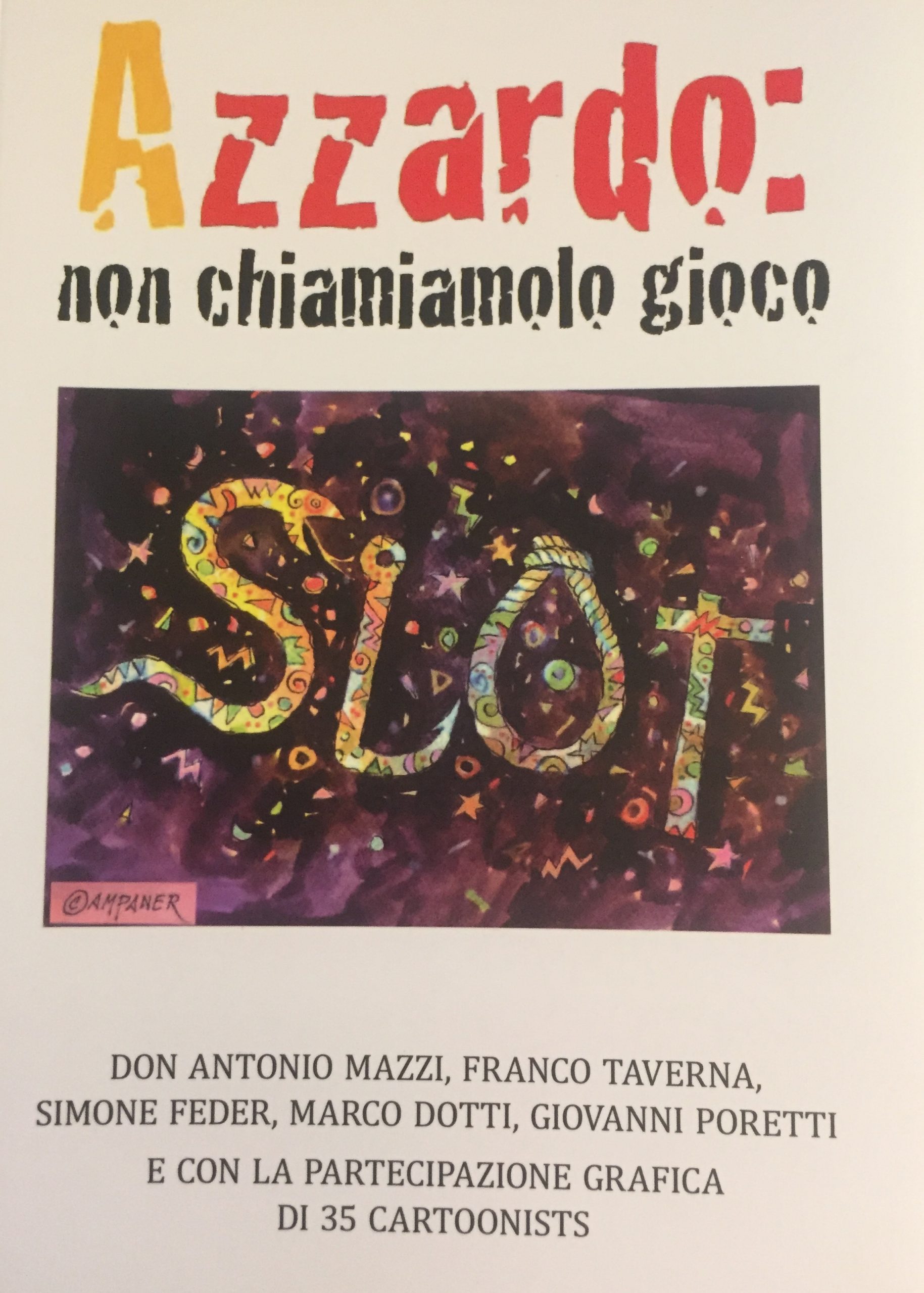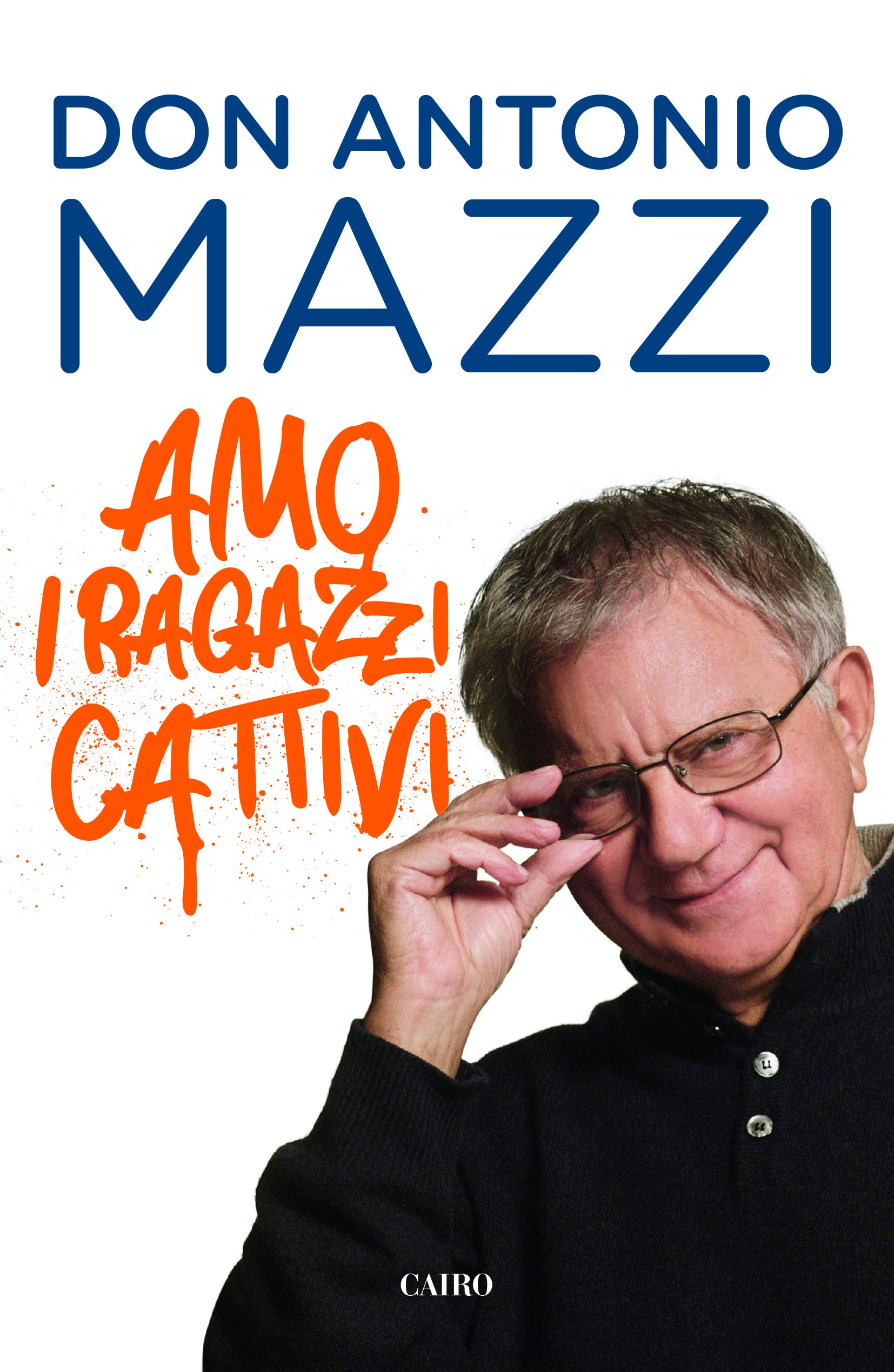Viviamo il tempo dell’impazienza e della fretta. Forse oggi, dopo la forzata sospensione della quarantena, ci aspettiamo una sorta di ipotetico indennizzo e aumentiamo la smania del fare.
Viviamo il tempo dell’impazienza e della fretta. Forse oggi, dopo la forzata sospensione della quarantena, ci aspettiamo una sorta di ipotetico indennizzo e aumentiamo la smania del fare.
Lo spazio virtuale che ci attornia corre a velocità sempre maggiore e forse ci assedia. Non è raro che ci faccia sentire di esistere solo se facciamo o parliamo in continuazione, se rispondiamo anche senza aver ascoltato o atteso che l’interlocutore abbia concluso il suo pensiero.
C’è ovunque l’urgenza di far prevalere il proprio punto di vista e in gara con tutti abitare lo spazio fisico delle conversazioni sovrapposte e confuse, immersi in una babele di parole che appena dette si dimenticano. Poco, o sempre meno, è lo spazio mentale del pensiero divergente utile per trovare soluzioni alternative, pochissimo il tempo per la riflessione e sempre maggiore quello in cui si consuma ogni emozione che poi si perde o si getta senza che possa lasciare traccia.
Saranno gli instant message che riempiono il tempo quotidiano e quel bisogno esasperato di conferma che ci spinge tutti a controllare ogni doppia spunta di WhatsApp e di Telegram. O saranno i timori sconsiderati di essere dimenticati che assalgono se vedi che non hanno letto o forse trascurato il tuo “necessario twittare”. Ma potrebbero essere anche le poche domande che ci facciamo e le tante risposte di conferma che vogliamo dagli altri per sconfiggere l’incertezza che ci assale e la montagna di dubbi che ci portiamo appresso.
Allora tutto diventa urgente, le pause tra un’azione e l’altra, voragini da riempire per non rischiare la tortura della mente. Sembra che valga ovunque l’idea che meno vuoti ci sono e meglio si sta. Più il tempo è pieno e meno ne abbiamo per cercare le risposte che ci servono. Ed è l’ansia del fare che trasmettiamo alle nuove generazioni.
Ma è anche in aumento il rischio di trasmettere ai figli, più di prima, la paura per l’attesa e l’impazienza, la frenesia della mente occupata e la preoccupazione di non aver niente a cui pensare che può trasformarsi in un sentimento angosciante.
C’è da chiedersi se quel compulsivo digitare in ogni momento e in ogni luogo sugli onnipresenti dispositivi digitali, non sia un comodo antidoto contro la solitudine e la noia, ma anche il segnale di una crescente insofferenza e della frustrazione per non poter avere soluzioni immediate. Il tempo dell’attesa, se non sei educato al saperlo gestire, innesca tensione, impulsività e comportamenti aggressivi.
Come adulti dare pazienza al giorno potrebbe voler dire imparare l’arte di aspettare. Che non è praticare l’ozio assoluto, ma valorizzare la distanza dal fare e la sospensione dell’azione per generare pause nel pensiero. E’ capacità di sintonizzarsi sull’ascolto dell’altro e arrestare il giudizio frettoloso delle parole, così come gustare il piacere del vuoto che si genera se mettiamo un po’ a tacere quel vociare continuo dei social in un’alternanza benefica di silenzio tecnologico. Ciò non farà perdere la connessione col mondo né disattivare le funzioni cerebrali. Servirà a ritrovare il passo lento dell’indugio che permette di vedere quello che sfugge quando andiamo di fretta.
Come educatori, poi, insegnare l’attesa servirà per dare ai bambini uno spazio per i sogni. In fondo questi nascono nello stesso terreno dei desideri e si costruiscono con le medesime immagini interne che ci fanno andare alla scoperta del mondo. Educare i piccoli alla fatica del “Si, ma…”, credo aiuti a farli crescere con fiducia e speranza.
Ascolta l’articolo