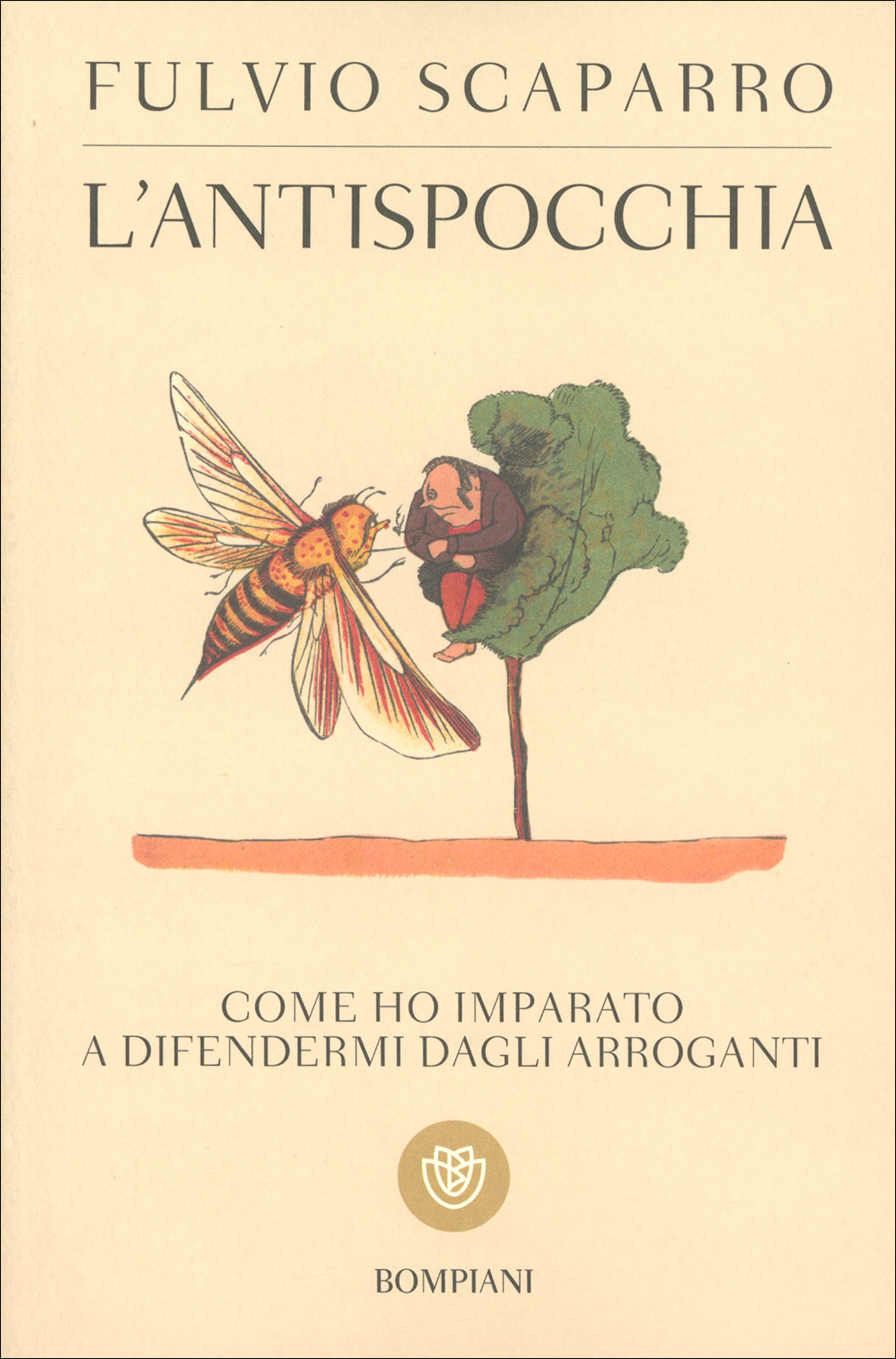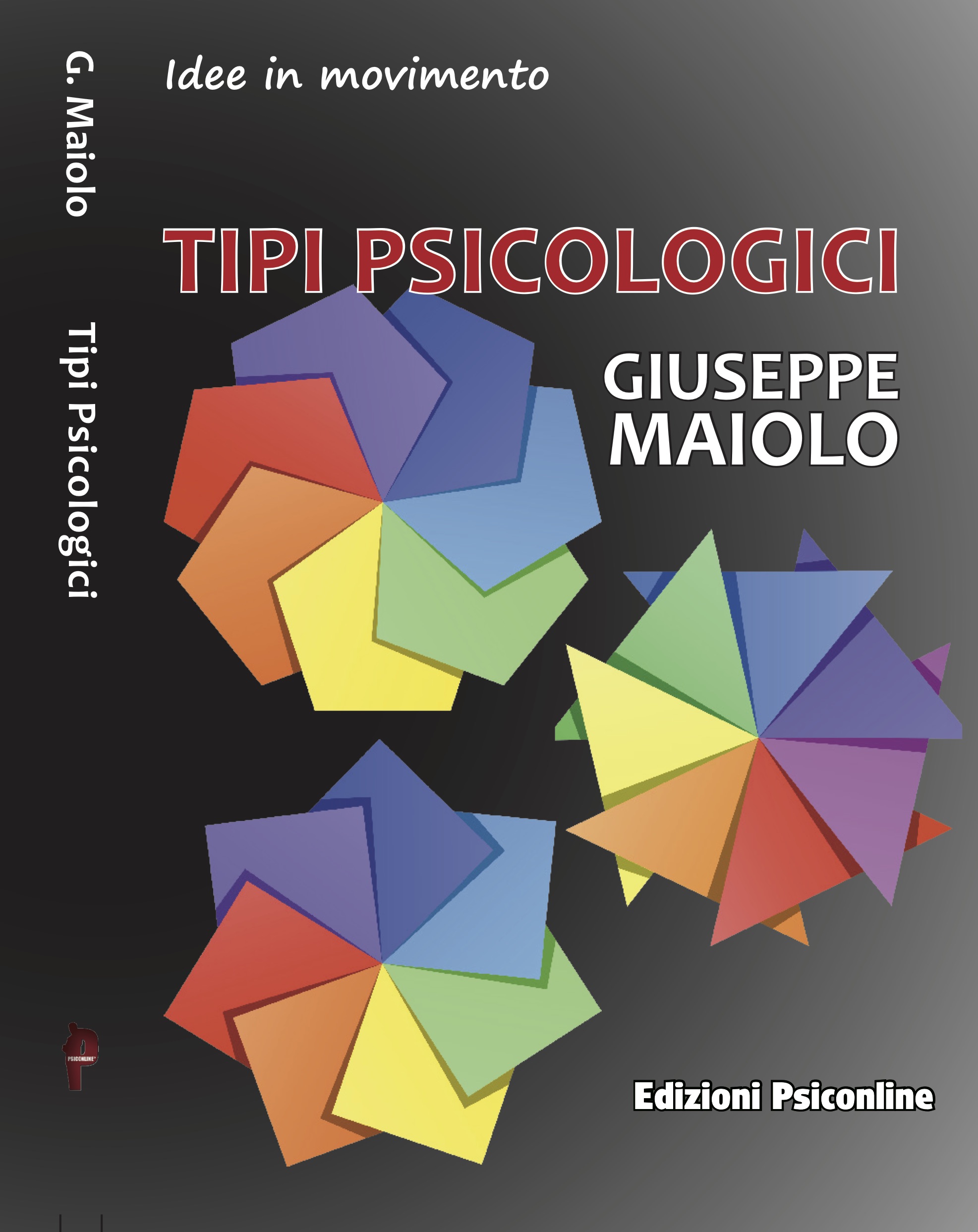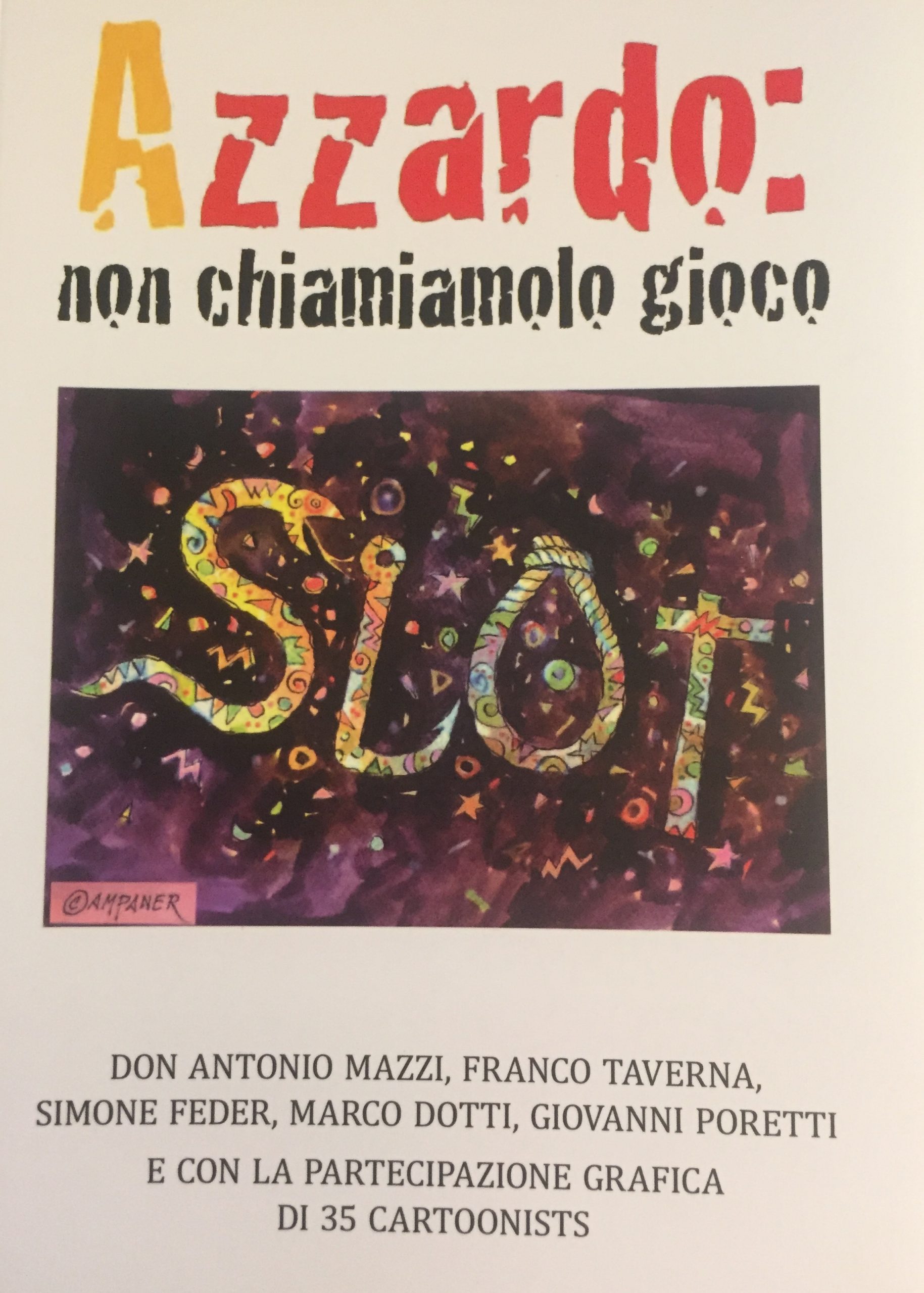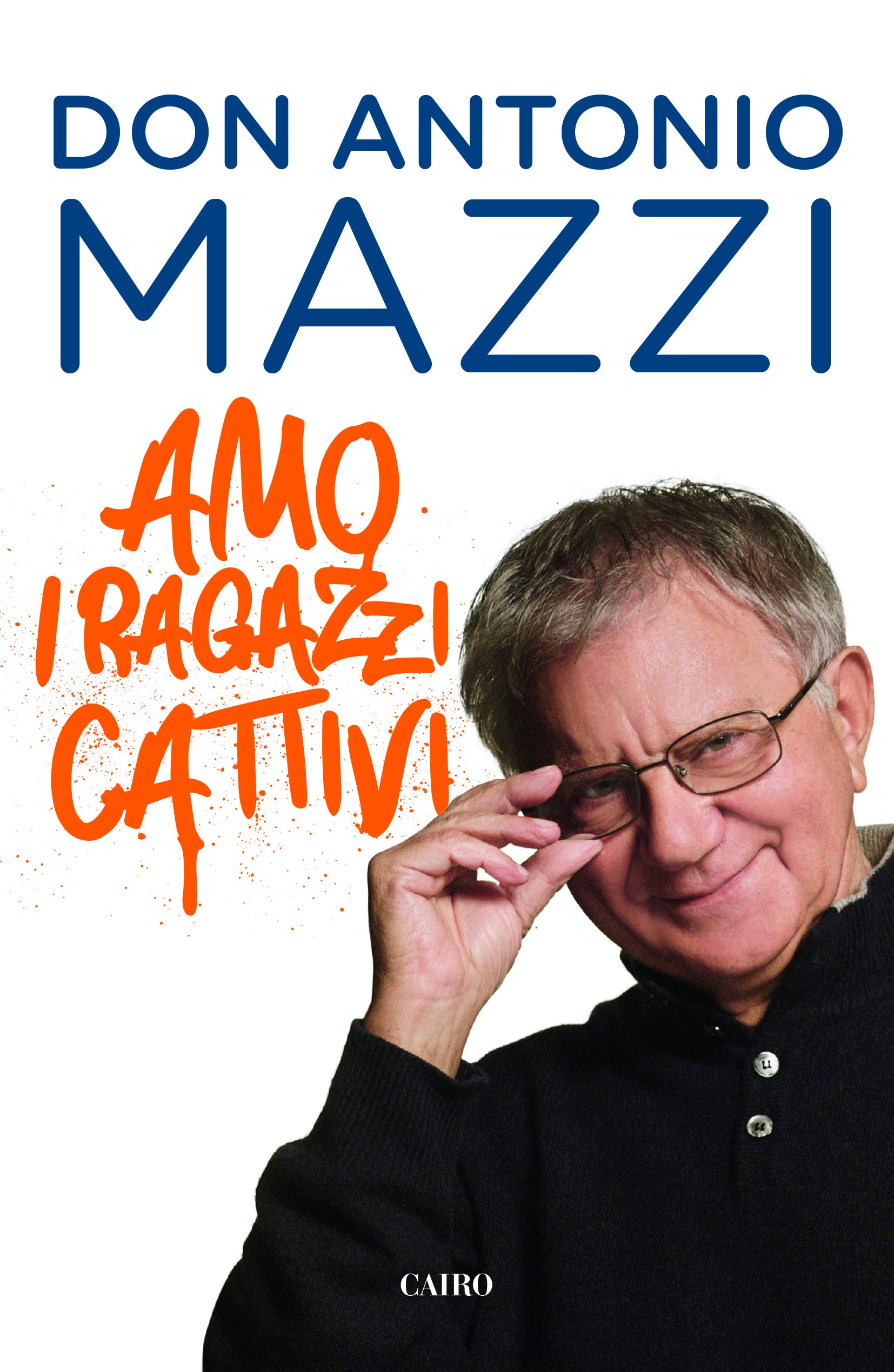È terribile la parola femminicidio, nuova e difficile da pronunciare. Ma più ancora vocabolo inaccettabile che definisce la mattanza delle donne, un olocausto che continua a insanguinare il nostro tempo e pure le giornate vicine alla ricorrenza “festosa” dell’8 marzo.
Così è davvero difficile festeggiare se i numeri ti dicono che solo nei primi giorni di questo mese tre sono state le donne uccise dalla furia dei maschi e 20 le vittime del 2023!
Femminicidio è sinonimo di omicidio di donne in quanto tali, forma estrema e definitiva della violenza di genere che non ha altri motivi.

È parola che segna l’efferatezza della cultura machista ancora presente e descrive l’annientamento delle “femmine” spesso preceduto da aggressioni domestiche continue, sopraffazioni, svalutazioni psicologiche e limitazioni dei diritti.
È parola forte e complessa che ormai appartiene al vocabolario comune ed è impregnato di elementi di natura sociale e psicologica, relazionale e affettiva, personale e collettiva.
Viene dall’inglese “femicide” ed è stato tradotto in italiano con “femminicidio”. Tra i primi ad usarlo negli anni novanta del secolo scorso, c’è Diana E.H. Russell, criminologa e sociologa che nella prefazione al libro “Femicide. The politcs of woman killing” definisce il “femicide” come l’omicidio di donne da parte di uomini “solo perché donne” e punta il dito sulla violenza di genere e sulla struttura delle relazioni uomo-donna.
Ne risulta un vocabolo lapidario ma preciso nel suo significato, che non consente giustificazioni o attenuanti. A volte ha fatto storcere il naso a qualcuno. Isabella Bossi Fedrigotti ad esempio, sul Corriere della Sera del 30 aprile 2012 nell’articolo “Donne uccise, violenza in aumento, ma non chiamatelo Femminicidio” suggerisce di non usarlo per non «intendere questi omicidi come chiusi in una categoria, meno gravi dei normali omicidi»
In realtà non è così. Di certo la parola che identifica l’omicidio di una donna in quanto femmina, è sintesi di un flusso inarrestabile di violenza maschile, domestica e quotidiana le cui radici affondano nella disparità di genere come prima forma di sopraffazione.
In questi giorni una ricerca significativa della Fondazione Libellula pubblicata sul sito www.luce.lanazione.it ha fornito dati sconcertanti sulla percezione che hanno gli uomini del fenomeno violenza di genere.
Rileva che il 43 % dei maschi intervistati ritiene la violenza sulle donne un fenomeno che non lo riguardi, e allo stesso tempo svela che il 36% dei padri “non ha mai utilizzato gli strumenti aziendali (congedo parentale) per occuparsi dei figli”. Significa che è ancora elevato il numero degli uomini incapace di riconoscere il proprio potenziale violento ed esercita senza rendersene conto una forma di privilegio di genere e discriminazione.
È innegabile allora che il vocabolo “femminicidio” sia dirompente e imponga la necessità di sconvolgere gli schemi intellettuali prevalenti e la cultura della violenza, perché oltre a indicare l’eliminazione fisica della donna, rimanda a forme variabili non meno gravi, di continue sopraffazioni, offese e prevaricazioni relazionali su cui i maschi sono chiamati con urgenza a interrogarsi.