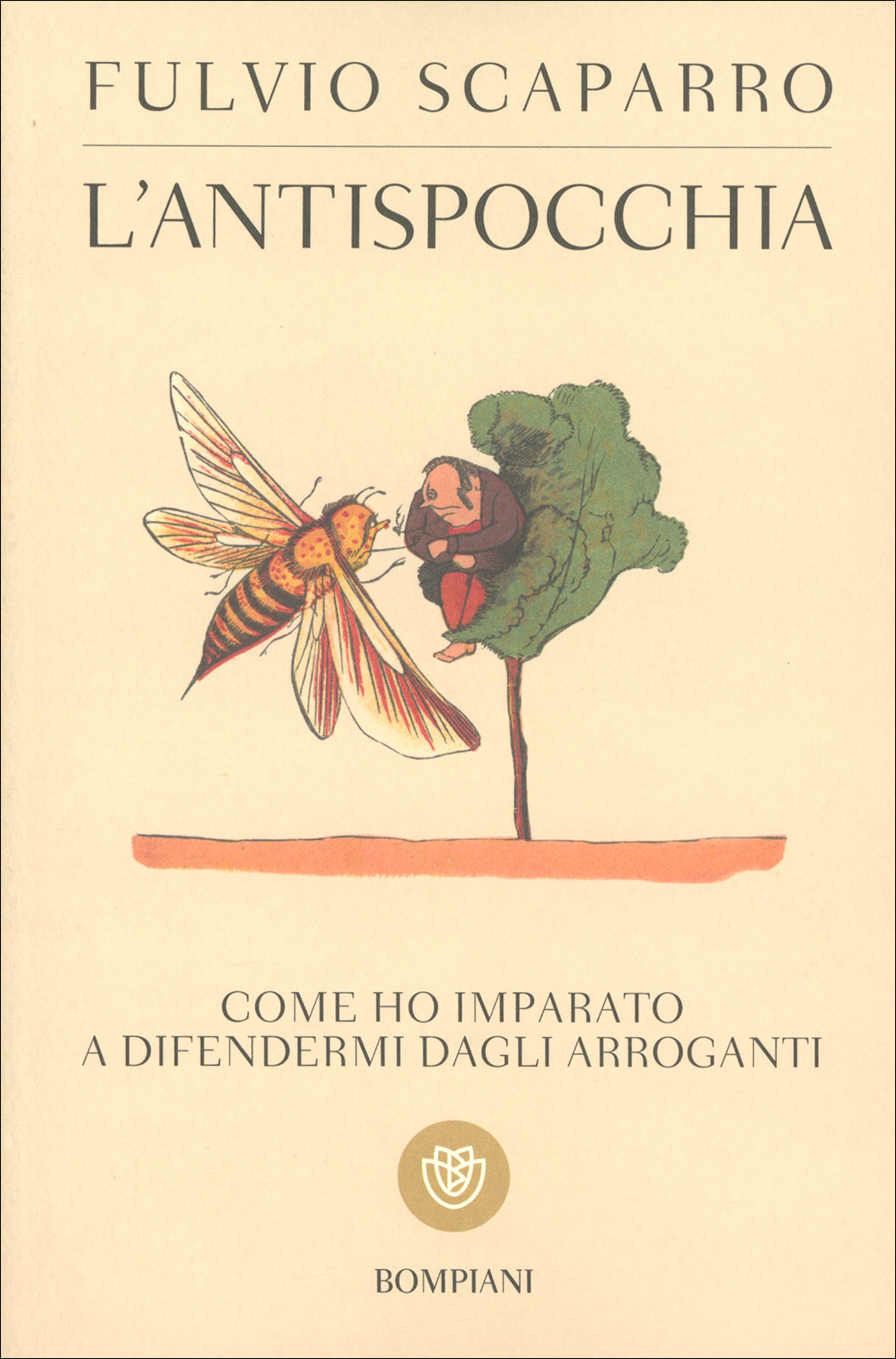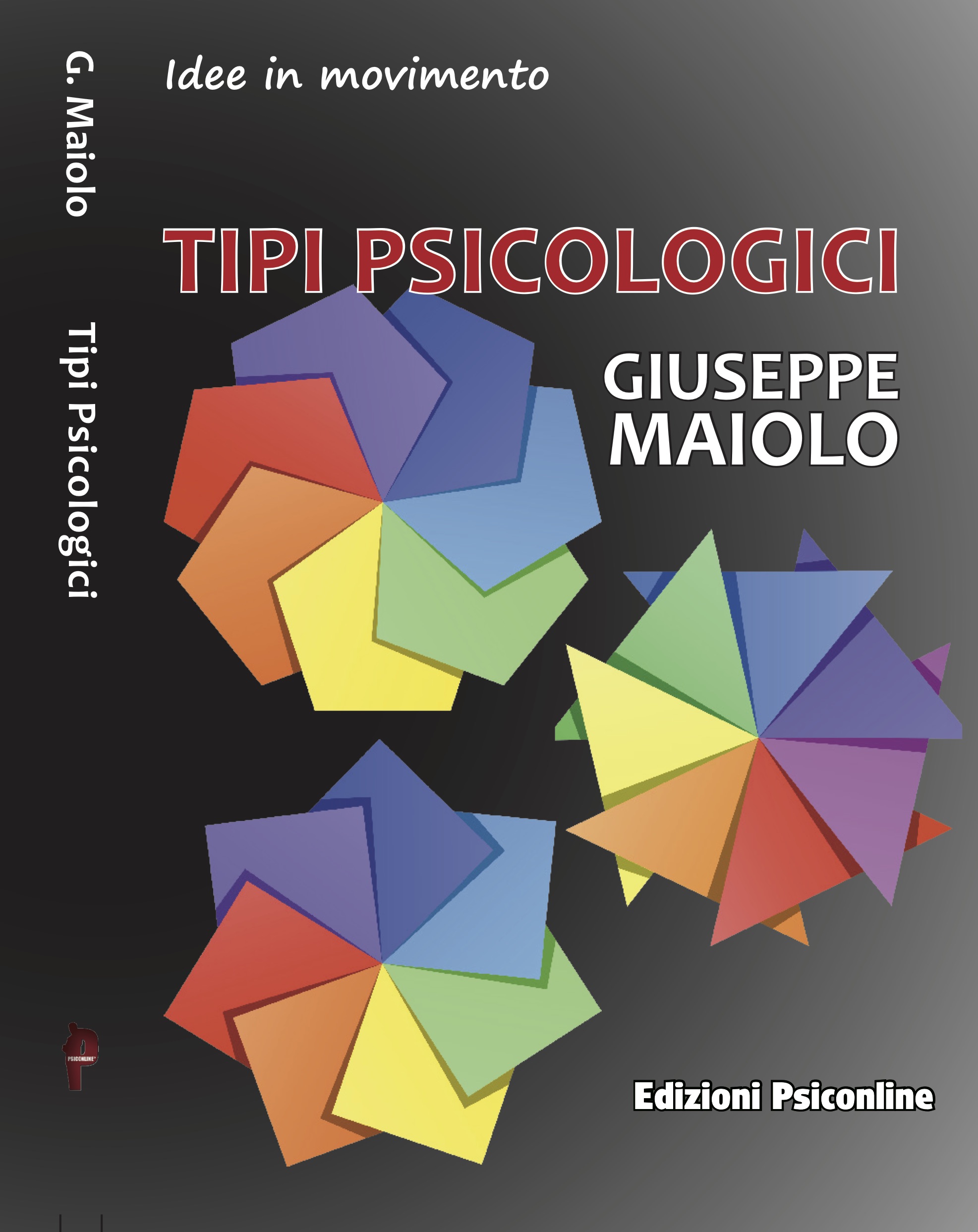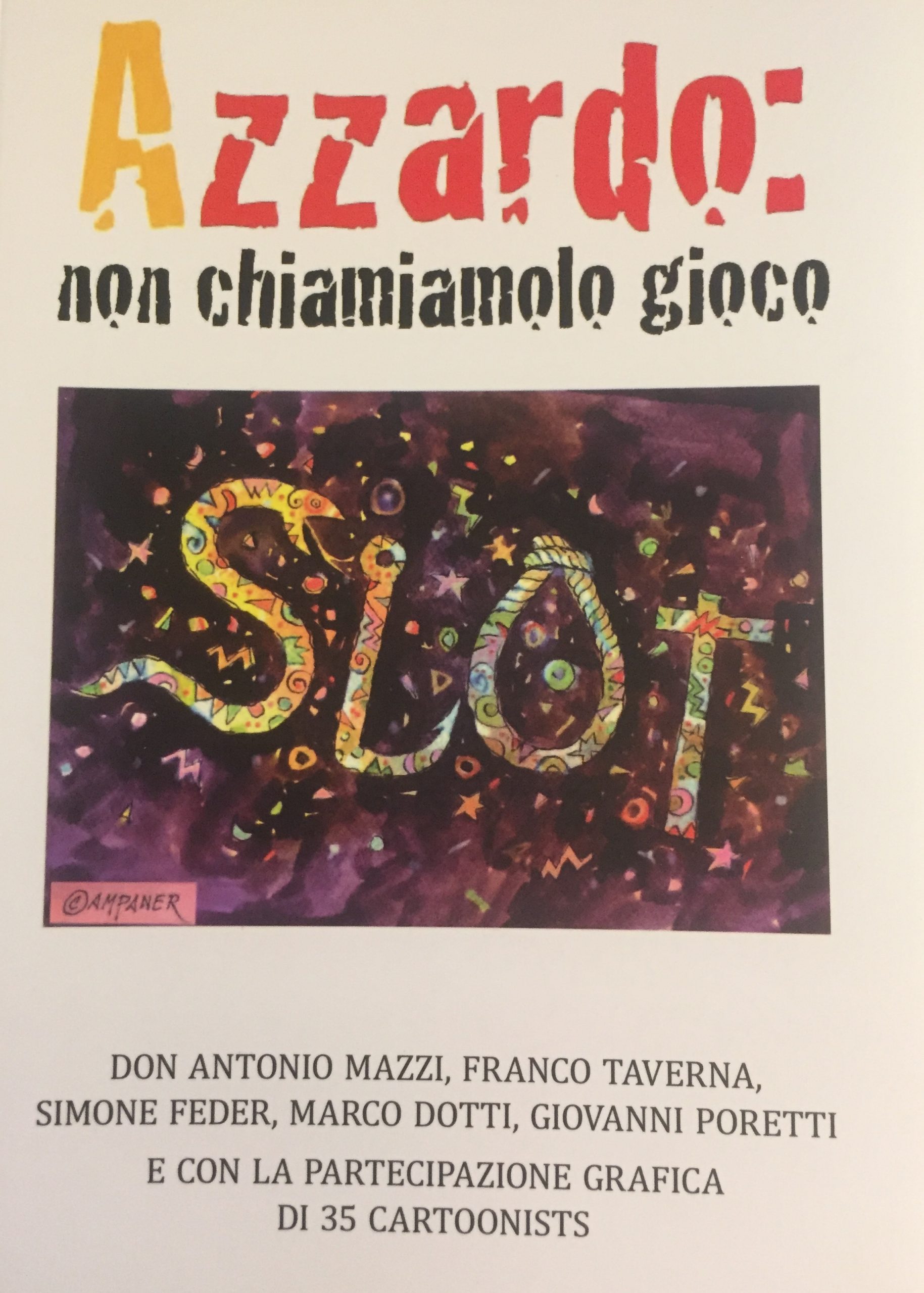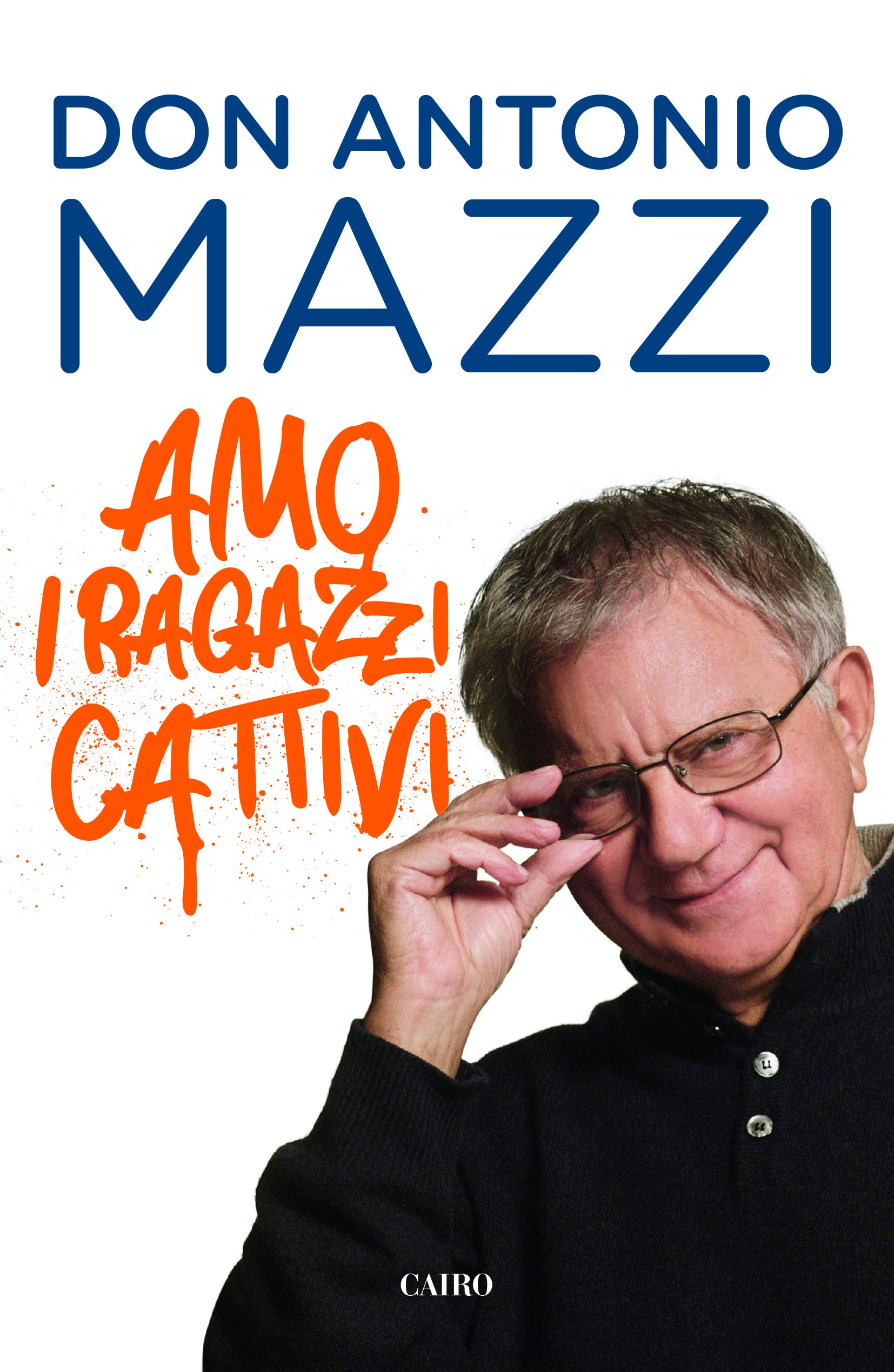Da più parti e da tempo ormai, si dice che nell’educare serve fornire il senso del limite, contenere gli eccessi, dare un confine alle richieste, moderare le pretese. La parola d’ordine è arginare il permissivismo che ha rappresentato una diffusa stagione educativa, per altro ancora presente nella relazione genitori-figli.
Non è una novità l’insistenza di valorizzare il “No” che ha basi valide e significati specifici in quanto è dell’adulto la competenza di mettere confini e delimitare il territorio dell’onnipotenza infantile, ma è defatigante per chi educa come pure impegnativo, perché richiede tempo e pazienza. Il risultato è che si fatica sempre a negare qualcosa o, quanto meno, a costruire non prigioni ma cancelli da cui in ogni caso si può uscire con la chiave giusta. Crescere, non c’è dubbio, è più complesso di un tempo.
E poi accade in fretta anche perché nell’infanzia i bambini li “adultizziamo” velocemente e, un a volta adolescenti stracolmi dei sentimenti di infallibilità con cui li abbiamo nutriti, li lasciamo da soli ad affrontare se stessi e il mondo, a cercare l’identità e l’autonomia che serve. In mancanza di adulti autorevoli capaci di accompagnare e con cui gli adolescenti si possano realmente confrontare (sono saltate da tempo le trasgressioni), senza l’allenamento a un pensiero critico che serva a porsi domande, i ragazzi si spaesano e cercano risposte immediate.

Se non le trovano si ritirano, se ne vanno distanti sul tappeto volante del virtuale e dei videogiochi a oltranza o si isolano da tutto. Oppure duplicano le angosce dei grandi che temono il fallimento dei figli, pretendono competizioni ma negano il valore della prova e il significato della sconfitta. Li abbiamo abituati al “giocare” per vincere e a percepirsi onnipotenti. Abbiamo chiesto loro di non fallire un colpo e sovente educati a colpevolizzare gli altri, chiunque essi siano, compagni, insegnanti, scuola.
Abbiamo dato al “gioco” l’unico valore del “game” che in inglese è gioco regolato ma anche esperienza di confronto per conoscere chi siamo noi e chi gli altri. Ma questo “game” è divenuto sempre più solitario, challenge cioè sfida con se stessi, esercizio di abilità che esce dalla dialettica del confronto. Una tipologia di gioco confinata nel cerchio narcisistico individuale e divenuta prova rischiosa senza calcolo ma propellente potente per restare protagonisti della scena, diventare famosi e realizzare i sogni dei grandi che chiedono trofei.
Il “game” come sfida solitaria è divenuta abilità senza confronto
Nel contempo gli adulti hanno smesso di fare “gioco” come play, divertimento, di giocare con i piccoli a “braccio di ferro” dove l’importanza non sta nel vincere, ma nel resistere. Così si è persa l’educazione al confronto e alla condivisione, ed è rimasta la cultura dei “like” e il potere dei follower.In mancanza di strumenti critici di “lavoro”, i “Supereroi” adesso sono fragili e incapaci di accettare prove e competizioni, non tollerano le perdite e non sanno sostenere le sconfitte.
Lo abbiamo visto in Inghilterra in quel gesto sprezzante della medaglia rifiutata che diceva in modo plateale quanto inequivocabile, che la sconfitta non era stata contemplata. Non apparteneva loro. Era fuori da ogni ordine di pensiero e da ogni confronto possibile