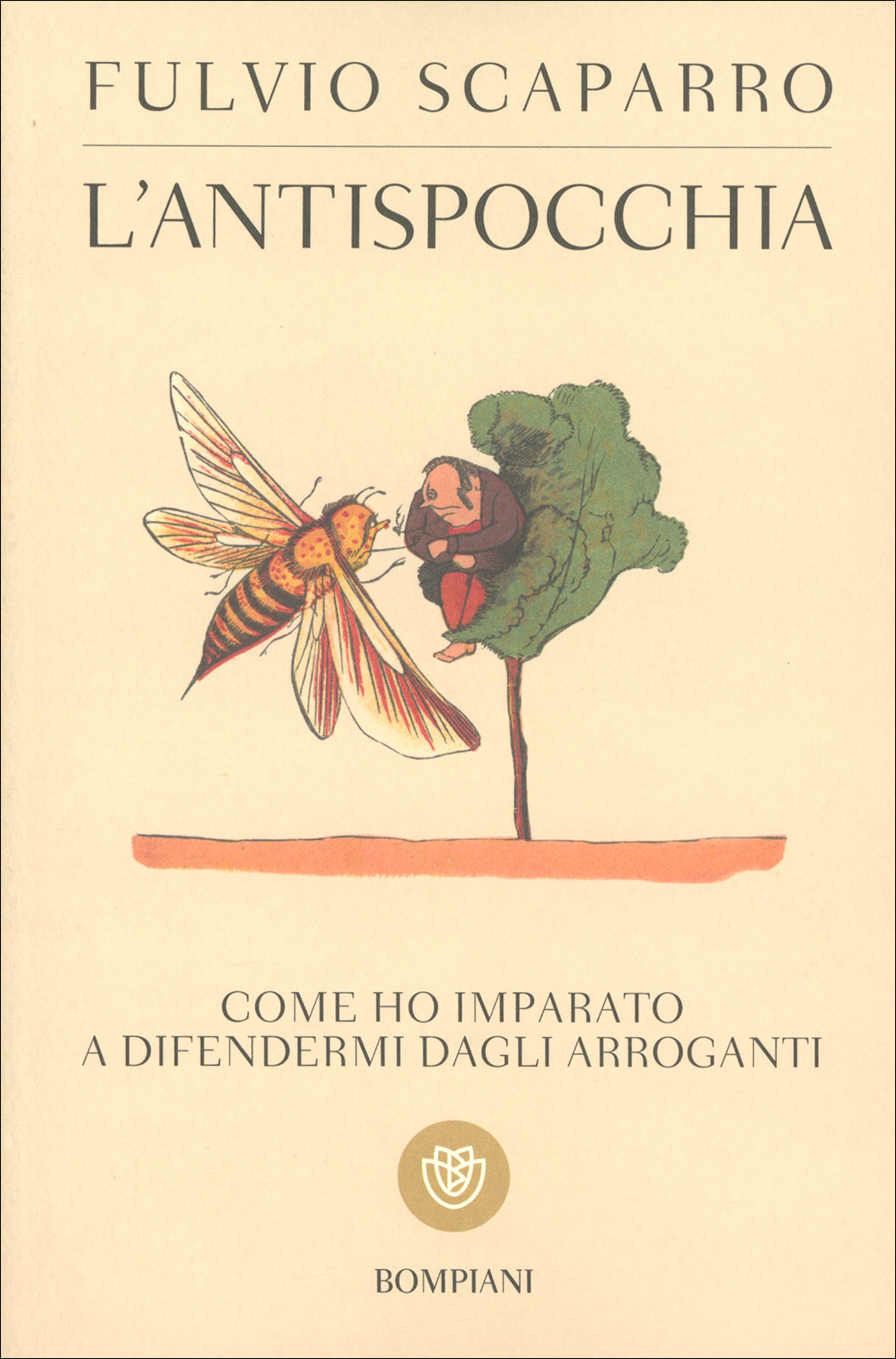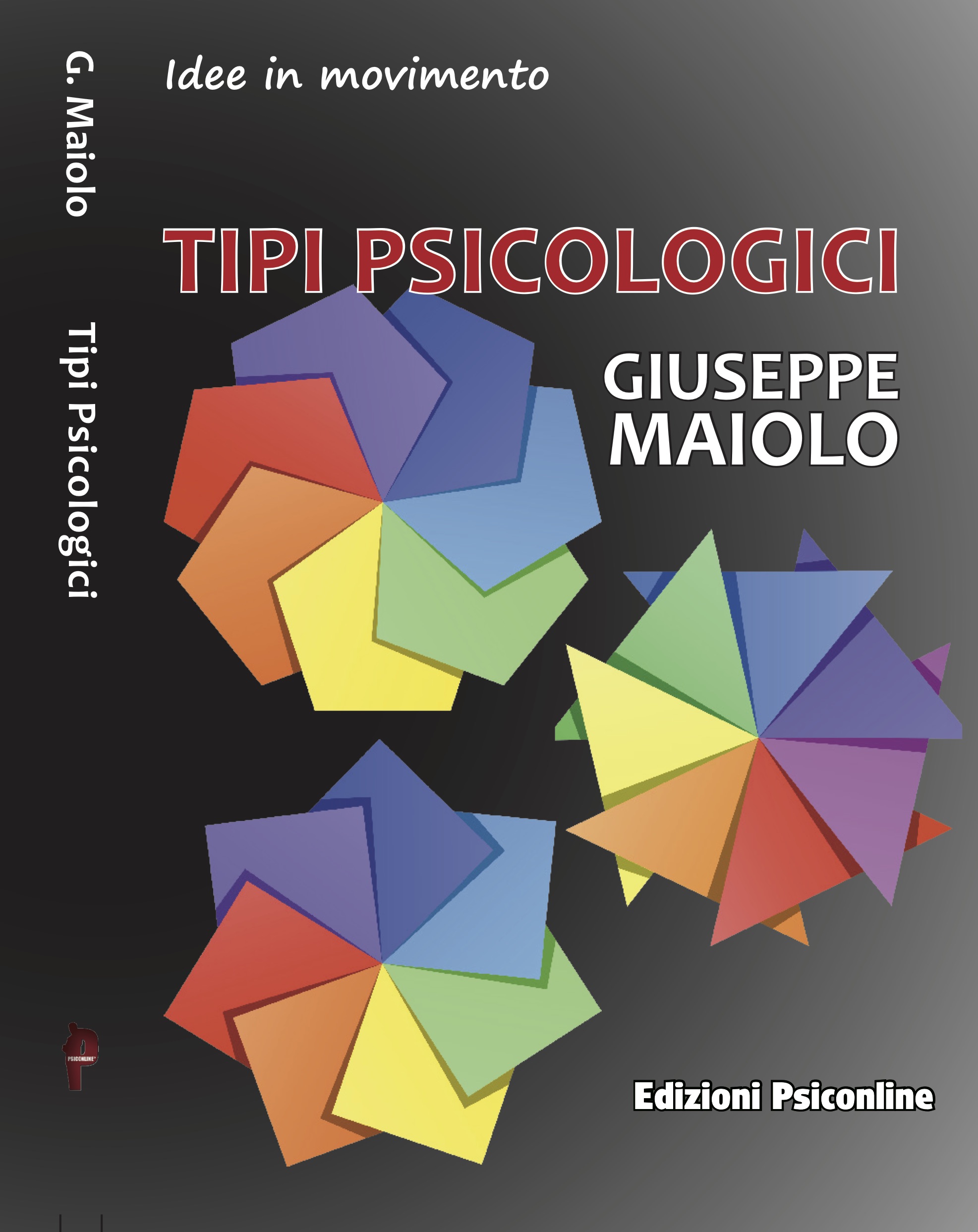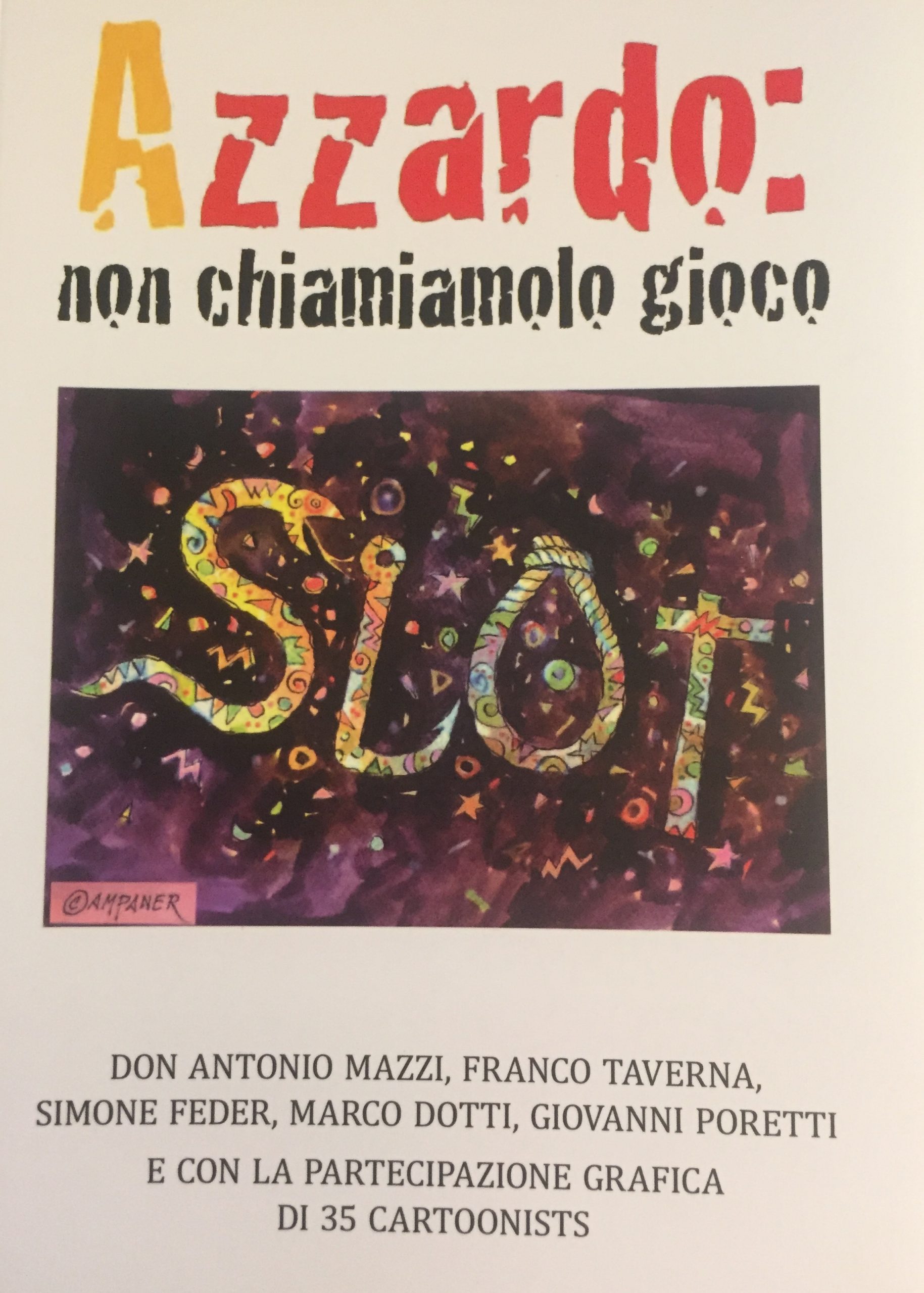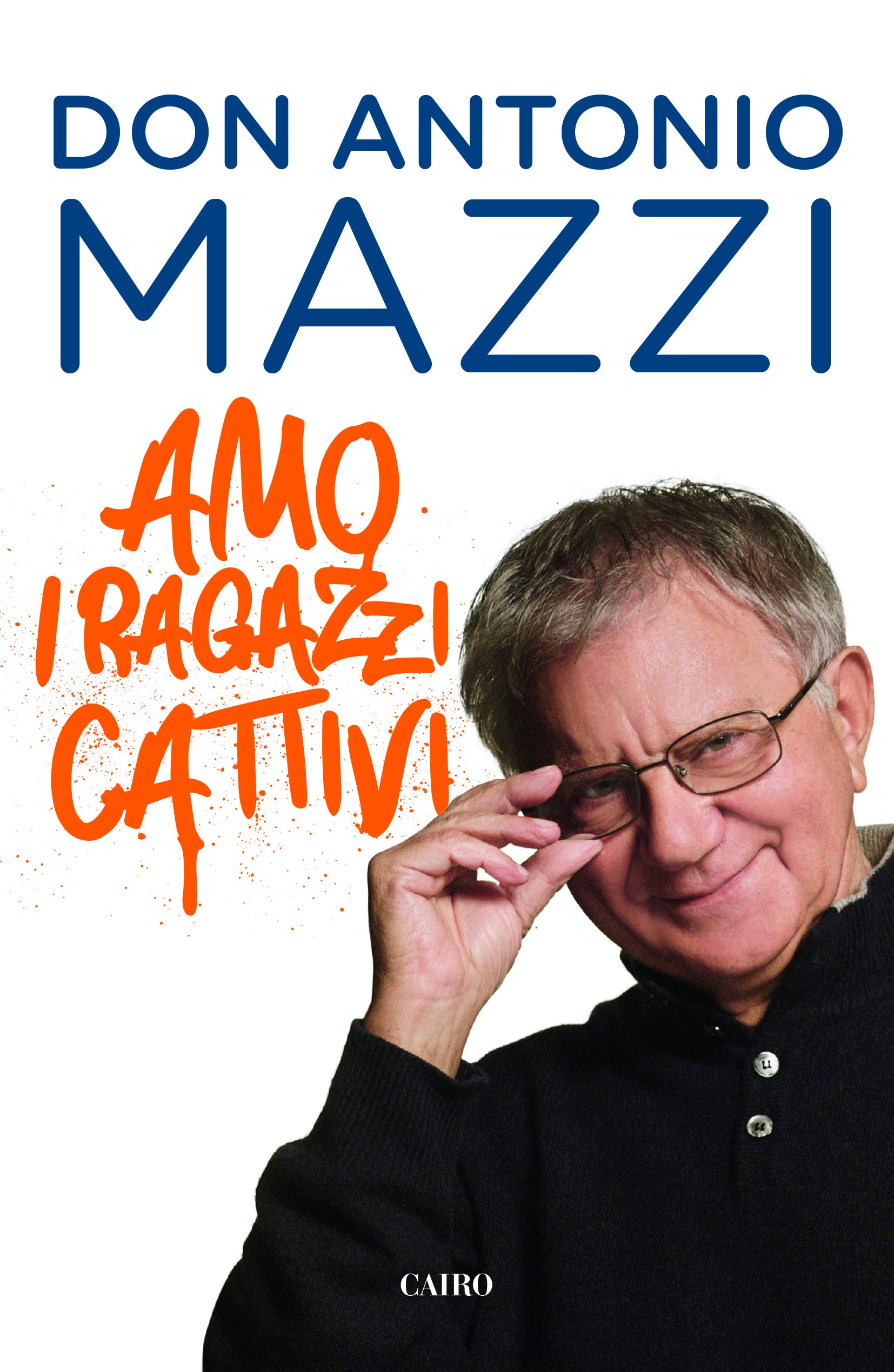“Se in carcere muore una ragazza di 27 anni, significa che tutto il sistema ha fallito. E io ho fallito, sicuramente…”.

Sono le parole lapidarie del giudice di Sorveglianza Semeraro, all’indomani del suicidio a Verona di Donatella, una delle 50 vittime dall’inizio dell’anno ad oggi, che alcuni giorni fa si è tolta la vita in carcere.
Un numero spaventoso quello del suicidio dei giovani e un’auto denuncia forte e grave di chi, doverosamente, sente la necessità di puntare il dito sull’intero sistema carcerario e sul sistema punitivo che va ripensato.
Costruito in effetti attorno all’idea che la detenzione debba togliere (libertà, autonomia e quant’altro), a nessuno viene in mente che ri-educare, esattamente come per l’educazione, vuol dire aggiungere. Non oggetti materiali ma relazioni significative e opportunità di crescita e “costruzione” del Sé. Per chi è giovane detenuto, la carcerazione dovrebbe servire per cercare gli strumenti necessari a riattivare quella progettualità già di per sé difficile nella quotidianità ma impossibile in questo genere di carcere.
Al tossicodipendente che reca con sé ferite nascoste, la detenzione aggiunge solitudine alla solitudine non essendo stata pensata per favorire il cambiamento di nessuno. Questa è la dimensione che conduce alla disperazione e al suicidio. È a mancanza di speranza che fa crescere il desiderio di morte e dai pensieri mortiferi, frequenti nell’età giovane, oggi è più facile passare al suicidio che in adolescenza è al secondo posto tra le cause di decesso.
Si “cresce solo se sognati” scriveva Danilo Dolci in una sua poesia in cui metteva l’accento sulla relazione educativa e sulla capacità di attesa che dovrebbe essere una dote adulta. Perché è l’essere pensati che serve a chi cresce. È sapere che qualcuno crede nelle tue potenzialità e si aspetta di vederne i germogli anche quando hai fallito, che dà l’idea di una possibile da ri-costruzione della vita.
Allora per cominciare penso sia necessario affermare, come ha fatto da tempo don Antonio Mazzi con Exodus, che ci sono alternative al carcere da mettere in atto. Ora che il disagio giovanile lievita e alimenta comportamenti autodistruttivi, diventa urgente avere coscienza di quanto le nuove generazioni percepiscano con dolore il diffuso fallimento che stiamo vivendo sul piano sociale, ambientale, relazionale e affettivo.
Il guaio è che ai giovani non abbiamo dato strumenti per tenere botta e sono pochi gli adulti in grado di aiutarli ad accettare le fragilità umane. Per lo più continuiamo a farli crescere con l’idea onnipotente di “poter sconfiggere il virus o il nemico” con le “armi” sofisticate che crediamo di aver costruito, quando serve dell’altro per diventare grandi.
Gli adolescenti hanno bisogno di imparare a con-vivere con gli opposti, mediare gli estremi e di attrezzature utili per accettare le responsabilità dei propri comportamenti.
Ma hanno la necessità di adulti capaci di riconoscere cosa voglia dire crescere oggi e di educatori in grado di intercettare presto la sofferenza, come pure di insegnanti che a scuola sappiano affrontare con i ragazzi il tema della morte, della violenza, della guerra e del suicidio e non si eclissino di fronte a questi eventi.