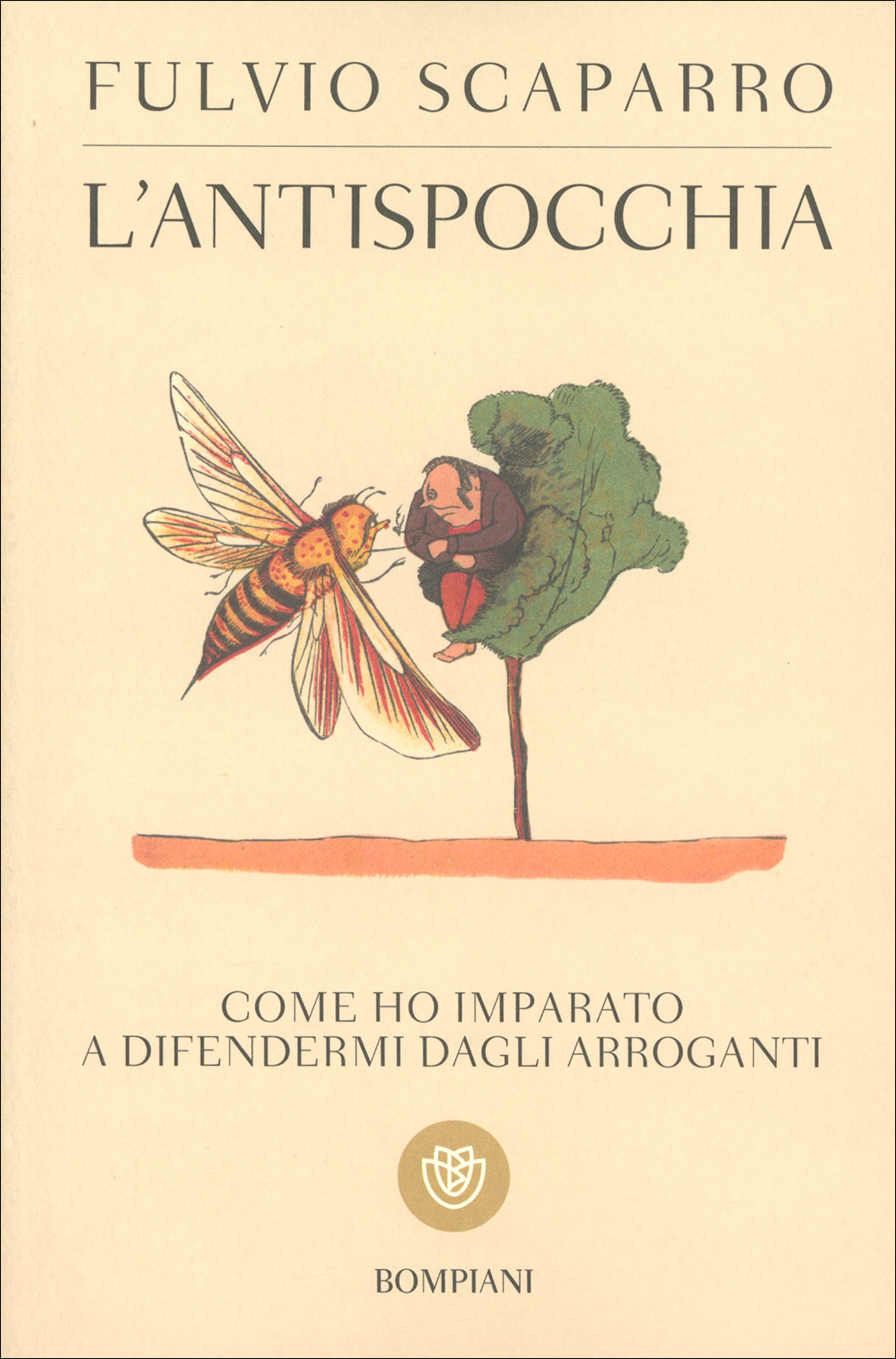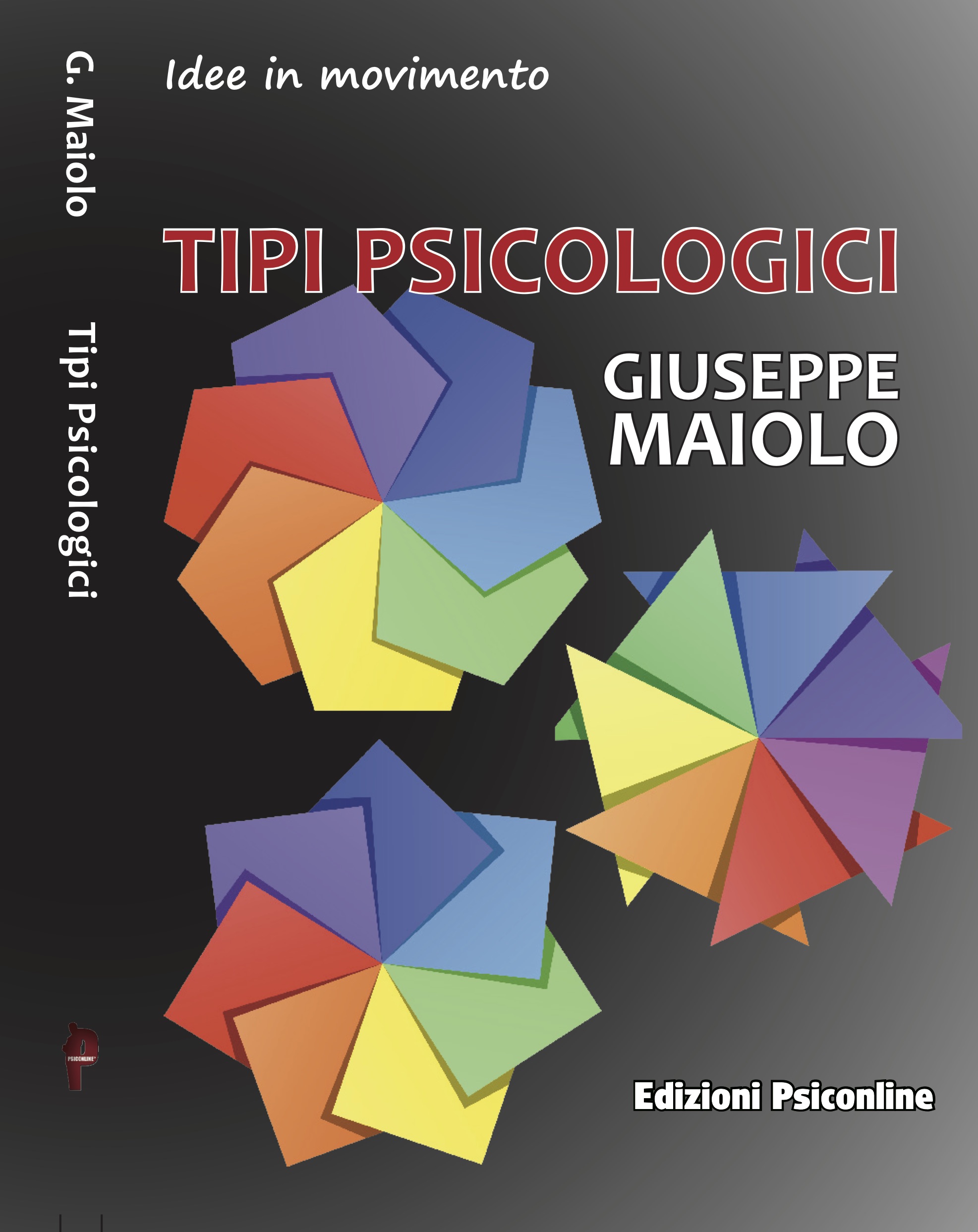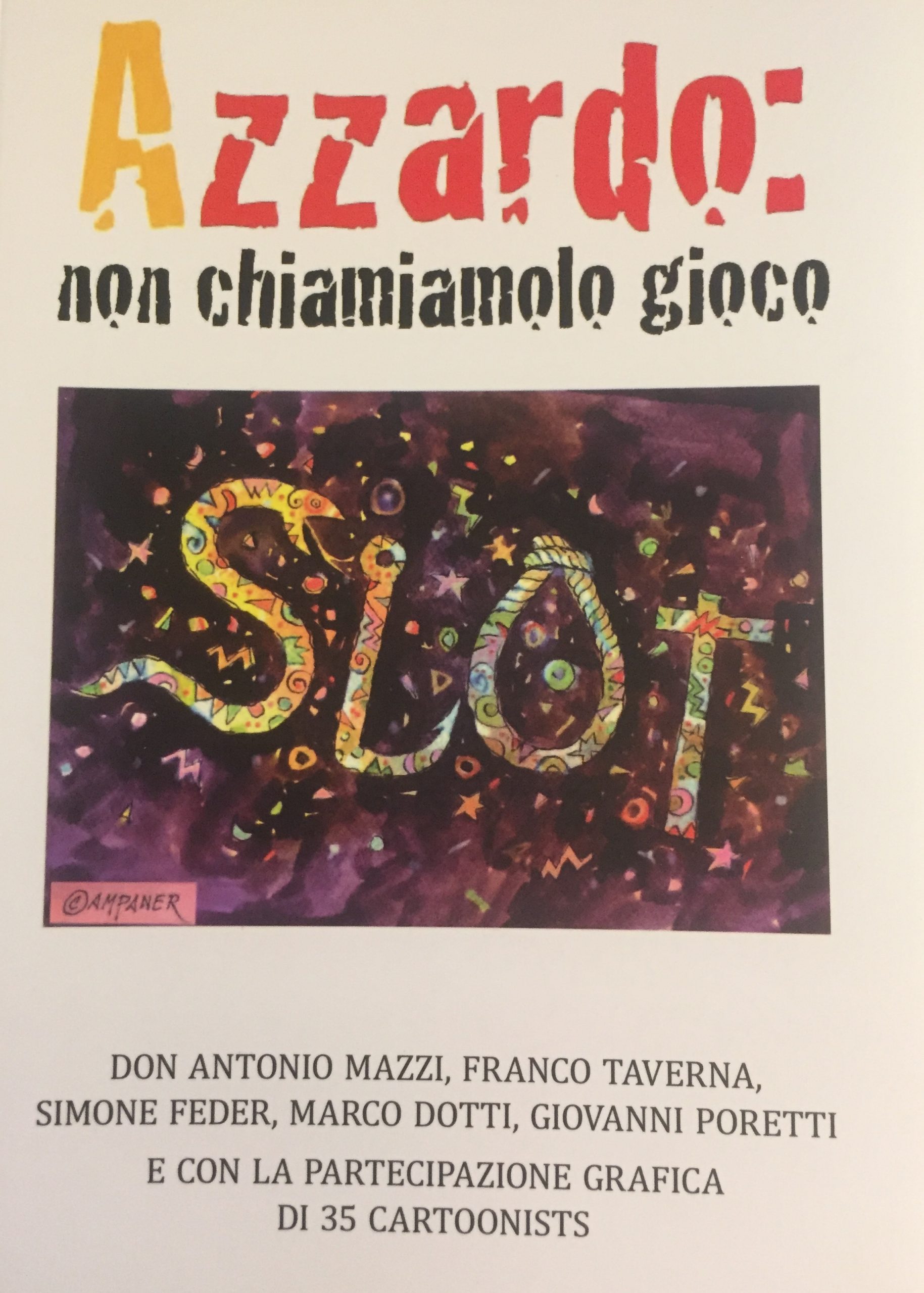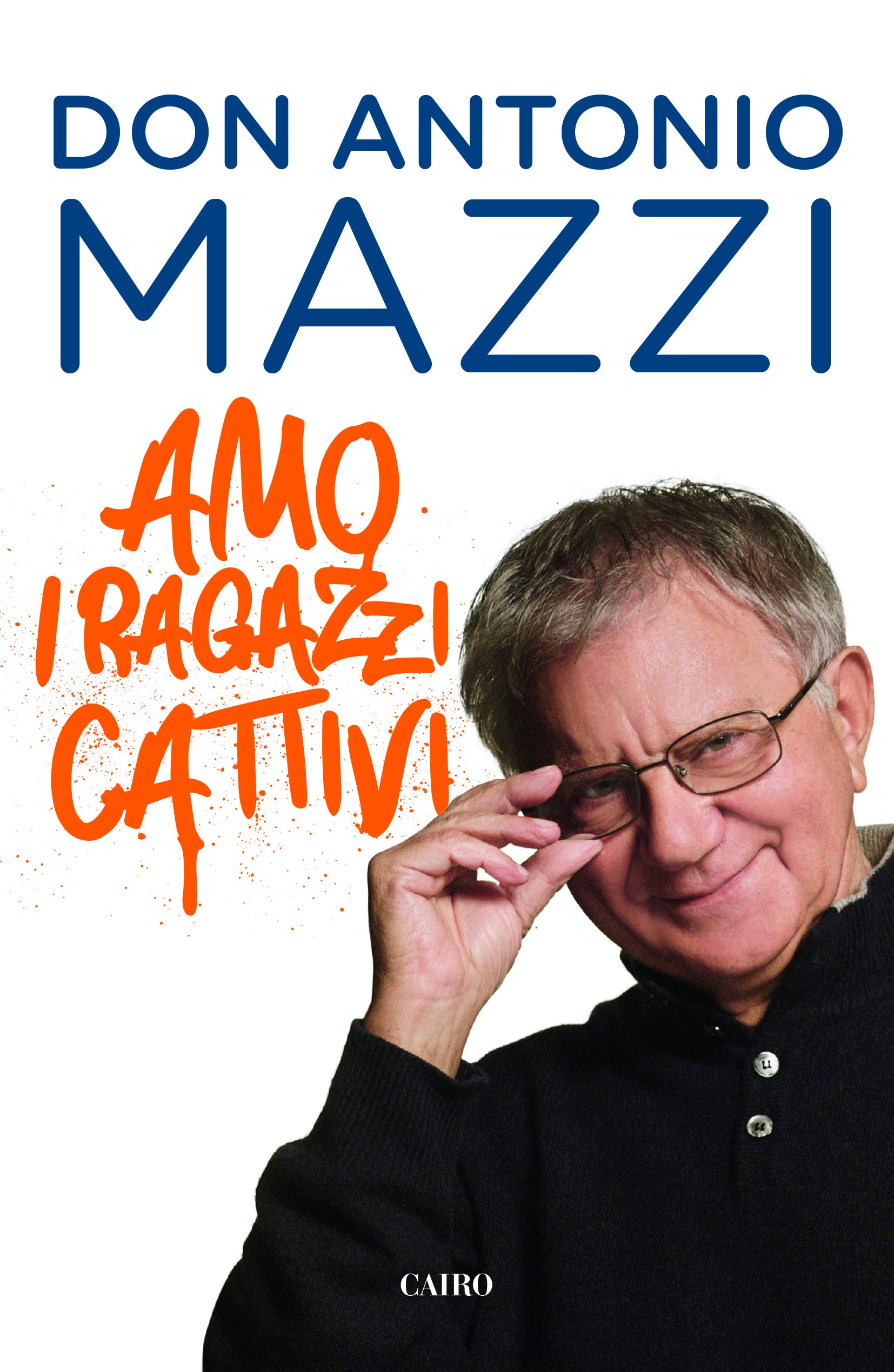Nei mesi scorsi è apparso sulla rivista “Psychiatry on line Italia” un editoriale a firma di Francesco Bollorino dal titolo emblematico “Manifesto per una salute mentale moderna e democratica in Italia”, quello che maggiormente mi ha colpito è la trasversalità delle firme che appoggiano questo appello/manifesto. Si spazia dal presidente di “Psichiatria Democratica” al presidente della “Società Italiana di Psicoanalisi”! Basterebbe questo per far capire quanto il tema trattato dall’intervento sia sentito e condiviso pur partendo da posizioni profondamente divergenti tra loro.
Lo scritto in questione è assolutamente esaustivo nella critica al modello biomedico in campo psichiatrico, al tentativo di ridurre la cura del dolore psichico al mero approccio farmacologico, al tentativo di sottrarsi alla relazione con il paziente e con la società. Un modello che se guardato con attenzione mostra chiaramente il suo essere deresponsabilizzante tanto per il medico quanto per il paziente. Il farmaco come terzo nella relazione, spesso magicamente investito, in un goffo tentativo di sostituirla, è il farmaco che funziona o non funziona, in uno scambio paziente – psichiatra divenuto immobile.
Ho lavorato otto anni in un dipartimento di psichiatria ed i miei ricordi, la mia esperienza è molto diversa dalla realtà attuale. Ricordi idealizzati? È probabile, ma non per questo meno veri.

In quegli anni, mi riferisco al secolo scorso, dalla metà degli anni ’80 alla metà degli anni ’90, la psichiatria si proponeva come punto di snodo tra la medicina (si usavano i farmaci anche allora) la psicologia e la sociologia.
Nei miei ricordi la psichiatria si confrontava con la malattia mentale, con il dolore che questa comporta, con le sue ricadute individuali e sociali, con la sua storia secolare, nei mie ricordi dicevo la psichiatria era un vero e proprio laboratorio di pensieri, di idee, di proposte. La psichiatria poteva essere tutto tranne che arida.
Ovviamente ognuno si indirizzava nella comprensione e nell’approfondimento di quelle teorie che erano più vicine a lui, alla sua personalità.
Si spaziava da una visione sociologica delle cause della malattia mentale e conseguentemente a ciò delle risposte alla sofferenza, del progetto di cura, ecco allora sorgere le comunità terapeutiche, gli appartamenti protetti, gli inserimenti lavorativi etc. Tutte proposte che nascevano da un pensiero ben preciso e direi da una specifica visione della persona.
Altri volgevano lo sguardo al pensiero psicoanalitico, la psicoanalisi entrava allora nei reparti psichiatrici, molti psichiatri avevano fatto la propria analisi individuale e in alcuni casi erano diventati psicoanalisti, portando così la propria esperienza nell’istituzione, basti pensare ad un libro divenuto famoso “Lo psicoanalista senza divano” di Paul Claude Racamier, dando origine ed impulso alla psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo strumenti più appropriati per cogliere la “verità” individuale del matto e del suo dolore.
Soprattutto io credo non c’era il timore di riconoscere che gli ideali erano e sono le gambe su cui si muovono le speranze, le utopie. La stessa ricerca di comprendere l’eziopatogenesi del dolore psichico era ed è permeata dagli ideali di riferimento e di questo si deve essere consapevoli, se non vogliamo nasconderci dietro un eccesso di determinismo che ha come unico risultato il sottrarsi alla relazione con il paziente e con il suo dolore. Ed è questa parola, la parola ideale che sta sempre più scomparendo dal discorso sociale, quasi non fossero gli ideali alla base del nostro modo di pensare ma fossero i fatti a determinare il nostro pensiero, che poi altro non è che la base del pensiero unico e la morte del pensiero critico. Senza accorgersi che la negazione dell’ideale rende la vita, non solo la psichiatria, ma la vita di tutti noi più povera, più arida ed anche più cieca.
In questo senso la psichiatria diventa emblematica proprio per il suo collocarsi all’incrocio tra l’individuale ed il sociale, scienza che ha sempre interrogato coloro che si confrontavano con la sofferenza psichica, con le sue cause ma anche con i suoi effetti, senza ridurla ad uno sterile catalogo dei sintomi.
Ora io penso che la cultura non sia un inutile insieme di nozioni ma sia la nostra capacità e modalità di interpretare il mondo, sia uno sguardo critico, uno sguardo che trae origine dai nostri aspetti più profondi, dalle nostre relazioni primarie che si trasformano e ci fanno diventare ciò che siamo, uno sguardo che non cede a tentazioni deterministiche perché più semplici o meno dolorose, ma soprattutto non cede alla loro presunta neutralità.

Come eravamo? Un po’ com’era il mondo che ci circondava, e di cui la psichiatria faceva parte, ricco di speranze, di desideri e di utopia, ora diventati ricordi a disposizione di chiunque non si accontenti di risposte standardizzate a quel grande enigma, a quella grande domanda che è il dolore psichico.